
Piazza San Carlo con, sullo sfondo, la Torre Littoria e l'edificio a torre di via XX Settembre. Fotografia di Alessandro Martini, 2012. © MuseoTorino
Anteprima e Stampa
Torino verticale. Torri e "grattacieli" nello skyline cittadino
Pur intervallata da pause e fratture, dal sogno positivista di Alessandro Antonelli per la sua Mole alla proliferazione di torri e veri e propri “grattacieli” dei nostri giorni, la vicenda della Torino “in verticale” si è sviluppata tra Otto e Novecento sulla base di un processo di relativa continuità: in quanto segno eminentemente urbano, l’edificio alto è divenuto la manifestazione, facilmente comprensibile e comunicabile al più vasto pubblico perché immediatamente visibile, del ruolo della città come luogo della modernità. All’edificio sviluppato in verticale è stata quindi attribuita – sin dalle sue origini – una funzione, prima che di massimizzazione dello sfruttamento del suolo, innanzitutto simbolica. Il ruolo “preminente” degli edifici alti è stato così di volta in volta messo in evidenza dalla loro altezza tout court (la Mole, a fine Ottocento), dal loro posizionarsi in un punto della città da sempre parte della «zona di comando» (la Torre Littoria nel periodo fascista), dalle loro dimensioni e dall’esibizione di capacità tecniche (le sedi di grandi imprese private, nell’epoca del capitalismo avanzato, tra gli anni ’50 e ’60), dall’applicazione di tecnologie avanzate a temi altrimenti considerati “poveri” (alcune realizzazioni di residenza sociale tra anni ’70 e ’80).
Tuttavia, così come, a dispetto di una notevole serie di eccezioni, l’edificio pluripiano non ha in effetti assunto un carattere connotante per Torino – come avvenuto, invece, per altre città europee e anche italiane –, allo stesso modo il dibattito sul tema è rimasto relativamente marginale rispetto ad altre discussioni sulla forma e sui destini della città, fino ad essersi prepotentemente riacceso in tempi recenti, in particolare in relazione ai casi dei grattacieli per la Regione Piemonte e per Intesa-Sanpaolo,la cui realizzazione è attualmente in corso. In entrambe queste occasioni altamente rappresentative (la “democratica” sede di un organo di governo politico versus quella di uno dei massimi “poteri forti”, quello economico-finanziario di una grande banca, torinese e mondiale internazionale insieme), significativamente, critici e sostenitori hanno ugualmente ricondotto la discussione al confronto con la storia urbana della città, con le sue linee di sviluppo, con i segni e i simboli della sua identità. Primo fra tutti, ancora una volta, la Mole Antonelliana: tuttora l’edificio più alto di Torino, destinato a rimanere tale anche dopo la conclusione del grattacielo di Renzo Piano per Intesa-Sanpaolo; nel pieno del 150° anniversario dall’avvio del suo cantiere, la Mole è riconosciuta come l’edificio simbolo della città, i cui limiti dimensionali in altezza non pare legittimo superare.
-
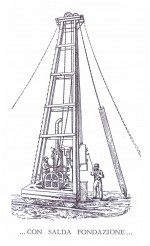
SIAT-Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino
La Società degli Ingegneri e degli Industriali è costituita nel 1866 come luogo di discussione e di confronto tecnico, culturale e scientifico; nel 1886 assume la denominazione di Società degli Ingegneri e degli Architetti. Con il ventennio fascista cessa la sua attività autonoma. Nell’immediato dopoguerra, rifondata come Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, riprende la pubblicazione della rivista «Atti e Rassegna Tecnica».
Vai alla scheda -

Chiesa di Santa Zita, già Madonna del Suffragio
Il beato Faà di Bruno (1825-1888) volle dotare l’Opera Pia di Santa Zita di una cappella ma pensando anche al borgo San Donato, area in forte espansione, costruì una chiesa da aprire ai fedeli del quartiere. Il campanile della chiesa è la terza sommità più alta della città, dopo la Mole Antonelliana e la Torre Littoria.
Vai alla scheda -

Torre per uffici a Collegno
Il piccolo edificio nell'area industriale di Collegno (piazza Maestri del Lavoro d’Italia), appena fuori i confini di Torino, introduce elementi di “urbanità” in un tessuto, quale quello delle aree industriali periurbane, caratterizzato da scarsissimi valori formali e problematiche caratteristiche qualitative.
Vai alla scheda -

Nuova stazione di Porta Susa
La nuova stazione è destinata a diventare il principale scalo ferroviario cittadino e nodo di interconnessione a livello metropolitano.
Vai alla scheda -

Torri «Porta Europa»
Esito della collaborazione tra Studio Camerana e Jan Störmer Partner, l’insieme delle torri “Porta Europa” di corso Lione e corso Mediterraneo rappresenta l’estrema evoluzione di uno dei punti individuati dal Prg del 1995 come snodi lungo l’asse delle Spine e segnati per questo dalla presenza di edifici alti.
Vai alla scheda -

Il Centro direzionale di Torino: il concorso del 1962
Nel 1962 il Comune bandisce un concorso per la progettazione del nuovo centro direzionale della città, a cui partecipano numerosi gruppi di architetti torinesi e nazionali. Previsto nell’area occidentale, non verrà realizzato, ma sollecita il dibattito intorno allo sviluppo verticale dell’edilizia torinese.
Vai alla scheda -

Progetto «Torino possibile»
«Torino possibile» è una proposta che ipotizza un futuro “alla Le Corbusier” per tre aree torinesi, intese come nuovi poli urbani (quartiere Vanchiglia, quartiere Falchera, parco della Pellerina, parco Colonnetti): grandi spazi liberati dalle costruzioni e destinati a verde pubblico e privato, con i nuovi edifici per la residenza e il terziario tutti concentrati in verticale per occupare la minor quantità di suolo.
Vai alla scheda -

Case-torri della Cooperativa di abitazioni Giuseppe Di Vittorio
Le due “doppie torri” residenziali all’imbocco dell’autostrada Torino-Milano rappresentano uno dei non molti esempi di applicazione in ambito torinese di tecnologie costruttive industrializzate (sistema a coffrage tunnel, con l’aggregazione degli elementi strutturali intorno a un nucleo centrale che scandisce effetti di simmetrie modulari senza sacrificare la ricerca di un’espressione formale). Le torri segnano efficacemente l’ingresso nord della città, esercitando un chiaro ruolo di landmark.
Vai alla scheda -

Torri del Quartiere “Falchera Nuova”
Le sedici torri della “Falchera Nuova”, realizzate per mezzo di sistemi di costruzione prefabbricata all’inizio degli anni Settanta, svolgono un efficace ruolo di nuovo margine della città verso la campagna e le infrastrutture, concludendo l’espansione del quartiere.
Vai alla scheda -

Torre Mirafiori
Realizzata tra il 1970 e il 1974, rappresenta la declinazione architettonicamente più interessante, con echi della cultura Pop, del disegno del locale Piano di zona, che comprende, oltre che a quella di Jaretti e Luzi, altre dieci torri di uguale altezza, allineate sulle vie Nichelino e Cercenasco.
Vai alla scheda -

-

Ex centro direzionale RIV
Nel 1955, su progetto di Amedeo Albertini (1916-1982), viene costruito il palazzo per uffici della RIV, attualmente sede delle Assicurazioni Generali.
Vai alla scheda -

Torri Rivella
Due edifici, le cosiddette «zuccheriere», che segnano con il loro linguaggio tardo eclettico e il loro bizzarro profilo lo skyline della parte di città compresa tra i Giardini Reali e il corso della Dora, conferendo gerarchia e struttura alle visuali degli assi dei corsi Regina Margherita e San Maurizio.
Vai alla scheda -

Casa Saiba
Pur realizzato nel 1949, l’edificio (in contiguità con il coevo cinema Reposi), per modalità compositive e di relazioni con il contesto, si configura quasi come un estremo completamento del piano per via Roma Nuova.
Vai alla scheda -

Edificio pluripiano per abitazioni, negozi e uffici
L’edificio, progettato da Gino Salvestrini, rappresenta uno dei casi più emblematici di inserimento postbellico di elementi alti all’interno del tessuto storico.
Vai alla scheda -

Ex sede direzionale Burgo
L’edificio nell’isolato compreso tra via Roma, piazza San Carlo e Galleria San Federico ospita dal 1933 la Direzione centrale e l’Ufficio vendite della Burgo, dopo il trasferimento da Milano. La presenza della società nel cuore della città è segnalata da un’imponente scritta al neon dai caratteri cubitali. La società rimane nello stabile fino al 1940, quando gli uffici sono trasferiti a Palazzo Ceriana in piazza Solferino. Dal 1956 la nuova sede del gruppo è trasferita nel palazzo di Gualtiero Casalegno di corso Matteotti 8; dal 1980 circa a San Mauro.
Vai alla scheda -

Edificio per abitazioni, negozi e uffici in piazza Solferino
L'edificio ottocentesco preesistente fu raso al suolo dai bombardamenti dell'estate 1943. Attualmente sull'area è presente la torre per uffici e residenze di Gualtiero Casalegno (1949), terzo dei grandi interventi nel centro cittadino dei tardi anni Quaranta del Novecento.
Vai alla scheda -

Edificio per appartamenti
Opera di Nello Renacco, al di là della qualità architettonica intrinseca, è edificio emblematico dell’applicazione di una normativa “quantitativa” tipicamente postbellica, indifferente alle qualità formali del tessuto storico urbano.
Vai alla scheda -

Torre CTO
Uno dei landmark della Torino del boom economico, esito della rapida crescita demografica e dell’espansione urbana che tocca il settore sud della città ai confini con Moncalieri e Nichelino.
Vai alla scheda -

Edificio per uffici e abitazioni
Un’opera firmata dai milanesi BBPR che si inserisce nel contesto storico assumendone i caratteri strutturali.
Vai alla scheda -

Grattacielo RAI
Uno dei primi edifici alti a Torino che guarda alle esperienze statunitensi del secondo dopoguerra.
Vai alla scheda -

Grattacielo Lancia
Costruito dall’architetto Nino Rosani a cavallo della via Braccini (già Montenegro) tra il 1954 e il 1957, l’opera è commissionata da Gianni Lancia, figlio di Vincenzo, per concentrare in un unico luogo tutti gli uffici della società. A nord e a sud del grattacielo, sorgevano le officine Lancia. Segna il tessuto urbano, diverso dalle tipologie edilizie del borgo. Acquisito nel 1969 dalla Fiat con tutta la produzione Lancia, nel 2005, privato della sua insegna storica, è venduto e occupato da uffici.
Vai alla scheda -

Albergo Principi di Piemonte
La torre dell’Albergo Principi di Piemonte (tuttora struttura alberghiera di alta categoria, dopo gli interventi per i Giochi Olimpici Invernali del 2006) rappresenta – con la Torre Littoria (ora grattacielo della Reale Mutua Assicurazioni) – il fulcro intorno al quale, a metà degli anni Trenta del Novecento, si organizza la ricostruzione di via Roma Nuova.
Vai alla scheda -

Torre, detta Littoria
Un edificio che segna lo skyline del centro di Torino, in bilico tra razionalismo e stile Novecento, e di cui va segnalata l’innovativa – per l’epoca – struttura portante in acciaio.
Vai alla scheda -

Palazzo sede della Provincia di Torino, già Telecom, Sip e Stipel
Nel cuore dell’area di cantiere della nuova stazione di Porta Susa, l’attuale Palazzo della Provincia di Torino, già Palazzo per uffici Telecom (e prima ancora Sip e Stipel), conferma il ruolo primario nei flussi metropolitani che ha caratterizzato questa porzione di città fin dai tardi anni Cinquanta del Novecento. Già allora, nella prospettiva di trasformazione prevista e di una centralità auspicata all’interno del sistema urbano, era stato commissionato a Ottorino Aloisio l’edificio pluripiano per uffici dalla società Stipel.
Vai alla scheda -

Sede unica Regione Piemonte
Il nuovo grattacielo progettato da Massimiliano Fuksas con AI Studio accorperà uffici della Regione oggi sparsi in diverse zone della città. Dopo una prima collocazione lungo la Spina centrale (concorso del 2001), è attualmente in corso di realizzazione (2011-2015) nell’area ex Fiat Avio.
Vai alla scheda -

Grattacielo Intesa Sanpaolo
Uno dei simboli della città del XXI secolo, oggetto di un acceso dibattito che ha coinvolto larghi strati della cittadinanza, in particolare della politica locale.
Vai alla scheda -

Mole Antonelliana
Progettata nel 1862 dall’ingegnere Alessandro Antonelli, doveva essere la sinagoga torinese, ma dopo i contrasti sorti con la committenza, l’edificio fu portato a termine dal Comune, diventando la sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e dal 2000 quella del Museo Nazionale del Cinema.
Vai alla scheda -

MuseoTorino: facile conoscere. III
MuseoTorino partecipa all’iniziativa Torino verso una città accessibile, programma di eventi promosso dalla Città di Torino, dedicato al tema del patrimonio e dell’accessibilità culturale universale. MuseoTorino è, per sua natura, facilmente accessibile: è liberamente consultabile in rete, sempre, da ogni luogo e mette a disposizione di tutti la conoscenza della città. Nella terza puntata sguardi in giù e in su.
Vai alla scheda
