
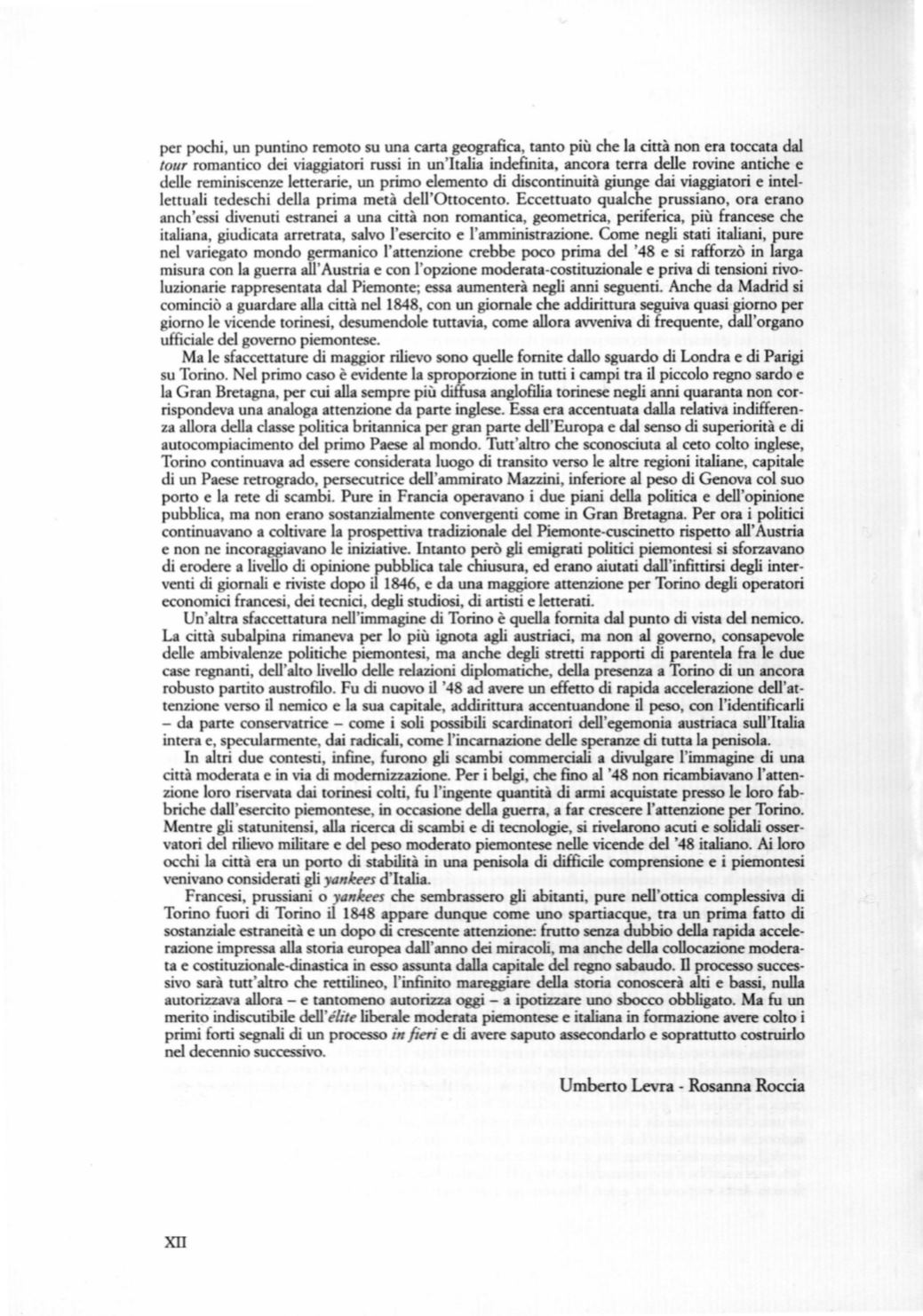
per pochi, un puntino remoto su una carta geografica, tanto più che la città non era toccata dal
tour
romantico dei viaggiatori russi in un'Italia indefinita, ancora terra delle rovine antiche e
delle reminiscenze letterarie, un primo elemento di discontinuità giunge dai viaggiatori e intel–
lettuali tedeschi della prima metà dell'Ottocento. Eccettuato qualche prussiano, ora erano
anch'essi divenuti estranei a una città non romantica, geometrica, periferica, più francese che
italiana, giudicata arretrata, salvo l'esercito e l'amministrazione. Come negli stati italiani, pure
nel variegato mondo germanico l'attenzione crebbe poco prima del '48 e si rafforzò in larga
misura con la guerra all'Austria e con l'opzione moderata-costituzionale e priva di tensioni rivo–
luzionarie rappresentata dal Piemonte; essa aumenterà negli anni seguenti. Anche da Madrid si
cominciò a guardare alla città nel 1848, con un giornale che addirittura seguiva quasi giorno per
giorno le vicende torinesi, desumendole tuttavia, come allora avveniva di frequente, dall'organo
ufficiale del governo piemontese.
Ma le sfaccettature di maggior rilievo sono quelle fornite dallo sguardo di Londra e di Parigi
su Torino. Nel primo caso è evidente la sproporzione in tutti i campi tra il piccolo regno sardo e
la Gran Bretagna, per cui alla sempre più diffusa anglofilia torinese negli anni quaranta non cor–
rispondeva una analoga attenzione da parte inglese. Essa era accentuata dalla relativa indifferen–
za allora della classe politica britannica per gran parte dell'Europa e dal senso di superiorità e di
autocompiacimento del primo Paese al mondo. Tutt'altro che sconosciuta al ceto colto inglese,
Torino continuava ad essere considerata luogo di transito verso le altre regioni italiane, capitale
di un Paese retrogrado, persecutrice dell'ammirato Mazzini, inferiore al peso di Genova col suo
porto e la rete di scambi. Pure in Francia operavano i due piani della politica e dell'opinione
pubblica, ma non erano sostanzialmente convergenti come in Gran Bretagna. Per ora i politici
continuavano a coltivare la prospettiva tradizionale del Piemonte-cuscinetto rispetto all'Austria
e non ne incoraggiavano le iniziative. Intanto però gli emigrati politici piemontesi si sforzavano
di erodere a livello di opinione pubblica tale chiusura, ed erano aiutati dall'infittirsi degli inter–
venti di giornali e riviste dopo il 1846, e da una maggiore attenzione per Torino degli operatori
economici francesi, dei tecnici, degli studiosi, di artisti e letterati.
Un'altra sfaccettatura nell'immagine di Torino è quella fornita dal punto di vista del nemico.
La città subalpina rimaneva per lo più ignota agli austriaci, ma non al governo, consapevole
delle ambivalenze politiche piemontesi, ma anche degli stretti rapporti di parentela fra le due
ca e regnanti, dell'alto livello delle relazioni diplomatiche, della presenza a Torino di un ancora
robu to partito austrofilo. Fu di nuovo il '48 ad avere un effetto di rapida accelerazione dell'at–
tenzione ver o il nemico e la sua capitale, addirittura accentuandone il peso, con !'identificarli
- da parte conservatrice - come i soli possibili scardinatori dell'egemonia austriaca sull'Italia
intera e, pecularmente dai radicali, come l'incarnazione delle speranze di tutta la penisola.
In
altri due conte
ti,
infine, furono gli scambi commerciali a divulgare l'immagine di una
città moderata e in via di modernizzazione. Per i belgi, che fino al '48 non ricambiavano l'atten–
zione lor ri rvata dai torine i colti, fu l'ingente quantità di armi acquistate presso le loro fab–
brich dall esercito piemonte e, in occasione della guerra, a far crescere l'attenzione per Torino.
Mentr gli tatuniten i alla ricerca di scambi e di tecnologie, si rivelarono acuti e solidali osser-
at ri del rili
militare e del pe o moderato piemontese nelle vicende del '48 italiano.
Ai
loro
chi la città era un porto di tabilità in una penisola di difficile comprensione e i piemontesi
eni an c n iderati
gli
yankees
d'Italia.
rane i pru iani o
yankees
eh embrassero gli abitanti, pure nell'ottica complessiva di
T<
rin fu ri di Torino il
1
48 appare dunque come uno spartiacque, tra un prima fatto di
tanziale traneità e un dopo di ere cente attenzione: frutto senza dubbio della rapida accele–
n impr a alla toria europea dall'anno dei miracoli ma anche della collocazione modera-
tituzi nale-dina tica in
o a unta dalla capitale del regno sabaudo. TI processo succes-
ar' tutt altr che r ttilineo l infinito mareggiare della toria conoscerà alti e bassi, nulla
aut rizza allora - tantomeno autorizza o
si -
a ipotizzare uno bocco obbligato. Ma fu un
merit indi utibile dell
élite
liberale m derata piemontese e italiana
in
formazione avere colto i
primi forti gnali di un proc o
in /ieri
e di a ere aputo assecondarlo e soprattutto costruirlo
nel de ennio ucc
i
o.
Umberto Levra - Rosanna Roccia
xn


















