
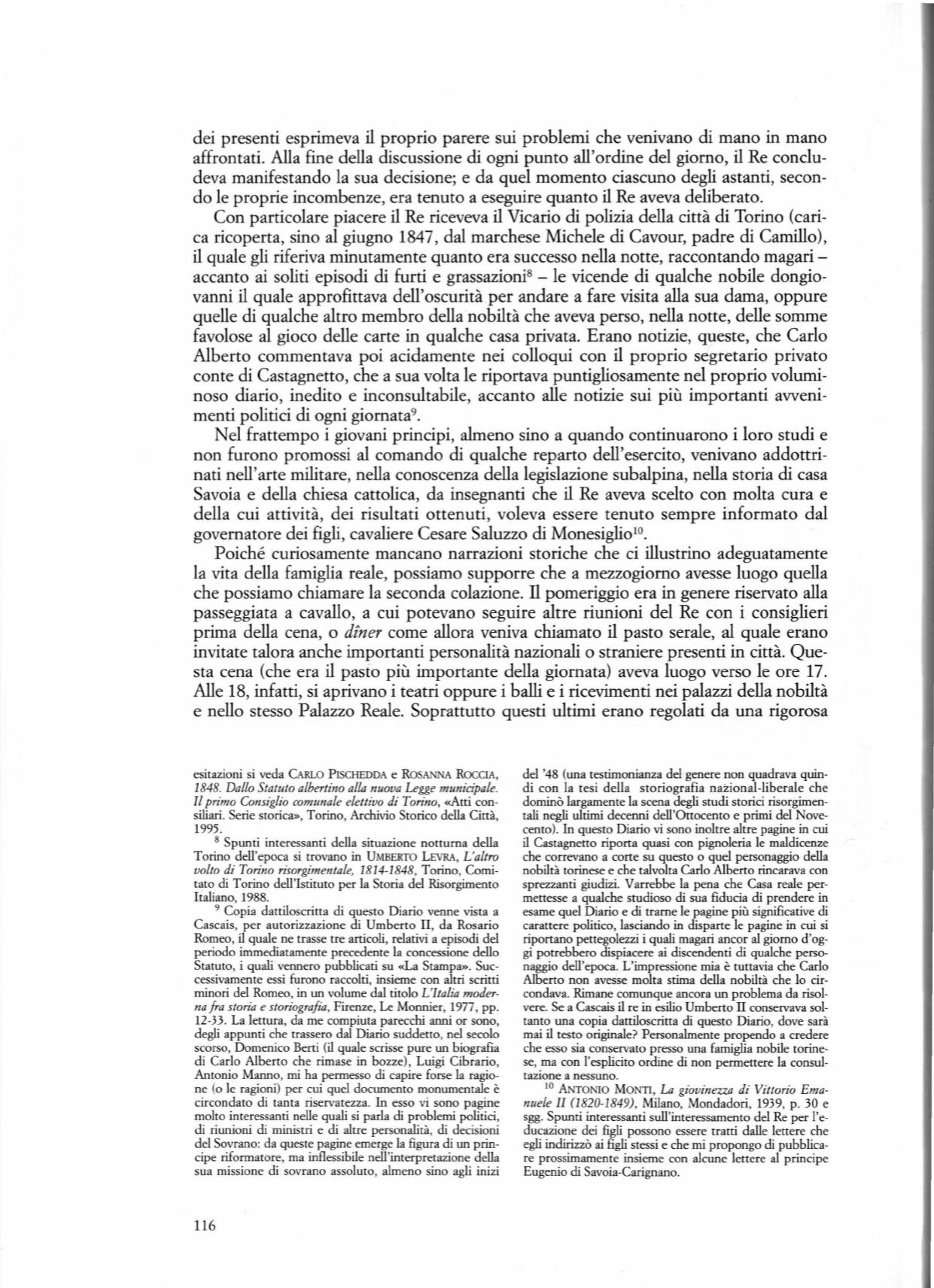
dei presenti esprimeva il proprio parere sui problemi che venivano di mano in mano
affrontati. Alla fine della discussione di ogni punto all'ordine del giorno, il Re conclu–
deva manifestando la sua decisione; e da quel momento ciascuno degli astanti, secon–
do le proprie incombenze, era tenuto a eseguire quanto il Re aveva deliberato.
Con particolare piacere il Re riceveva il Vicario di polizia della città di Torino (cari–
ca ricoperta, sino al giugno 1847, dal marchese Michele di Cavour, padre di Camillo),
il quale gli riferiva minutamente quanto era successo nella notte, raccontando magari -
accanto ai soliti episodi di furti e grassazioni
8 -
le vicende di qualche nobile dongio–
vanni il quale approfittava dell'oscurità per andare a fare visita alla sua dama, oppure
quelle di qualche altro membro della nobiltà che aveva perso, nella notte, delle somme
favolose al gioco delle carte in qualche casa privata. Erano notizie, queste, che Carlo
Alberto commentava poi acidamente nei colloqui con
il
proprio segretario privato
conte di Castagnetto, che a sua volta le riportava puntigliosamente nel proprio volumi–
noso diario, inedito e inconsultabile, accanto alle notizie sui più importanti avveni–
menti politici di ogni giornata
9 .
Nel frattempo i giovani principi, almeno sino a quando continuarono i loro studi e
non furono promossi al comando di qualche reparto dell'esercito, venivano addottri–
nati nell' arte militare, nella conoscenza della legislazione subalpina, nella storia di casa
Savoia e della chiesa cattolica, da insegnanti che il Re aveva scelto con molta cura e
della cui attività, dei risultati ottenuti, voleva essere tenuto sempre informato dal
governatore dei figli, cavaliere Cesare Saluzzo
di
Monesiglio
lO •
Poiché curiosamente mancano narrazioni storiche che ci illustrino adeguatamente
la vita della famiglia reale, possiamo supporre che a mezzogiorno avesse luogo quella
che possiamo chiamare la seconda colazione. TI pomeriggio era in genere riservato alla
passeggiata a cavallo, a cui potevano seguire altre riunioni del Re con i consiglieri
prima della cena, o
diner
come allora veniva chiamato
il
pasto serale, al quale erano
invitate talora anche importanti personalità nazionali o straniere presenti in città. Que–
sta cena (che era
il
pasto più importante della giornata) aveva luogo verso le ore 17.
Alle 18, infatti, si aprivano i teatri oppure i balli e i ricevimenti nei palazzi della nobiltà
e nello stesso Palazzo Reale. Soprattutto questi ultimi erano regolati da una rigorosa
esitazioni si veda CARLO PISCHEDDA e ROSANNA ROCCIA,
1848. Dallo Statuto albertino alla nuova Legge municipale.
Il primo Consiglio comunale elettivo di Torino,
«Atti con–
siliari. Serie storica», Torino, Archivio Storico della Città,
1995.
8
Spunti interessanti della situazione notturna della
Torino dell'epoca si trovano in UMBERTO LEVRA,
L'altro
volto di Torino risorgimentale,
1814-1848, Torino, Comi–
tato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, 1988.
9
Copia dattiloscritta di questo Diario venne vista a
Cascais, per autorizzazione di Umberto II, da Rosario
Romeo, il quale ne trasse tre articoli, relativi a episodi del
periodo immediatamente precedente la concessione dello
Statuto, i quali vennero pubblicati su «La Stampa». Suc–
cessivamente essi furono raccolti, insieme con altri scritti
minori del Romeo, in un volume dal titolo
L'Italia moder–
na fra storia e storiografia,
Firenze, Le Monnier, 1977, pp.
12-33. La lettura, da me compiuta parecchi anni or sono,
degli appunti che trassero dal Diario suddetto, nel secolo
scorso, Domenico Berti (il quale scrisse pure un biografia
di Carlo Alberto che rimase in bozze) , Luigi Cibrario,
Antonio Manno,
mi
ha permesso di capire forse la ragio–
ne (o le ragioni) per cui quel documento monumentale è
circondato di tanta riservatezza. In esso vi sono pagine
molto interessanti nelle quali si parla di problemi politici,
di riunioni di ministri e di altre personalità, di decisioni
del Sovrano: da queste pagine emerge la figura di un prin–
cipe riformatore, ma inflessibile nell'interpretazione della
sua missione di sovrano assoluto, almeno sino agli inizi
116
del '48 (una testimonianza del genere non quadrava quin–
di con la tesi della storiografia nazional-liberale che
dominò largamente la scena degli studi storici risorgimen–
tali negli ultimi decenni dell'Ottocento e primi del Nove–
cento) .
In
questo Diario vi sono inoltre altre pagine in cui
il Castagnetto riporta quasi con pignoleria le maldicenze
che correvano a corte su questo o quel personaggio della
nobiltà torinese e che talvolta Carlo Alberto rincarava con
sprezzanti giudizi. Varrebbe la pena che Casa reale per–
mettesse a qualche studioso di sua fiducia di prendere in
esame quel Diario e di trame le pagine più significative di
carattere politico, lasciando in disparte le pagine in cui si
riportano pettegolezzi i quali magari ancor al giorno d'og–
gi potrebbero dispiacere ai discendenti di qualche perso–
naggio dell'epoca. L'impressione mia è tuttavia che Carlo
Alberto non avesse molta stima della nobiltà che lo cir–
condava. Rimane comunque ancora un problema da risol–
vere. Se a Cascais il re in esilio Umberto II conservava sol–
tanto una copia dattiloscritta di questo Diario, dove sarà
mai il testo originale? Personalmente propendo a credere
che esso sia conservato presso una famiglia nobile torine–
se, ma con l'esplicito ordine di non permettere la consul–
tazione a nessuno.
10
ANTONIO MONTI,
La
giovinezza di Vittorio Ema–
nuele II (1820-1849),
Milano, Mondadori, 1939, p. 30 e
sgg. Spunti interessanti sull'interessamento del Re per l'e–
ducazione dei figli possono essere tratti dalle lettere che
egli indirizzò ai figli stessi e che
mi
propongo di pubblica–
re prossimamente insieme con alcune lettere al principe
Eugenio di Savoia-Carignano.


















