
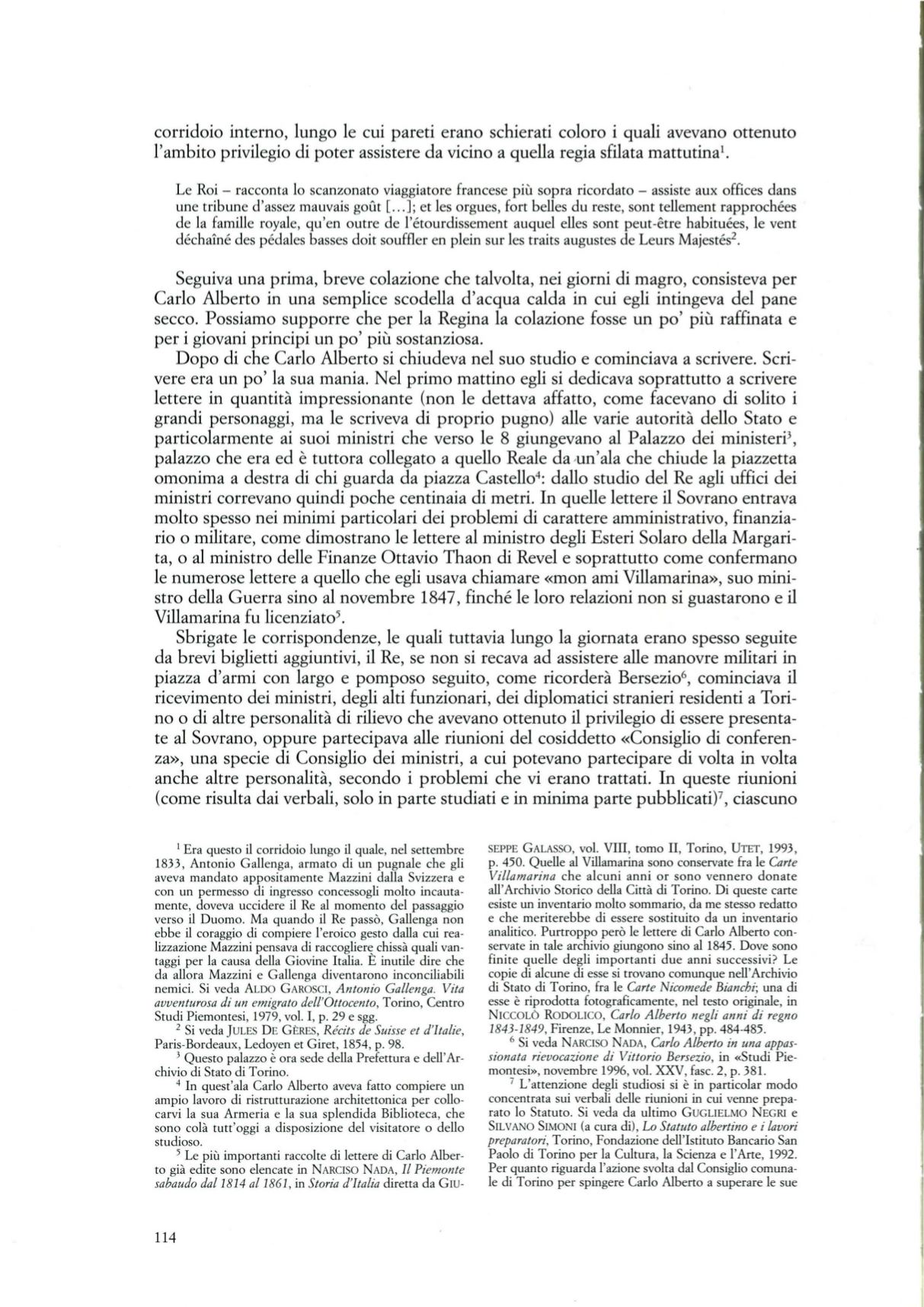
corridoio interno, lungo le cui pareti erano schierati coloro i quali avevano ottenuto
l'ambito privilegio di poter assistere da vicino a quella regia sfilata mattutina
l.
Le Roi - racconta lo scanzonato viaggiatore francese più sopra ricordato - assiste aux offices dans
une tribune d'assez mauvais goGt [.. .]; et les orgues, fort bel1es du reste, sont tel1ement rapprochées
de la famille royale, qu'en outre de l'étourdissement auquel el1es sont peut-etre habituées, le vent
déchainé des pédales basses doit souffler en plein sur les traits augustes de Leurs Majestés
2 .
Seguiva una prima, breve colazione che talvolta, nei giorni di magro, consisteva per
Carlo Alberto in una semplice scodella d'acqua calda in cui egli intingeva del pane
secco. Possiamo supporre che per la Regina la colazione fosse un po' più raffinata e
per i giovani principi un po' più sostanziosa.
Dopo di che Carlo Alberto si chiudeva nel suo studio e cominciava a scrivere. Scri–
vere era un po' la sua mania. Nel primo mattino egli si dedicava soprattutto a scrivere
lettere in quantità impressionante (non le dettava affatto, come facevano di solito i
grandi personaggi, ma le scriveva di proprio pugno) alle varie autorità dello Stato e
particolarmente ai suoi ministri che verso le 8 giungevano al Palazzo dei ministeri
3 ,
palazzo che era ed
è
tuttora collegato a quello Reale da ,un' ala che chiude la piazzetta
omonima a destra di chi guarda da piazza Castell0
4 :
dallo studio del Re agli uffici dei
ministri correvano quindi poche centinaia di metri. In quelle lettere il Sovrano entrava
molto spesso nei minimi particolari dei problemi di carattere amministrativo, finanzia–
rio o militare, come dimostrano le lettere al ministro degli Esteri Solaro della Margari–
ta, o al ministro delle Finanze Ottavio Thaon di Revel e soprattutto come confermano
le numerose lettere a quello che egli usava chiamare «mon ami Villamarina», suo mini–
stro della Guerra sino al novembre 1847, finché le loro relazioni non si guastarono e il
Villamarina fu licenziat0
5 .
Sbrigate le corrispondenze, le quali tuttavia lungo la giornata erano spesso seguite
da brevi biglietti aggiuntivi, il Re, se non si recava ad assistere alle manovre militari in
piazza d'armi con largo e pomposo seguito, come ricorderà Bersezi0
6 ,
cominciava il
ricevimento dei ministri, degli alti funzionari, dei diplomatici stranieri residenti a Tori–
no o di altre personalità di rilievo che avevano ottenuto il privilegio di essere presenta–
te al Sovrano, oppure partecipava alle riunioni del cosiddetto «Consiglio di conferen–
za», una specie di Consiglio dei ministri, a cui potevano partecipare di volta in volta
anche altre personalità, secondo i problemi che vi erano trattati. In queste riunioni
(come risulta dai verbali, solo in parte studiati e in minima parte pubblicati)7, ciascuno
l
Era questo il corridoio lungo il quale, nel settembre
1833, Antonio G allenga, armato di un pugnale che gli
aveva mandato appositamente Mazzini dalla Svizzera e
con un permesso di ingresso concessogli molto incauta–
mente, doveva uccidere il Re al momento del passaggio
verso il Duomo. Ma quando il Re passò, Gallenga non
ebbe il coraggio di compiere l'eroico gesto dalla cui rea–
lizzazione Mazzini pensava di raccogliere chissà quali van–
taggi per la causa della Giovine Italia.
È
inutile dire che
da allora Mazzini e Gallenga diventarono inconciliabili
nemici. Si veda ALDO GAROSCl,
Antonio Gallenga. Vita
avventurosa di un emigrato dell'Ottocento,
Torino, Centro
Studi Piemontesi, 1979, val. I, p. 29 e sgg.
2
Si veda JULES DE GÈRES,
Récits de Suisse et d'ltalie,
Paris-Bordeaux, Ledoyen et Giret, 1854, p. 98.
3
Questo palazzo è ora sede della Prefettura e dell'Ar–
chivio di Stato di Torino.
4
In quest'ala Carlo Alberto aveva fatto compiere un
ampio lavoro di ristrutturazione architettonica per collo–
carvi la sua Armeria e la sua splendida Biblioteca, che
sono colà tutt'oggi a disposizione del visitatore o dello
studioso.
5
Le più importanti raccolte di lettere di Carlo Alber–
to già edite sono elencate in NARCISO NADA,
Il Piemonte
sabaudo dal
1814
al
186 1, in
Storia d'Italia
diretta da GIU-
114
SEPPE GALASSO, val. VIII, tomo II, Torino, UTET, 1993,
p. 450. Quelle al Villamarina sono conservate fra le
Carte
Villamarina
che alcuni anni or sono vennero donate
all'Archivio Storico della Città di Torino. Di queste carte
esiste un inventario molto sommario, da me stesso redatto
e che meriterebbe di essere sostituito da un inventario
analitico. Purtroppo però le lettere di Carlo Alberto con–
servate in tale archivio giungono sino al 1845. Dove sono
finite quelle degli importanti due anni successivi? Le
copie di alcune di esse si trovano comunque nell'Archivio
di Stato di Torino, fra le
Carte Nicomede Bianchi;
una di
esse è riprodotta fotograficamente, nel testo originale, in
NICCOLÒ RODOLlCO,
Carlo A lberto negli anni di regno
1843-1849, Firenze, Le Monnier, 1943, pp. 484-485.
6
Si veda NARCISO NADA,
Carlo Alberto in una appas–
sionata rievocazione di Vittorio Bersezio,
in «Studi Pie–
montesi», novembre 1996, val. XXV, fasc. 2, p. 38l.
7
L'attenzione degli studiosi si è in particolar modo
concentrata sui verbali delle riunioni in cui venne prepa–
rato lo Statuto. Si veda da ultimo GUGLIELMO NEGRI e
SILVANO SlMONI (a cura di) ,
Lo Statuto albertino e
i
lavori
preparatori,
Torino, Fondazione dell'Istituto Bancario San
Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte, 1992.
Per quanto riguarda l'azione svolta dal Consiglio comuna–
le di Torino per spingere Carlo Alberto a superare le sue


















