
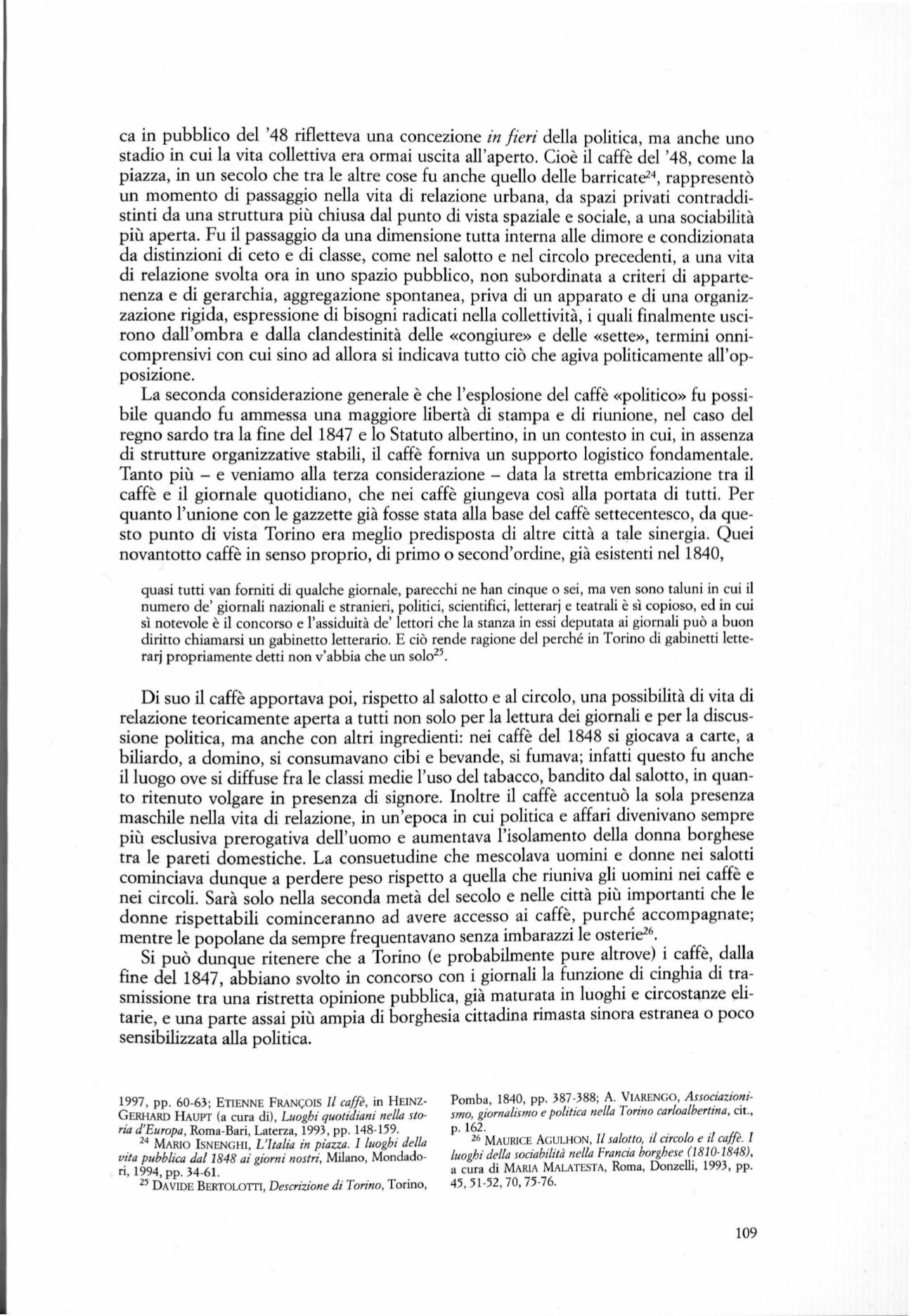
ca in pubblico del '48 rifletteva una concezione
in fieri
della politica, ma anche uno
stadio in cui la vita collettiva era ormai uscita all 'aperto. Cioè il caffè del '48, come la
piazza, in un secolo che tra le altre cose fu anche quello delle barricate24, rappresentò
un momento di passaggio nella vita di relazione urbana, da spazi privati contraddi–
stinti da una struttura più chiusa dal punto di vista spaziale e sociale, a una sociabilità
più aperta. Fu
il
passaggio da una dimensione tutta interna alle dimore e condizionata
da distinzioni di ceto e di classe, come nel salotto e nel circolo precedenti, a una vita
di relazione svolta ora in uno spazio pubblico, non subordinata a criteri di apparte–
nenza e di gerarchia, aggregazione spontanea, priva di un apparato e di una organiz–
zazione rigida, espressione di bisogni radicati nella collettività, i quali finalmente usci–
rono dall' ombra e dalla clandestinità delle «congiure» e delle «sette», termini onni–
co~~rensivi
con cui sino ad allora si indicava tutto ciò che agiva politicamente all'op–
pOSIZIOne.
La seconda considerazione generale è che l'esplosione del caffè «politico» fu possi–
bile quando fu ammessa una maggiore libertà di stampa e di riunione, nel caso del
regno sardo tra la fine del 1847 e lo Statuto albertino, in un contesto in cui, in assenza
di strutture organizzative stabili, il caffè forniva un supporto logistico fondamentale.
Tanto più - e veniamo alla terza considerazione - data la stretta embricazione tra il
caffè e il giornale quotidiano, che nei caffè giungeva così alla portata di tutti. Per
quanto l'unione con le gazzette già fosse stata alla base del caffè settecentesco, da que–
sto punto di vista Torino era meglio predisposta di altre città a tale sinergia. Quei
novantotto caffè in senso proprio, di primo o second'ordine, già esistenti nel 1840,
quasi tutti van forniti di qualche giornale, parecchi ne han cinque o sei, ma ven sono taluni in cui
il
numero de' giornali nazionali e stranieri, politici, scientifici, letterarj e teatrali
è
sÌ copioso, ed in cui
sÌ notevole
è
il
concorso e l'assiduità de' lettori che la stanza in essi deputata ai giornali può a buon
diritto chiamarsi un gabinetto letterario. E ciò rende ragione del perché in Torino di gabinetti lette–
rarj propriamente detti non v'abbia che un sol025.
Di suo il caffè apportava poi, rispetto al salotto e al circolo, una possibilità di vita di
relazione teoricamente aperta a tutti non solo per la lettura dei giornali e per la discus–
sione politica, ma anche con altri ingredienti: nei caffè del 1848 si giocava a carte, a
biliardo, a domino, si consumavano cibi e bevande, si fumava; infatti questo fu anche
il luogo ove si diffuse fra le classi medie l'uso del tabacco, bandito dal salotto, in quan–
to ritenuto volgare in presenza di signore. Inoltre il caffè accentuò la sola presenza
maschile nella vita di relazione, in un'epoca in cui politica e affari divenivano sempre
più esclusiva prerogativa dell'uomo e aumentava l'isolamento della donna borghese
tra le pareti domestiche. La consuetudine che mescolava uomini e donne nei salotti
cominciava dunque a perdere peso rispetto a quella che riuniva gli uomini nei caffè e
nei circoli. Sarà solo nella seconda metà del secolo e nelle città più importanti che le
donne rispettabili cominceranno ad avere accesso ai caffè, purché accompagnate;
mentre le popolane da sempre frequentavano senza imbarazzi le osterie2
6
.
Si può dunque ritenere che a Torino (e probabilmente pure altrove) i caffè, dalla
fine del 1847, abbiano svolto in concorso con i giornali la funzione di cinghia di tra–
smissione tra una ristretta opinione pubblica, già maturata in luoghi e circostanze eli–
tarie, e una parte assai più ampia di borghesia cittadina rimasta sinora estranea o poco
sensibilizzata alla politica.
1997, pp. 60-63; ETIENNE FRANçOIS
Il caffè,
in
HEINZ–
GERHARD
HAUPT (a cura di),
Luoghi quotidiani nella sto–
ria d'Europa,
Roma-Bari, Laterza,
1993 , pp. 148-159.
24
MARIO ISNENGHI,
L'Italia in piazza. I luoghi della
vita pubblica dal
1848
ai giorni nostri,
Milano, Mondado–
ri,
1994, pp. 34-61.
25
DAVIDE BERTOLOTII,
Descrizione di Torino,
Torino,
Pomba,
1840, pp. 387-388;
A. VIARENGO,
Associazioni–
smo, giornalismo e politica nella Torino carloalbertina,
cit.,
p.162.
26
MAURJCE AGULHON,
Il salotto, il circolo e il caffè. I
luoghi della sociabilità nella Francia borghese (1810-1848),
a cura di MARJA MALATESTA, Roma, Donzelli,
1993 , pp.
45, 51-52,70,75-76.
109


















