
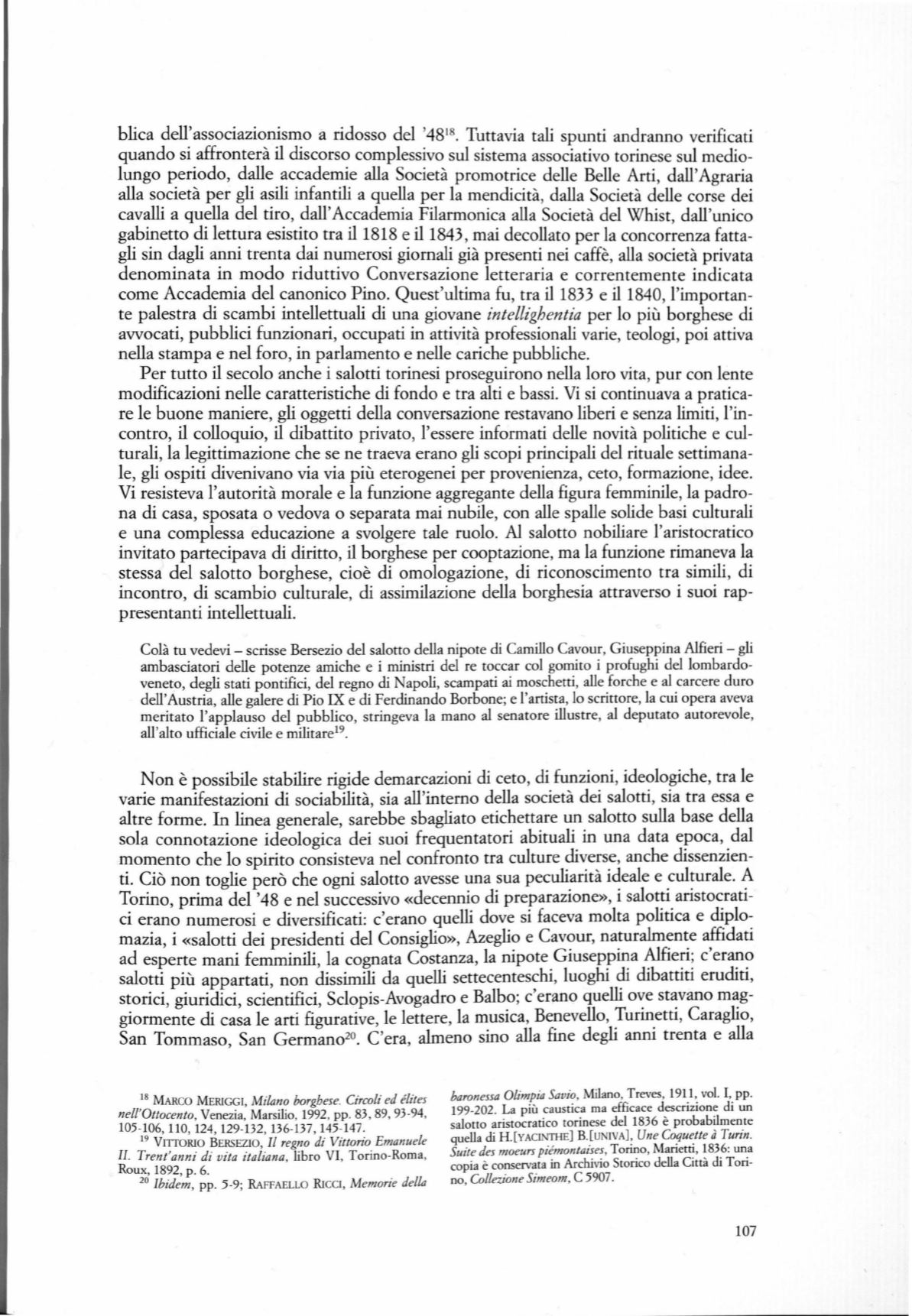
blica dell'associazionismo a ridosso del '48
18 •
Tuttavia tali spunti andranno verificati
quando si affronterà il discorso complessivo sul sistema associativo torinese sul medio–
lungo periodo, dalle accademie alla Società promotrice delle Belle Arti, dall 'Agraria
alla società per gli asili infantili a quella per la mendicità, dalla Società delle corse dei
cavalli a quella del tiro, dall'Accademia Filarmonica alla Società del Whist, dall'unico
gabinetto di lettura esistito tra il 1818 e il 1843 , mai decollato per la concorrenza fatta–
gli sin dagli anni trenta dai numerosi giornali già presenti nei caffè, alla società privata
denominata in modo riduttivo Conversazione letteraria e correntemente indicata
come Accademia del canonico Pino. Quest'ultima fu, tra
il
1833 e il 1840, l'importan–
te palestra di scambi intellettuali di una giovane
intellighentia
per lo più borghese di
avvocati, pubblici funzionari, occupati in attività professionali varie, teologi, poi attiva
nella stampa e nel foro, in parlamento e nelle cariche pubbliche.
Per tutto il secolo anche i salotti torinesi proseguirono nella loro vita, pur con lente
modificazioni nelle caratteristiche di fondo e tra alti e bassi. Vi si continuava a pratica–
re le buone maniere, gli oggetti della conversazione restavano liberi e senza limiti, l'in–
contro, il colloquio, il dibattito privato, l'essere informati delle novità politiche e cul–
turali, la legittimazione che se ne traeva erano gli scopi principali del rituale settimana–
le, gli ospiti divenivano via via più eterogenei per provenienza, ceto, formazione, idee.
Vi resisteva l'autorità morale e la funzione aggregante della figura femminile, la padro–
na di casa, sposata o vedova o separata mai nubile, con alle spalle solide basi culturali
e una complessa educazione a svolgere tale ruolo. Al salotto nobiliare l'aristocratico
invitato partecipava di diritto, il borghese per cooptazione, ma la funzione rimaneva la
stessa del salotto borghese, cioè di omologazione, di riconoscimento tra simili, di
incontro, di scambio culturale, di assimilazione della borghesia attraverso i suoi rap–
presentanti intellettuali.
Colà tu vedevi - scrisse Bersezio del salotto della nipote di Camillo Cavour, Giuseppina Alfieri - gli
ambasciatori delle potenze amiche e i ministri del re toccar col gomito i profughi del lombardo–
veneto, degli stati pontifici, del regno di Napoli, scampati ai moschetti, alle forche e al carcere duro
dell'Austria, alle galere di Pio IX e di Ferdinando Borbone; e l'artista, lo scrittore, la cui opera aveva
meritato l'applauso del pubblico, stringeva la mano al senatore illustre, al deputato autorevole,
all'alto ufficiale civile e militare
l9 .
Non è possibile stabilire rigide demarcazioni di ceto, di funzioni, ideologiche, tra le
varie manifestazioni di sociabilità, sia all'interno della società dei salotti, sia tra essa e
altre forme. In linea generale, sarebbe sbagliato etichettare un salotto sulla base della
sola connotazione ideologica dei suoi frequentatori abituali in una data epoca, dal
momento che lo spirito consisteva nel confronto tra culture diverse, anche dissenzien–
ti. Ciò non toglie però che ogni salotto avesse una sua peculiarità ideale e culturale. A
Torino, prima del '48 e nel successivo «decennio di preparazione», i salotti aristocrati–
ci erano numerosi e diversificati: c'erano quelli dove si faceva molta politica e diplo–
mazia, i «salotti dei presidenti del Consiglio», Azeglio e Cavour, naturalmente affidati
ad esperte mani femminili, la cognata Costanza, la nipote Giuseppina Alfieri; c'erano
salotti più appartati, non dissimili da quelli settecenteschi, luoghi ?i dibattiti eruditi,
storici, giuridici, scientifici, Sclopis-Avogadro e Balbo; c'erano quelli
o~e st~vano m~g
giormente di casa le arti figurative, le lettere, la musica, Benevello, Turmett!, Caraglio,
San Tommaso, San German0
20 •
C'era, almeno sino alla fine degli anni trenta e alla
18 MARCO MERIGGI,
Milano borghese. Circoli ed élites
nell'Ottocento,
Venezia, Marsilio, 1992, pp. 83, 89, 93-94,
105-106, 1l0, 124, 129-132, 136-137, 145-147.
19
VITIORIO BERSEZIO,
Il regno di Vittorio Emanuele
II.
Trent 'anni di vita italiana ,
libro VI, Torino-Roma,
Roux, 1892, p. 6.
20
Ibidem,
pp. 5-9;
RAFFAELLO
RICCI,
Memorie della
baronessa Olimpia Savio,
Milano, Treves, 1911, voI. I, pp.
199-202. La più caustica ma efficace descrizione di un
salotto aristocratico torinese del 1836 è probabilmente
quella di
H.[YACINTHEl B.[UNfVAl,
Une Coquette
à
Turin.
Suite des moeurs piémontaises,
Torino, Marietti, 1836: una
copia è conservata in Archivio Storico della Città di Tori–
no,
Collezione Simeom,
C 5907.
107


















