
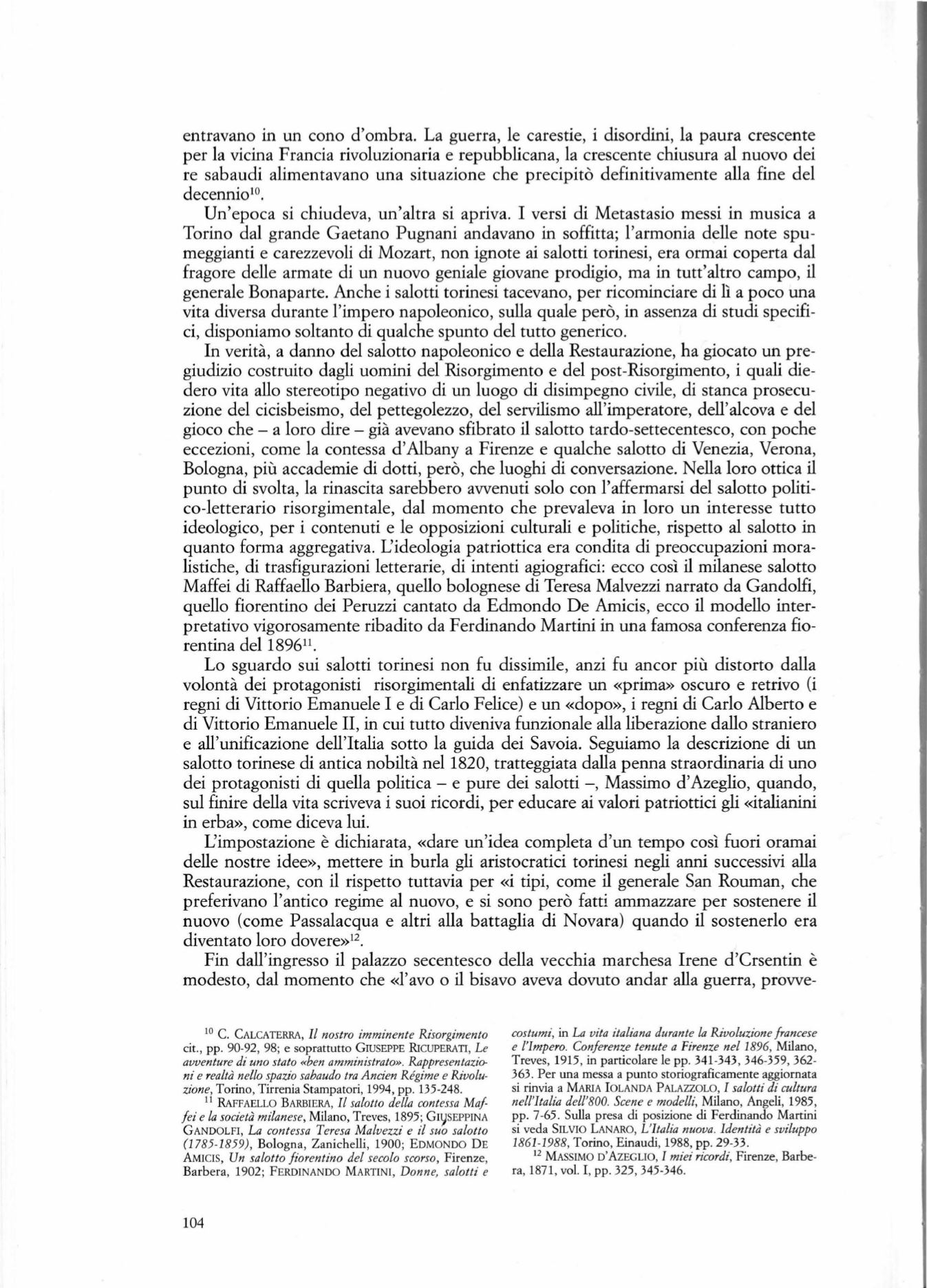
entravano in un cono d'ombra. La guerra, le carestie, i disordini, la paura crescente
per la vicina Francia rivoluzionaria e repubblicana, la crescente chiusura al nuovo dei
re sabaudi alimentavano una situazione che precipitò definitivamente alla fine del
decennio
lO.
Un'epoca si chiudeva, un'altra si apriva. I versi di Metastasio messi in musica a
Torino dal grande Gaetano Pugnani andavano in soffitta; l'armonia delle note spu–
meggianti e carezzevoli di Mozart, non ignote ai salotti torinesi, era ormai coperta dal
fragore delle armate di un nuovo geniale giovane prodigio, ma in tutt' altro campo, il
generale Bonaparte. Anche i salotti torinesi tacevano, per ricominciare di
lì
a poco una
vita diversa durante l'impero napoleonico, sulla quale però, in assenza di studi specifi–
ci, disponiamo soltanto di qualche spunto del tutto generico.
In verità, a danno del salotto napoleonico e della Restaurazione, ha giocato un pre–
giudizio costruito dagli uomini del Risorgimento e del post-Risorgimento, i quali die–
dero vita allo stereotipo negativo di un luogo di disimpegno civile, di stanca prosecu–
zione del cicisbeismo, del pettegolezzo, del servilismo all'imperatore, dell' alcova e del
gioco che - a loro dire - già avevano sfibrato il salotto tardo-settecentesco, con poche
eccezioni, come la contessa d'Albany a Firenze e qualche salotto di Venezia, Verona,
Bologna, più accademie di dotti, però, che luoghi di conversazione. Nella loro ottica il
punto di svolta, la rinascita sarebbero avvenuti solo con 1'affermarsi del salotto politi–
co-letterario risorgimentale, dal momento che prevaleva in loro un interesse tutto
ideologico, per i contenuti e le opposizioni culturali e politiche, rispetto al salotto in
quanto forma aggregativa. L'ideologia patriottica era condita di preoccupazioni mora–
listiche, di trasfigurazioni letterarie, di intenti agiografici: ecco così il milanese salotto
Maffei di Raffaello Barbiera, quello bolognese di Teresa Malvezzi narrato da Gandolfi,
quello fiorentino dei Peruzzi cantato da Edmondo De Amicis, ecco il modello inter–
pretativo vigorosamente ribadito da Ferdinando Martini in una famosa conferenza fio–
rentina del 1896
11
•
Lo sguardo sui salotti torinesi non fu dissimile, anzi fu ancor più distorto dalla
volontà dei protagonisti risorgimentali di enfatizzare un «prima» oscuro e retrivo (i
regni di Vittorio Emanuele I e di Carlo Felice) e un «dopo», i regni di Carlo Alberto e
di Vittorio Emanuele II, in cui tutto diveniva funzionale alla liberazione dallo straniero
e all'unificazione dell'Italia sotto la guida dei Savoia. Seguiamo la descrizione di un
salotto torinese di antica nobiltà nel 1820, tratteggiata dalla penna straordinaria di uno
dei protagonisti di quella politica - e pure dei salotti -, Massimo d'Azeglio, quando,
sul finire della vita scriveva i suoi ricordi, per educare ai valori patriottici gli «italianini
in erba», come diceva lui.
L'impostazione è dichiarata, «dare un'idea completa d'un tempo così fuori oramai
delle nostre idee», mettere in burla gli aristocratici torinesi negli anni successivi alla
Restaurazione, con il rispetto tuttavia per «i tipi, come il generale San Rouman, che
preferivano l'antico regime al nuovo, e si sono però fatti ammazzare per sostenere il
nuovo (come Passalacqua e altri alla battaglia di Novara) quando il sostenerlo era
diventato loro dovere»12.
Fin dall'ingresso il palazzo secentesco della vecchia marchesa Irene d'Crsentin è
modesto, dal momento che «l'avo o il bisavo aveva dovuto andar alla guerra, provve-
lO
C.
CALCATERRA,
Il nostro imminente Risorgimento
cit., pp. 90-92, 98; e soprattutto GIUSEPPE RICUPERATI,
Le
avventure di uno stato «ben amministrato». Rappresentazio–
ni e realtà nello spazio sabaudo tra Ancien Régime e Rivolu–
zione,
Torino, Tirrenia Stampatori, 1994, pp. 135-248.
11
RAFFAELLO BARBIERA,
Il salotto della contessa Ma!
fei e la società milanese,
Milano, Treves, 1895; GIySEPPINA
G ANDOLFI,
La contessa Teresa Malvezzi e
il
suo salotto
(1785-1859), Bologna, Zanichelli, 1900; EDMONDO DE
AMICIS,
Un salotto fiorentino del secolo scorso,
Firenze,
Barbera, 1902; FERDINANDO MARTlN I,
Donne, salotti e
104
costumi,
in
La
vita italiana durante la Rivoluzione francese
e l'Impero. Conferenze tenute a Firenze nel
1896, Milano,
Treves, 1915, in particolare le pp. 341 -343, 346-359, 362-
363. Per una messa a punto storiograficamente aggiornata
si rinvia a MARIA IOLANDA PALAZZOLO,
I salotti di cultura
nell'Italia dell'800. Scene e modelli,
Milano, Angeli, 1985,
pp. 7-65. Sulla presa di posizione di Ferdinando Martini
si veda SILVIO LANARO,
L'Italia nuova. Identità e sviluppo
1861-1988, Torino, Einaudi, 1988, pp. 29-33.
12
MASSIMO D'AZEGLIO,
I miei ricordi,
Firenze, Barbe–
ra, 1871 , voI. I, pp. 325, 345 -346.


















