
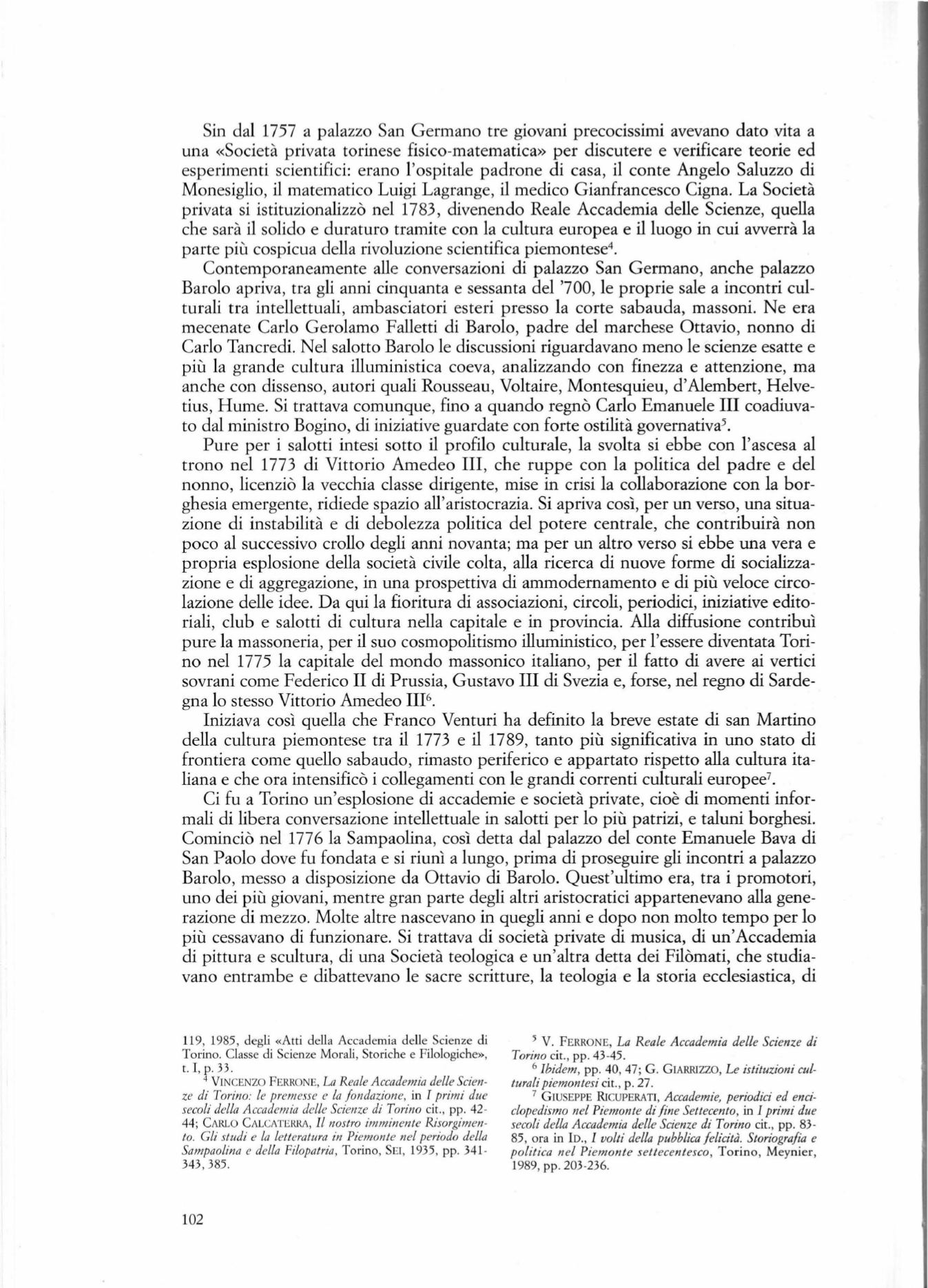
Sin dal 1757 a palazzo San Germano tre giovani precocissimi avevano dato vita a
una «Società privata torinese fisico-matematica» per discutere e verificare teorie ed
esperimenti scientifici: erano 1'ospitale padrone di casa, il conte Angelo Saluzzo di
Monesiglio, il matematico Luigi Lagrange, il medico Gianfrancesco Cigna. La Società
privata si istituzionalizzò nel 1783, divenendo Reale Accademia delle Scienze, quella
che sarà il solido e duraturo tramite con la cultura europea e il luogo in cui avverrà la
parte più cospicua della rivoluzione scientifica piemontese
4 •
Contemporaneamente alle conversazioni di palazzo San Germano, anche palazzo
Barolo apriva, tra gli anni cinquanta e sessanta del '700, le proprie sale a incontri cul–
turali tra intellettuali, ambasciatori esteri presso la corte sabauda, massoni. Ne era
mecenate Carlo Gerolamo Falletti di Barolo, padre del marchese Ottavio, nonno di
Carlo Tancredi. Nel salotto Barolo le discussioni riguardavano meno le scienze esatte e
più la grande cultura illuministica coeva, analizzando con finezza e attenzione, ma
anche con dissenso, autori quali Rousseau, Voltaire, Montesquieu, d'Alembert, Helve–
tius, Hume. Si trattava comunque, fino a quando regnò Carlo Emanuele
III
coadiuva–
to dal ministro Bogino, di iniziative guardate con forte ostilità governativa
5 .
Pure per i salotti intesi sotto il profilo culturale, la svolta si ebbe con l'ascesa al
trono nel 1773 di Vittorio Amedeo III, che ruppe con la politica del padre e del
nonno, licenziò la vecchia classe dirigente, mise in crisi la collaborazione con la bor–
ghesia emergente, ridiede spazio all' aristocrazia. Si apriva così, per un verso, una situa–
zione di instabilità e di debolezza politica del potere centrale, che contribuirà non
poco al successivo crollo degli anni novanta; ma per un altro verso si ebbe una vera e
propria esplosione della società civile colta, alla ricerca di nuove forme di socializza–
zione e di aggregazione, in una prospettiva di ammodernamento e di più veloce circo–
lazione delle idee. Da qui la fioritura di associazioni, circoli, periodici, iniziative edito–
riali, club e salotti di cultura nella capitale e in provincia. Alla diffusione contribuì
pure la massoneria, per il suo cosmopolitismo illuministico, per l'essere diventata Tori–
no nel
1775
la capitale del mondo massonico italiano, per il fatto di avere ai vertici
sovrani come Federico II di Prussia, Gustavo
III
di Svezia e, forse, nel regno di Sarde–
gna lo stesso Vittorio Amedeo III6.
Iniziava cosÌ quella che Franco Venturi ha definito la breve estate di san Martino
della cultura piemontese tra il
1773
e il
1789,
tanto più significativa in uno stato di
frontiera come quello sabaudo, rimasto periferico e appartato rispetto alla cultura ita–
liana e che ora intensificò i collegamenti con le grandi correnti culturali europee.
Ci fu a Torino un 'esplosione di accademie e società private, cioè di momenti infor–
mali di libera conversazione intellettuale in salotti per lo più patrizi, e taluni borghesi.
Cominciò nel
1776
la Sampaolina, così detta dal palazzo del conte Emanuele Bava di
San Paolo dove fu fondata e si riunì a lungo, prima di proseguire gli incontri a palazzo
Barolo, messo a disposizione da Ottavio di Barolo. Quest'ultimo era, tra i promotori,
uno dei più giovani, mentre gran parte degli altri aristocratici appartenevano alla gene–
razione di mezzo. Molte altre nascevano in quegli anni e dopo non molto tempo per lo
più cessavano di funzionare. Si trattava di società private di musica, di un'Accademia
di pittura e scultura, di una Società teologica e un'altra detta dei Filòmati, che studia–
vano entrambe e dibattevano le sacre scritture, la teologia e la storia ecclesiastica, di
119, 1985,
degli «Atti della Accademia delle Scienze di
Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche»,
t.
I,
p.
33.
4
VINCENZO FERRONE,
La Reale Accademia delle Scien–
ze di Torino: le premesse e la fondazione,
in
J
primi due
secoli della A ccademia delle Scienze di Torino
cit. ,
pp. 42-
44; CARLO CALCATERRA,
Il nostro imminente Risorgimen–
to. Gli studi e la letteratura in Piemonte nel periodo della
Sampaolina e della Filopatria ,
Torino, SEI,
1935, pp. 341-
343,385.
102
5
V. FERRONE,
La Reale Accademia delle Scienze di
Torino
cit., pp.
43-45.
6
Ibidem,
pp.
40, 47; G . GlARRIZZO,
Le istituzioni cul–
turali piemontesi
cit. , p.
27.
7
GIUSEPPE RICUPERATI,
Accademie, periodici ed enci–
clopedismo nel Piemonte di fine Settecento,
in
I primi due
secoli della Accademia delle Scienze di Torino
cit.,
pp.
83-
85,
ora
in
lo.,
I volti della pubblica felicità. Storiografia e
politica nel Piemonte settecentesco,
Torino, Meynier,
1989,
pp.
203-236.


















