
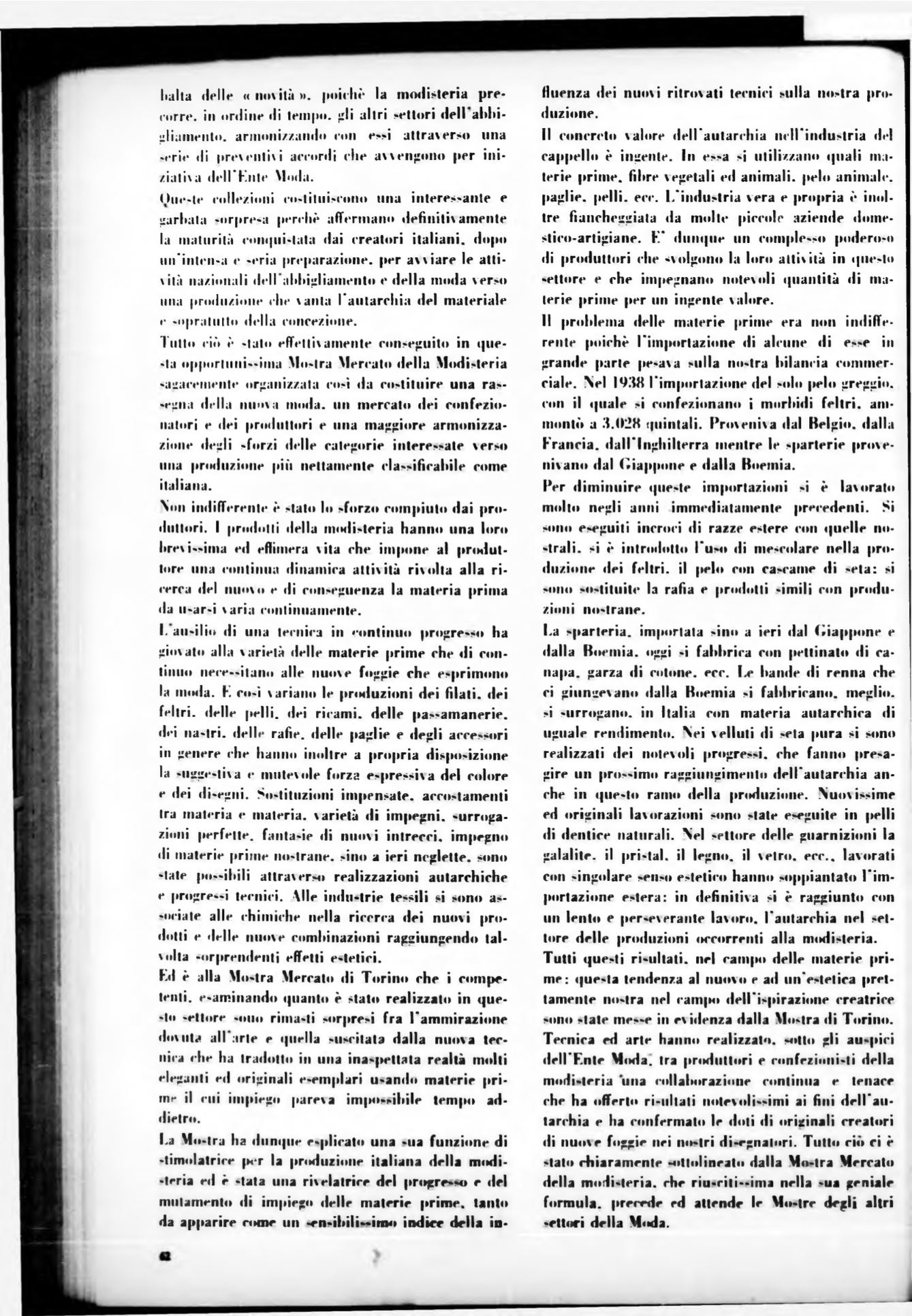
Italia delle « n o v ità » . poiché la modisteria pre
corre. in ordine di tempo, gli altri settori dell abbi
gliamento. armonizzando con essi attraverso una
«cri** di |ire\enti\i accordi che avvengono per in i
ziativa dell*Knte Moda.
Ouc-tc collezioni co»tituiscono una interessante e
garbata «orpre«a perchè affermano definitivamente
la maturità conquistata dai creatori ita lian i, dopo
im'inten-a e «cria preparazione, per avviare le atti
vità nazionali dell abbigliamento e della moda verso
una produzione che vanta l'au tarch ia del materiale
e -opratulto della concezione.
Tutto ciò è «tato effettivamente conseguito in que
sta opportuni—ima Mostra Mercato della Modisteria
sagacemente organizzata cosi da costituire una ras
segna della nuova moda, un mercato dei confezio
natori e dei produttori e una maggiore armonizza
zione degli sforzi delle categorie interessate verso
una produzione più nettamente classificabile come
italiana.
Non indifferente è stato lo sforzo compiuto dai pro
duttori. I prodotti della modisteria hanno una lori»
brevissima ed effimera vita che impone al produt
tore una continua dinamica attività rivo lta a lla r i
cerca del nuovo e di conseguenza la materia prima
da u«ar«i varia continuamente.
I. au«ilio di una tecnica in continuo progresso ha
giovato alla varietà delle materie prime che «li con
tinuo necessitano alle nuove foggie che esprimono
la moda, h co-i variano le produzioni dei filati, dei
feltri, delle pelli, dei ricami, delle passamanerie,
dei n a 'tri. delle rafie, delle paglie e degli accessori
in genere che hanno inoltre a propria disposizione
la suggestiva e mutevole forza espressiva del colore
e dei disegni. Sostituzioni impensate, accostamenti
Ira materia e materia, varietà di impegni, surroga
zioni perfette, fantasie di nuovi intrecci, impegno
di materie prime nostrane, sino a ieri neglette, sono
‘ tate possibili attraverso realizzazioni autarchiche
e progressi tecnici. M ie industrie tessili si sono as
sociate alle chimiche nella ricerca dei nuovi pro
dotti e (Ielle nuove combinazioni raggiungendo ta l
volta sorprendenti effetti estetici.
L«l è alla Mostra Mercato di To rino che i compe
tenti. esaminando «pianto è stato realizzato in que
sto se tto re .«tuo
rimasti sorpresi fra l'amm irazione
dovuta all arte e quella suscitata dalla nuova tec
nica che ha tradotto iti una inaspettata realtà molti
eleganti ed «triginali esemplari usando materie p r i
me
il cui impieg«t pareva impossibile tempo ad-
dietro.
La Mo-tra ha dunque esplicai** una »ua funzione di
•limolatrice per la pr«»duzione italiana della modi-
•teria ed è -tata una rivelatrice del progresso e del
mutamento di impiego delle materie prime, tanto
da apparire n»me un •ensihili—imo indice della in
fluenza dei nu«»vi ritrovati tecnici sulla nostra prò-
duzione.
Il concreto vahtre dell'autarch ia ne ll'industria del
cappello è ingente. In essa si utilizzano «piali ma
terie prime, fibre vegetali ed animali, pebt animale,
paglie, pelli. ecc. L 'indu s tria vera e propria è inol
tre fiancheggiata da mtdte piccole aziende dome
stico-artigiane. K* dunque un complesso ptideroso
di produtt«iri che svidgono la loro attività in «piesto
settore e che impegnano notevoli «piantità di ma
terie prime per un ingente valore.
Il pmhlema delle materie prime era non indiffe
rente pttichè l'importazione di alcune di esse in
grande parte pesava sulla nostra bilancia commer
ciale. Nel 1938 l'importazione «lei solo pelo greggio,
con il «piale si confezionano i morbidi fe ltri, ani-
umntò a 3.028 quintali. Proven iva «lai Be lg io , dalla
Franc ia . da lITngh ilterra mentre le sparterie prove
nivano dal G iappone e dalla Boemia.
Per d im inu ire queste importazioni si è lavorato
m«dt«i negli anni immediatamente preludenti. Si
sono eseguiti incroci di razze estere con «pielle no
strali. si è introdotto l'uso di mescolare nella prò-
duzione dei fe ltri, il pelo c«m cascame di seta: si
sono sostituite la rafia e prodotti simili con produ-
zioni nostrane.
La sparteria. importata sino a ieri dal G iappone e
dalla Boem ia. oggi si fabbrica con pettinato di ca
napa. garza di cotone, ecc. Le bande di renna che
ci giungevano dalla Boem ia si fabbricami, meglio,
si surrogano. in Italia con materia autarchica di
uguale rendimento. Nei ve lluti di seta pura si sono
realizzati dei notevoli progressi. che fanno presa
gire un prossimo raggiungimento de ll'au tan 'h ia an
che in questo ramo della produzi«me. Nuovissime
ed orig ina li lavorazioni sono state eseguite in pelli
di dentice naturali. Nel settore delle guarnizioni la
galalite, il p ri'ta l. il legno, il vetro, ecc.. lavorati
c«»n singolare seiis«i estetico hanno soppiantato l'im-
p«irtazi«me estera: in definitiva si è raggiunto con
un lento e perseverante lavoro, l'autarch ia nel set
tore delle produzioni occorrenti alla nmdisteria.
Tutti questi risultati, nel rampo delle materie p ri
me: <|uesta tendenza al nuovo e ad un'estetica pret
tamente nostra nel campo dell'ispirazione creatrice
sono state mes>e in evidenza dalla Mostra di Torino .
Tecnica ed arte hanno realizzato, sotto gli auspici
dell’ F.nte Moda, tra produttivi e confezionisti della
m<»dis|eria una collab«»razioiie continua e tenace
che ha offerti* ri-ultati notevolissimi ai fini d e ll'a u
tarchia e ha confermato le doti di originali creatori
di nuove foggi*» nei nostri disegnatori. Tutto rio ci è
stato chiaramente sottolineato dalla Mostra Mercato
della modisteria, che riuscitissima nella «uà geniale
formula. precede ed attende Ir Mo»tre degli a ltri
•ettori della Moda.


















