
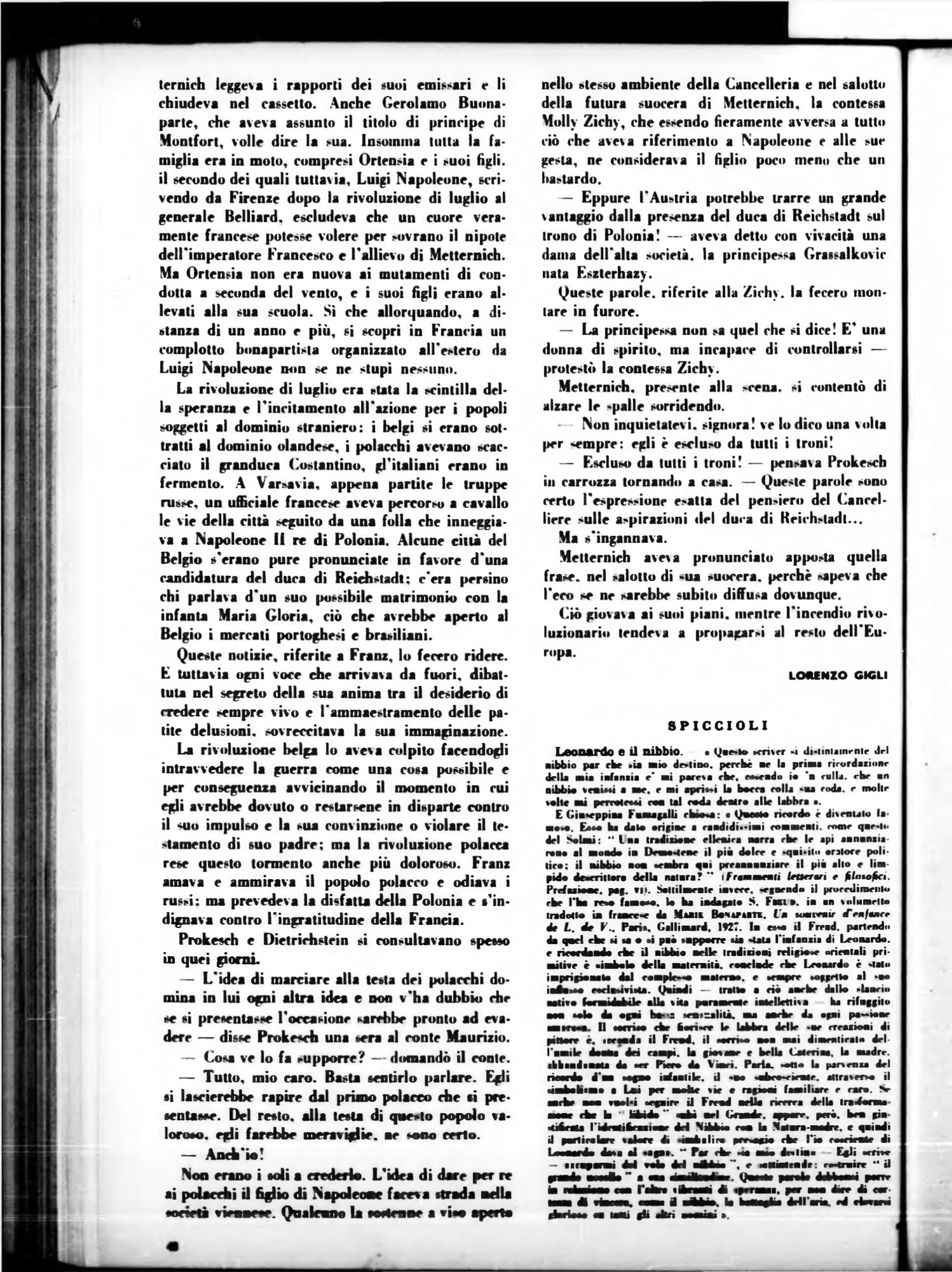
ternich leggeva i rapporti dei suoi emissari e li
chiudeva nel cassetto. Anche Gerolamo Buona-
parte, che aveva assunto il titolo di principe di
Montfort, volle dire la sua. Insoinina tutta la fa
miglia era in moto, compresi Ortensia e i suoi figli,
il secondo dei quali tuttavia, Luigi Napoleone, scri
vendo da Firenze dopo la rivoluzione di luglio al
generale Belliard, escludeva che un cuore vera
mente francese potesse volere per covrano il nipote
delPimperatore Francesco e l'allievo di Metternich.
Ma Ortensia non era nuova ai mutamenti di con
dotta a seconda del vento, e i suoi figli erano al
levati alla sua scuola. Si che allorquando, a di
stanza di un anno e più, si scoprì in Francia un
complotto bonapartista organizzato all'estero da
Luigi Napoleone non se ne stupì nessuno.
La rivoluzione di luglio era ctata la scintilla del
la speranza e l'incitamento all'azione per i popoli
soggetti al dominio straniero: i belgi si erano sot
tratti al dominio olandese, i polacchi avevano scac
ciato il granduca Costantino, gl'italiani erano in
fermento. A Varsavia, appena partite le truppe
russe, un ufficiale francese aveva percorso a cavallo
le vie della città seguito da una folla che inneggia
va a Napoleone II re d i Polonia. Alcune città del
Belgio s'erano pure pronunciate in favore d'una
candidatura del duca di Reichstadt; c'era persino
chi parlava d 'un suo possibile matrimonio con la
infanta Maria G loria, ciò che avrebbe aperto al
Belgio i mercati portoghesi e brasiliani.
Queste notizie, riferite a Franz, lo fecero ridere.
E tuttavia ogni voce che arrivava da fuori, dibat
tuta nel segreto della sua anima tra il desiderio di
credere sempre vivo e l'ammaestramento delle pa
tite delusioni, sovreccitava la sua immaginazione.
La rivoluzione belga lo aveva colpito facendogli
intravvedere la guerra come una cosa possibile e
per conseguenza avvicinando il momento in cui
egli avrebbe dovuto o restarsene in disparte contro
il suo impulso e la sua convinzione o violare il te
stamento di suo padre; ma la rivoluzione polacca
rese questo tormento anche più doloroso. Franz
amava e ammirava il popolo polacco e odiava i
russi: ma prevedeva la disfatta della Polonia e «'in
dignava contro l'ingratitudine della Francia.
Prokesch e Dietrichstein si consultavano spesso
in quei giorni.
— L 'idea di marciare alla testa dei polacchi do
mina in lui ogni altra idea e non v 'h a dubbio eh**
se si presentasse l'occasione sarebbe pronto ad eva
dere — disse Prokesch una sera al conte Maurizio.
— Cosa ve lo fa supporre? — domandò il conte.
— Tutto, mio caro. Basta sentirlo parlare. Egli
si lascierebbe rapire dal primo polacco che si pre
sentaste. Del resto, alla testa di questo popolo va
loroso. egli farebbe meraviglie, ne sono certo.
— Anch 'io!
Non erano i soli a crederlo. L 'idea di dare per re
ai polacchi il figlio d i Napoleone faceva strada nella
«oetetà viennese. Qualcuno la «ottenne a vi«o aperto
nello stesso ambiente della Cancelleria e nel salotto
della futura suocera di Metternich, la contessa
Molly Zichy, che essendo fieramente avversa a tutto
ciò che aveva riferimento a Napoleone e alle sue
gesta, ne considerava il figlio poco meno che un
bastardo.
— Eppure l'Austria potrebbe trarre un grande
vantaggio dalla presenza del duca di Reichstadt sul
trono di Polonia! — aveva detto con vivacità una
dama dell'alta società, la principessa Grassalkovic
nata Eszterhazy.
Queste parole, riferite alla Zichy. la fecero mon
tare in furore.
— La principessa non sa quel che si dice! E ' una
donna di spirito, ma incapace di controllarsi —
protestò la contessa Zichy.
Metternich, presente alla scena. si contentò di
alzare le spalle sorridendo.
— Non inquietatevi, signora! ve lo dico una volta
per sempre: egli è escluso da tutti i troni!
— Escluso da tutti i troni! — pensava Prokesch
in carrozza tornando a casa. — Queste parole sono
certo l'espressione esatta del penderò del Cancel
liere sulle aspirazioni del dura di Reichstadt...
Ma s'ingannava.
Metternich aveva pronunciato apposta quella
frase, nel salotto di sua suocera, perchè sapeva che
l'eco se ne sarebbe subito diffusa dovunque.
Ciò giovava ai suoi piani, mentre l'incendio rivo
luzionario tendeva a propagarsi al resto de ll'E u
ropa.
LORENZO G IGLI
S P I C C I O L I
L e o n a rd o e i l n ib b io .
• (Jue-k* ««riter »i «li-linlainente tiri
nibbio par che «ia mio dentino, perché ne la prima rirurdazinnr
della a ia infanzia e* mi pareva rbe, essendo io 'n rulla, rbe un
nibbio veaÌMÌ a n e . e mi a p ric i la boera eolia -uà roda, e molte
volle m i pem leM i eoa la i roda dentro alle labbra ».
E Giuseppina Fumagalli rbw>a: • QmMo ricordo è divenuto fa
mo*o. E*m> ha dato orìgine a randidi»-im i commenti, come qur-l«.
del S o la i: “ In a tradisione ellenira narra che le api annunzia
rono al mondo in Demo-tene il più dolce e »qui*it<> oratore po li
tico ; il nibbio non sembra qui preannunziare il più alto e lim
pido descrittore della natura? **
i Frammenti letterari
e
filosofai.
Prefazione, pag. vi.). Sottilmente invece, «eguendo il proretlimenlo
rbe l'ha re*o famoso, lo ha indagato S. F u i ». in un volumetto
tradotto in francese da M alie Bovipaite.
l'm %tmvenir
«f
enfance
de L . de
F ., Paris, Gallimard, 1927. In e>« il Freud, partendo
da qnel che t i i a t t i può ^apporre *ia «tata l'infanzia di Leonardo,
e ricordando che il nibbio «elle tradizioni religione orientali p ri
m itive è «imbolo della maternità, roarlade che Leonardo è «tato
imprigionato dal completo materno, e sempre «oggetto al -no
inim ico n c Im v ìiU . (Jaindi — tratto a ciò anche dallo «lanrio
nativo form idabile alla vita puramente intellettiva
ha rifuggito
non *olo da ogni ba--: *ea«=alità. ma anche da ogni pacione
— in ■ I l «orriao «he fio ri-re le labbra delle -ne creazioni di
pittore è, incenda il Fre»d, il « rriM non mai dimenticato dcl-
l'um ile donni dei campi, la giovale e bella Caterina, la madre,
ihhaadnaaf da *er Piero da V ia ri. Parla. «otto la parvenza del
ricordo d'un to p * infantile, il «no «abco-eicate. attraveoo il
«imballimi» a La i per molte vie e ragioni fam iliare e raro. Sr
Miche non vnol*i «guire il Fread netta ricerca della tra«forma
M ae che la ‘ lib ido " «ahi a ri Grande, appare, però, bea gin
•tifirata 1‘idm titrazione del N ibbio eoa la Natara-madre, e quindi
il partir»lare valore di lia ^ a lin presagio che Pio roarieate di
Loaaafdo dava al agai. ** Par rfcr «aa nato dn iia» - Egli arrive
— ir raparmi del «ala del nibbio " ,
e
n ttia lra d r: r istru ire •• il
p a l i m i o ” a aaa à a iik a d ia r Q m * parala IM a u i pnrrr
ia rdanàomo eoa fatare l i n a t i d i igiraaaa, per aaa dira d i « r-
lanaa d i r i a n , roane fl nibbio. la battaglia dell'aria, ed
etmani
gloriato
m
M i « li «ferì a— la i >.


















