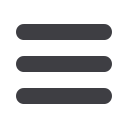
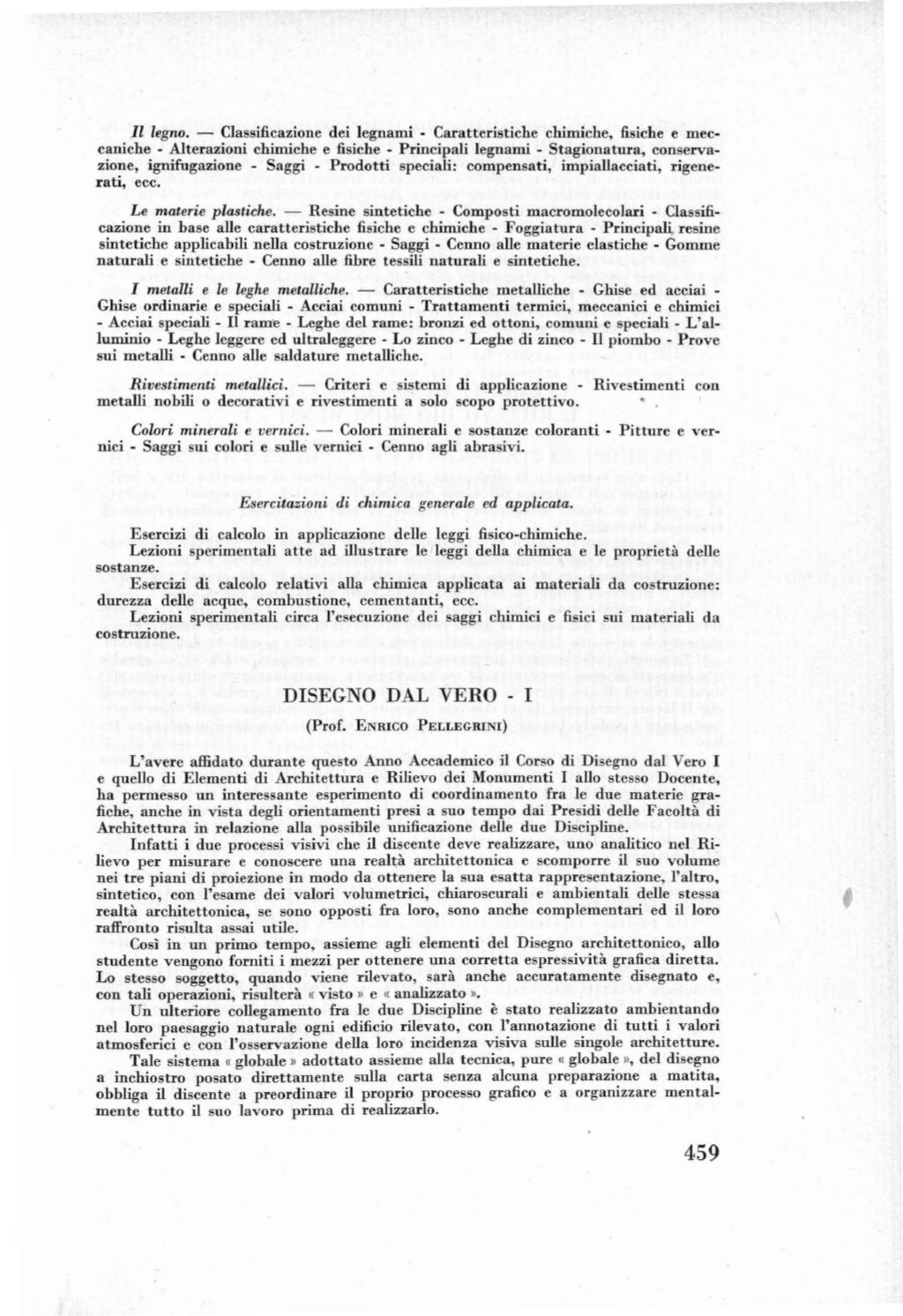
Il legno.
-
Classificazione dei legnami - Caratteristiche chimiche, fisiche e mec–
caniche - Alterazioni chimiche e fisiche - Principali legnami - Stagionatura, con serva–
zione, ignifugazione - Saggi - Prodotti speciali: compensati, impiallacciati, rigene–
rati, ecc.
Le mat erie plastiche.
-
Resine sintetiche - Composti macromolecolari - Classifi–
cazione in base alle caratteri stiche fisiche e chimiche - Foggiatura - Principali re sin e
sintetiche applicabili nella costruzione - Saggi - Cenno alle materie elastiche - Gomme
naturali e sint etiche - Cenno alle fibre te ssili naturali e sintetiche .
I metalli
e
le leghe metallich e.
-
Caratteristiche metalliche - Ghi se ed acciai –
Ghise ordinarie e speciali - Acciai comuni - Trattamenti termici, meccanici e chimici
- Acciai sp eciali - Il rame - Leghe del rame: bronzi ed ottoni, comuni e speciali - L'al–
luminio - Leghe leggere ed ultraleggere - Lo zinco - Legh e di zin co - Il piombo - Prove
sui metalli - Cenno all e saldature metalliche.
Rivestimenti metallici.
-
Criteri e siste mi di applicazione - Rivestimenti con
metalli nobili o decorativi e rivestimenti a solo scop o protettivo.
Colori minerali
e
vernici.
-
Colori minerali e sostanze coloranti - Pitture e ver–
nici - Sa ggi sui colori e sulle" vernici - Cenno agli abrasivi.
Esercitazioni di chimica generale ed applicata.
E sercizi di calcolo in applicazione delle leggi fisico-chimiche.
Lezioni speriment ali atte ad illustrare le leggi della chimica e le proprietà delle
sostan ze.
E sercizi di calcolo relativi all a chimica applicata ai materiali da costru zione :
durezza delle acque, combustione, cementanti, ecc .
Lezioni sperime ntali circa l'esecuzione dei saggi chimici e fisici sui materi ali da
costruzione.
DISEGNO DAL VERO - I
(Prof. E NRICO PELLEGRINI)
L'aver e affidato durante qu est o Anno Accademico il Corso di Di segn o dal Vero I
e quello di El em enti di Architettura e Rilievo dei Monumenti I allo ste sso Doc ente,
ha permesso un interessante esp erimento di coordiname nto fr a le du e materie gra–
fiche, anch e in vi st a degli orientamenti presi a suo tempo da i Presidi delle F aco ltà di
Architettura in relazione alla po ssibile unificazione delle du e Di scipline.
Infatti i due processi visivi che il di scente deve realizzare, uno an alitico ncl Ri–
lievo per mi surare e conoscere un a realtà architettonica e scomporre il suo volume
nei tre piani di proiezione in modo da otten ere la sua esa tta rappresentazione, l' altro,
sintetico, con l'esame dei valori volume trici, chiaroscura li e ambientali delle st essa
realtà ar chitettonica, se sono opposti fra loro, sono an ch e complemen ta ri ed il loro
raffronto ri sulta assai utile.
Così in un primo t empo, assiem e agli eleme nt i del Di segn o architettonico, allo
studente v engono forniti i mezzi per ottenere una corretta espress iv it à grafica diretta.
Lo stesso soggetto, quando vi ene ril evato, sarà an che accuratamente di segn ato e,
con tali op erazioni, risulterà
«
visto
»
e
«
analizza to
»,
Un ulteriore collegame nt o fra le due Di scipline
è
st ato realizzato ambientando
ne l loro paesaggio naturale ogni edifi cio ri levato, con l'annotazione di tutti i valori
atmosferici e con l'osservazione della loro incidenza visiva sulle sing ole ar chitetture.
Tale siste ma
«
globale
)l
adottato assieme all a t ecnica, pure
«
globale
»,
del disegno
a inchiostro posato direttamente sulla carta sen za alcuna pr eparazione a matita,
obbliga il discente a preordinare il proprio processo grafico e a organizzare mental–
mente tutto il suo lavoro prima di realizzarlo.
459


















