
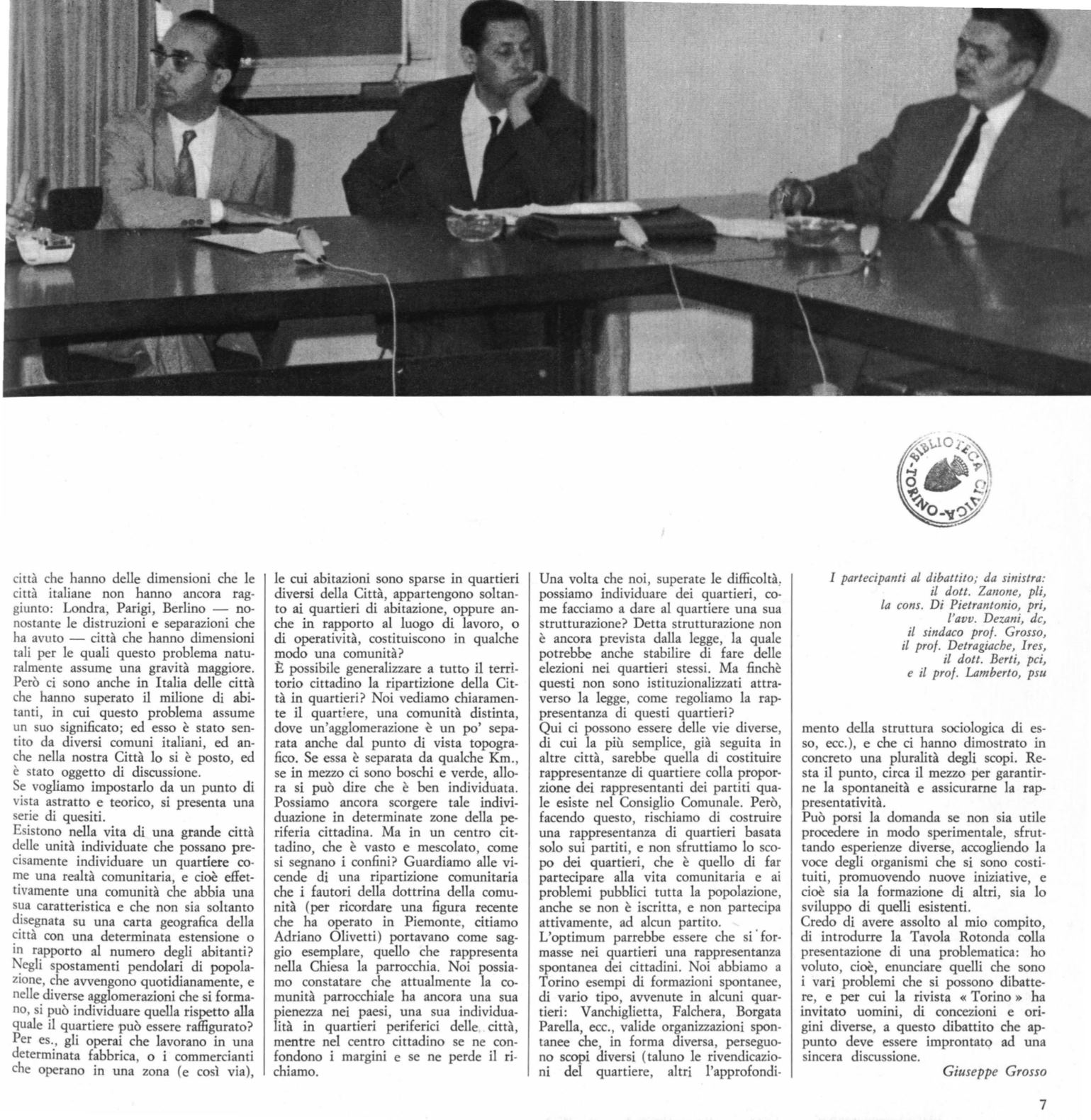
città che hanno delle dimensioni che le
città italiane non hanno ancora rag–
giunto: Londra, Parigi, Berlino - no–
nostante le distruzioni e separazioni che
ha avuto - città che hanno dimensioni
tali per le quali questo problema natu–
ralmente assume una gravità maggiore.
Però ci sono anche in Italia delle città
che hanno superato il milione di abi–
tanti, in cui questo problema assume
un suo significato; ed esso è stato sen–
tito da diversi comuni italiani, ed an–
che nella nostra Città lo si è posto, ed
è stato oggetto di discussione.
Se vogliamo impostarlo da un punto di
vista astratto e teorico, si presenta una
serie di quesiti.
Esistono nella vita
di
una grande città
delle unità individuate che possano pre–
cisamente individuare un quartiere co–
me una realtà comunitaria, e cioè effet–
tivamente una comunità che abbia una
sua caratteristica e che non sia soltanto
disegnata su una carta geografica della
città con una determinata estensione o
in rapporto al numero degli abitanti?
~eg1ispostamenti
pendolari di popola–
ZIOne, che avvengono quotidianamente, e
nelle diverse agglomerazioni che si forma–
no, si può individuare quella rispetto alla
quale il quartiere può essere raffigurato?
Per es. , gli operai che lavorano in una
determinata fabbrica, o i commercianti
che operano in una zona (e cosi via),
le cui abitazioni sono sparse in quartieri
diversi della Città, appartengono soltan–
to ai quartieri di abitazione, oppure an–
che in rapporto al luogo di lavoro, o
di operatività, costituiscono in qualche
modo una comunità?
È
possibile generalizzare a tutto il terri–
torio cittadino la ripartizione della Cit–
tà in quartieri? Noi vediamo chiaramen–
te
il
quartiere, una comunità distinta,
dove un'agglomerazione
è
un po' sepa–
rata anche dal punto di vista topogra–
fico. Se essa è separata da qualche Km. ,
se in mezzo ci sono boschi e verde, allo–
ra si può dire che è ben individùata.
Possiamo ancora scorgere tale indivi–
duazione in determinate zone della pe–
riferia cittadina. Ma in un centro cit–
tadino, che è vasto e mescolato, come
si segnano i confini? Guardiamo alle vi–
cende di una ripartizione comunitaria
che i fautori della dottrina della comu–
nità (per ricordare una figura recente
che ha operato in Piemonte, citiamo
Adriano Olivetti) portavano come sag–
gio esemplare, quello che rappresenta
nella Chiesa la parrocchia. Noi possia–
mo constatare che attualmente la co–
munità parrocchiale ha ancora una sua
pienezza nei paesi, una sua individua–
lità in quartieri periferici delle città,
mentre nel centro cittadino se ne con–
fondono i margini e se ne perde il
ri–
chiamo.
Una volta che noi, superate le difficoltà,
possiamo individuare dei quartieri, co–
me facciamo a dare al quartiere una sua
strutturazione? Detta strutturazione non
è ancora prevista dalla legge, la quale
potrebbe anche stabilire di fare delle
elezioni nei quartieri stessi. Ma finchè
questi non sono istituzionalizzati attra–
verso la legge, come regoliamo la rap–
presentanza di questi quartieri?
Qui ci possono essere delle vie diverse,
di cui la più semplice, già seguita in
altre città, sarebbe quella di costituire
rappresentanze di quartiere colla propor–
zione dei rappresentanti dei partiti qua–
le esiste nel Consiglio Comunale. Però,
facendo questo, rischiamo di costruire
una rappresentanza di quartieri basata
solo sui partiti, e non sfruttiamo lo sco–
po dei quartieri, che è quello di far
partecipare alla vita comunitaria e ai
problemi pubblici tutta la popolazione,
anche se non è iscritta, e non partecipa
attivamente, ad alcun partito. "–
L'optimum parrebbe essere che si · for–
masse nei quartieri una rappresentanza
spontanea dei cittadini. Noi abbiamo a
Torino esempi di formazioni spontanee,
di vario tipo, avvenute in alcuni quar–
tieri: Vanchiglietta, Falchera, Borgata
Parella, ecc., valide organizzazioni spon–
tanee che, in forma diversa, perseguo–
no scopi diversi (taluno le rivendicazio–
ni del quartiere, altri l'approfondi-
I partecipanti al dibattito; da sinistra:
il dotto Zallone, pli,
la cons. Di Pietrantonio, pri,
l'avv. Dezani, dc,
il
sindaco pro!. Grosso,
il pro!. Detragiache, l res,
il dotto Berti, pci,
e il pro!. Lamberto, psu
mento della struttura sociologica di es–
so, ecc.), e che ci hanno dimostrato in
concreto una pluralità degli scopi. Re–
sta il punto, circa
il
mezzo per garantir–
ne la spontaneità e assicurarne la rap–
presentatività.
Può porsi la domanda se non sia utile
procedere in modo sperimentale, sfrut–
tando esperienze diverse, accogliendo la
voce degli organismi che si sono costi–
tuiti, promuovendo nuove iniziative, e
cioè sia la formazione di altri, sia lo
sviluppo di quelli esistenti.
Credo di avere assolto al mio compito,
di introdurre la Tavola Rotonda colla
presentazione di una problematica: ho
voluto, cioè, enunciare quelli che sono
i vari problemi che si possono dibatte–
re, e per cui la rivista «Torino» ha
invitato uomini, di concezioni e ori–
gini diverse, a questo dibattito che ap–
punto deve essere improntatq ad una
sincera discussione.
Giuseppe Grosso
7


















