
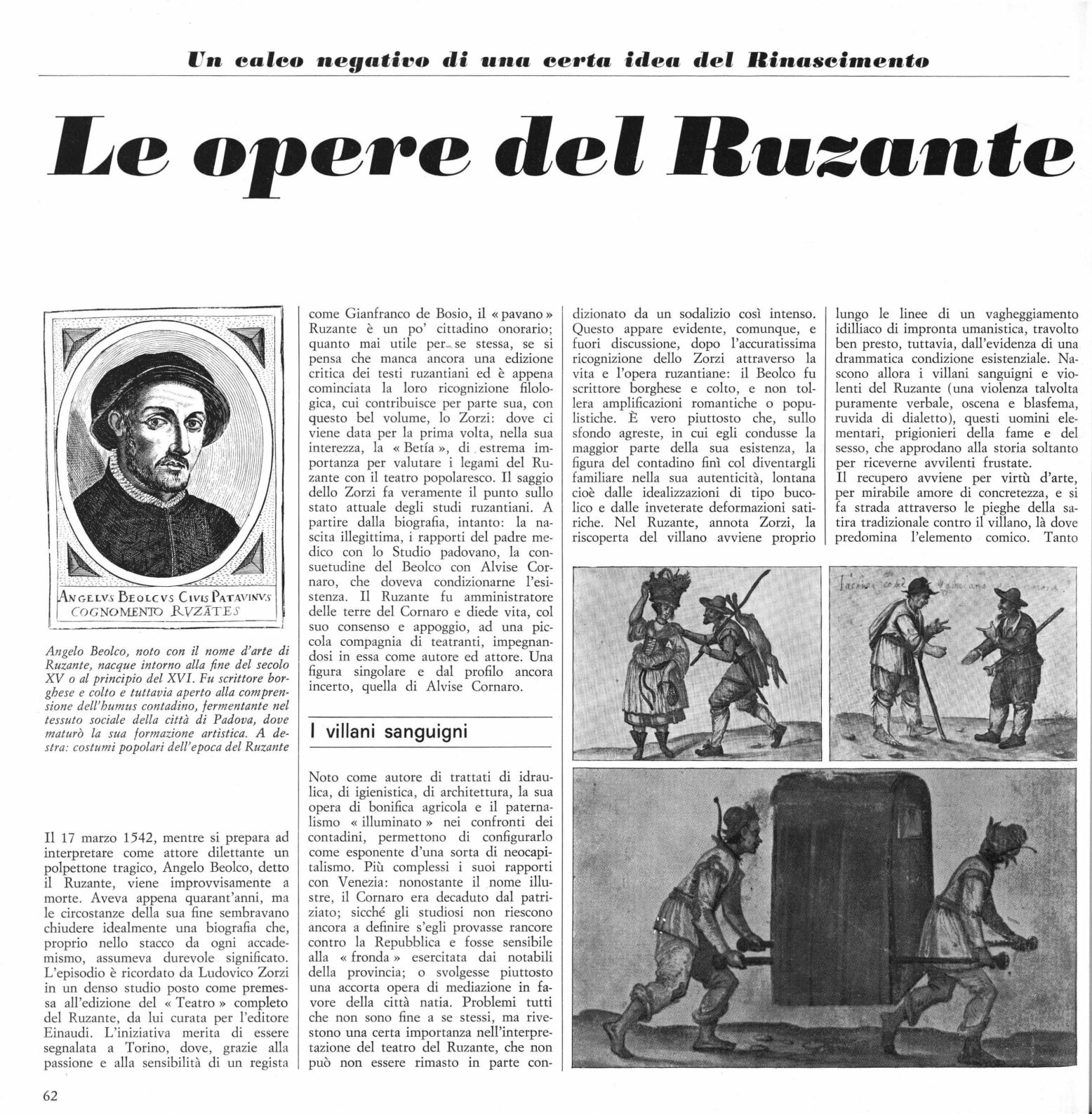
IIn calco neuativo
di
uno certo ideo del RinoscilUento
Le opere del Ru%onte
Gf.LVS BEOLCVS C1VIS
PATA"JtoN.S'
NOMENro
RVZATES
Angelo Beolco, noto con il nome d'arte di
Ruzante, nacque intorno alla fine del secolo
XV
o
al principio del XVI. Fu scrittore bor–
ghese e colto e tuttavia aperto alla compren–
sione dell'humus contadino, fermentante nel
tessuto sociale della città di Padova, dove
maturò la sua formazione artistica. A de–
stra: costumi popolari dell'epoca del Ruzante
Il 17 marzo 1542, mentre si prepara ad
interpretare come attore dilettante un
polpettone tragico, Angelo Beolco, detto
il
Ruzante, viene improvvisamente a
morte. Aveva appena quarant'anni, ma
le circostanze della sua fine sembravano
chiudere idealmente una biografia che,
proprio nello stacco da ogni accade–
mismo, assumeva durevole significato.
L'episodio è ricordato da Ludovico Zorzi
in un denso studio posto come premes–
sa all'edizione del « Teatro» completo
del Ruzante, da lui curata per l'editore
Einaudi. L'iniziativa merita di essere
segnalata a Torino, dove, grazie alla
passione e alla sensibilità di un regista
62
come Gianfranco de Bosio, il «pavano»
r
Ruzante è un po' cittadino onorario ;
quanto mai utile per_ se stessa, se si
pensa che manca ancora una edizione
critica dei testi ruzantiani ed è appena
cominciata la loro ricognizione filolo–
gica, cui contribuisce per parte sua, con
questo bel volume, lo Zorzi: dove ci
viene data per la prima volta, nella sua
interezza, la « Berla », di estrema im–
portanza per valutare i legami del Ru–
zante con il teatro popolaresco. Il saggio
dello Zorzi fa veramente il punto sullo
stato attuale degli studi ruzantiani. A
partire dalla biografia, intanto: la na–
scita illegittima, i rapporti del padre me–
dico con lo Studio padovano, la con–
suetudine del Beolco con Alvise Cor–
naro, che doveva condizionarne l'esi–
stenza . Il Ruzante fu amministratore
delle terre del Cornaro e diede vita, col
suo consenso e appoggio, ad una pic–
cola compagnia di teatranti, impegnan–
dosi in essa come autore ed attore. Una
figura singolare e dal profilo ancora
incerto, quella di Alvise Cornaro.
I villani sangUigni
Noto come autore di trattati di idrau–
lica, di igienistica, di architettura, la sua
opera di bonifica agricola e il paterna–
lismo «illuminato» nei confronti dei
contadini, permettono di configurarlo
come esponente d'una sorta di neocapi–
talismo. Più complessi i suoi rapporti
con Venezia: nonostante
il
nome illu–
stre, il Cornaro era decaduto dal patri–
ziato; sicché gli studiosi non riescono
ancora a definire s'egli provasse rancore
contro la Repubblica e fosse sensibile
alla « fronda » esercitata dai notabili
della provincia ; o svolgesse piuttosto
una accorta opera di mediazione in fa–
vore della città natia. Problemi tutti
che non sono fine a se stessi, ma rive–
stono una certa importanza nell'interpre–
tazione del teatro del Ruzante, che non
può non essere rimasto in parte con-
dizionato da un sodalizio così intenso.
Questo appare evidente, comunque, e
fuori discussione, dopo l'accuratissima
ricognizione dello Zorzi attraverso la
vita e l'opera ruzantiane: il Beolco fu
scrittore borghese e colto, e non tol–
lera amplificazioni romantiche o popu–
listiche.
È
vero piuttosto che, sullo
sfondo agreste, in cui egli condusse la
maggior parte della sua esistenza, la
figura del contadino finì col diventargli
familiare nella sua autenticità, lontana
cioè dalle idealizzazioni di tipo buco–
lico e dalle inveterate deformazioni sati–
riche. Nel Ruzante, annota Zorzi, la
riscoperta del villano avviene proprio
lungo le linee di un vagheggiamento
idilliaco di impronta umanistica, travolto
ben presto, tuttavia, dall'evidenza di una
drammatica condizione esistenziale. Na–
scono allora i villani sanguigni e vio–
lenti del Ruzante (una violenza talvolta
puramente verbale, oscena e blasfema,
ruvida di dialetto), questi uomini ele–
mentari, prigionieri della fame e del
sesso, che approdano alla storia soltanto
per riceverne avvilenti frustate.
Il recupero avviene per virtù d'arte,
per mirabile amore di concretezza, e si
fa strada attraverso le pieghe della sa–
tira tradizionale contro il villano, là dove
predomina l'elemento comico. Tanto


















