
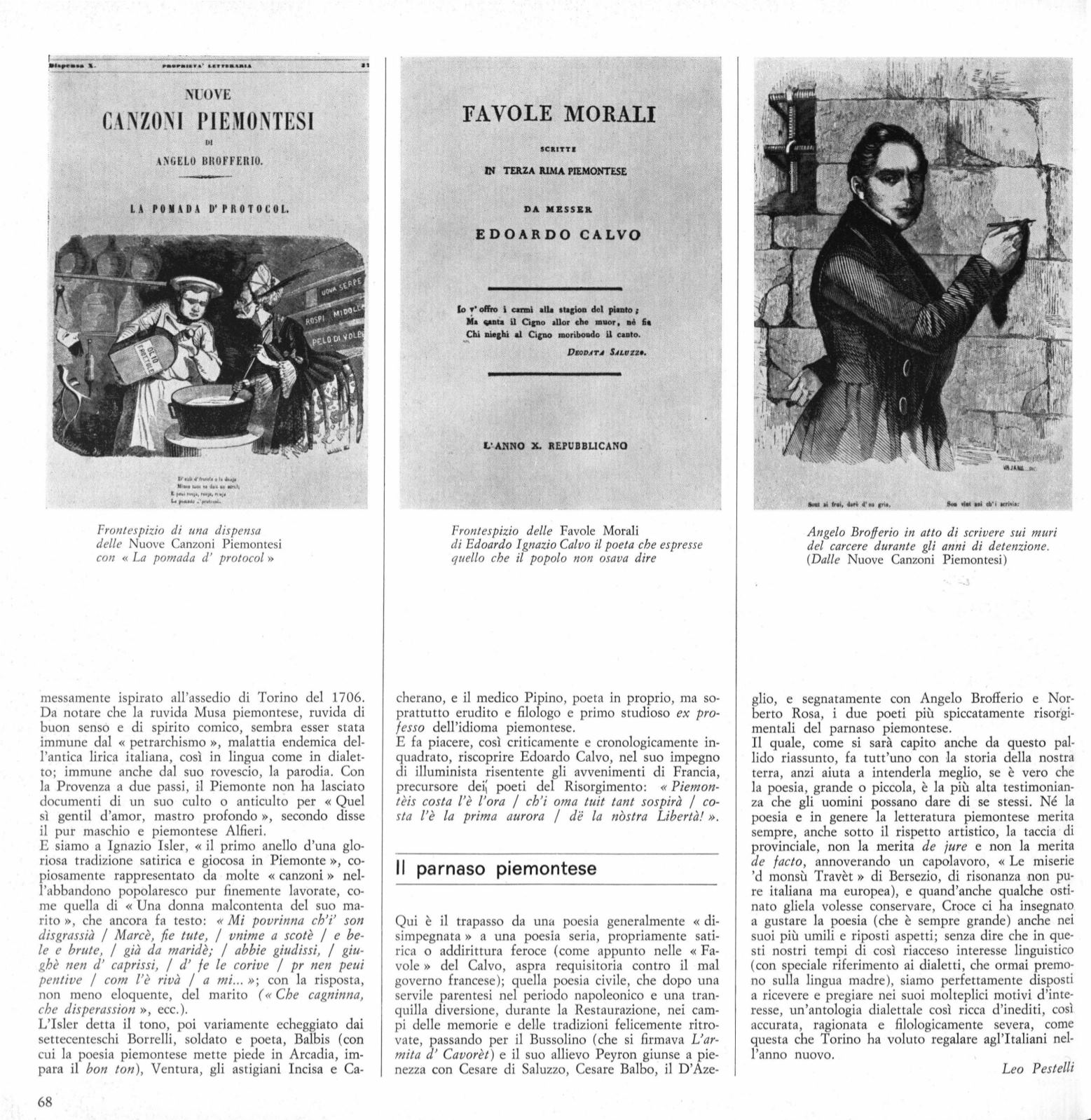
NUOVE
CANZONI
PIE~IONTESI
111
ANGELO IlIlOFFEItIO.
LA 'OIADA
D'
PROTOCOL,
l;'wlr4"tt..I«.lb.&..oJ–
M**,-,,"
uw ..
•
ltd~
t"....,..I••
,..,.,,...~jOJ'
W~
..
'f'h'I"~.
Front espizio di una dispensa
delle
Nuove Canzoni Piemontesi
con « La pomada d' protocol »
messamente ispirato all'assedio di Torino del 1706.
Da notare che la ruvida Musa piemontese, ruvida di
buon senso e di spirito comico, sembra esser stata
immune dal « petrarchismo », malattia endemica del–
l'antica lirica italiana, così in lingua come in dialet–
to; immune anche dal suo rovescio, la parodia. Con
la Provenza a due passi, iJ Piemonte non ha lasciato
documenti di un suo culto o anticulto per «Quel
sì gentil d'amor, mastro profondo », secondo disse
il
pur maschio e piemontese Alfieri.
E siamo a Ignazio Isler, «il primo anello d'una glo–
riosa tradizione satirica e giocosa in Piemonte », co–
piosamente rappresentato da molte «canzoni» nel–
l'abbandono popolaresco pur finemente lavorate, co–
me quella di «Una donna malcontenta del suo ma–
rito », che ancora fa testo:
« Mi povrinna ch'i' san
disgrassià
/
Marcè, fie tute,
/
vnime a scotè
/
e be–
le e brute,
/
già da maridè;
/
abbie giudissi,
/
giu–
ghè nen d' caprissi,
/
d' fe le corive
/
pr nen peui
pentive
/
com l'è rivà
/
a mi...
» ;
con la risposta,
non meno eloquente, del marito
( <<
Che cagninna,
che disperassion
», ecc.).
L'Isler detta
il
tono, poi variamente echeggiato dai
settecenteschi Borrelli, soldato e poeta, Balbis (con
cui la poesia piemontese mette piede in Arcadia, im–
para
il
bon ton),
Ventura, gli astigiani Incisa e Ca-
68
FAVOLE MORALI
scalTTI
IN TERZA
IUMA PIEMONTESE
DA .. _5s_a
.E DOARDO CALVO
ID
y'
offro l
cami
.Ila
atqloB
del
JIÙIdO
I
Ili.
_ti.
li
C'Po aIlor
che __• ..
fi.
~
lÙII&hi
ù
Cipo
tIIOrlbolldo
li
cuto.
DrtJD.lT..I ISAI."'lIn.
"~Al'tNO
X.
RE.1'UBBLlCANO
Frontespizio delle
Favole Morali
di Edoardo I gnazio Calvo il poeta che espresse
quello che il popolo non osava dire
cherano, e
il
medico Pipino, poeta in proprio, ma so–
prattutto erudito e filologo e primo studioso
ex pro–
fesso
dell'idioma piemontese.
E fa piacere, così criticamente e cronologicamente in–
quadrato, riscoprire Edoardo Calvo, nel suo impegno
di illuminista risentente gli avvenimenti di Francia,
precursore dei; poeti del Risorgimento:
«Piemon–
tèis costa l'è l'ora
/
ch'i ama tui! tant sospirà
/
co–
sta l'è la prima aurora
/
de la nòstra Libertà.'
».
Il
pa rnaso piemontese
Qui è il trapasso da una poesia generalmente «di–
simpegnata» a una poeSIa seria, propriamente sati–
rica o addirittura feroce (come appunto nelle «Fa–
vole» del Calvo, aspra requisitoria contro il mal
governo francese); quella poesia civile, che dopo una
servile parentesi nel periodo napoleonico e una tran–
quilla diversione, durante la Restaurazione, nei cam–
pi delle memorie e deHe tradizioni felicemente ritro–
vate, passando per
il
Bussolino (che si Brmava
L'ar–
mita d' Cavorèt)
e
il
suo allievo Peyron giunse a pie–
nezza con Cesare di Saluzzo, Cesare Balbo, il D'Aze-
Angelo Brofferio in atto di scrivere sui muri
del carcere durante gli anni di detenzione.
(Dalle
Nuove Canzoni Piemontesi)
glio, e segnatamente con Angelo Brofferio e Nor–
berto Rosa, i due poeti più spiccatamente risorgi–
mentali del parnaso piemontese.
Il quale, come si sarà capito anche da questo pal–
lido riassunto, fa tutt'uno con Ja storia della nostra
terra, anzi aiuta a intenderla meglio, se è vero che
la poesia, grande o piccola, è la più alta testimonian–
za che gli uomini possano dare di se stessi. Né la
poesia e in genere la letteratura piemontese merita
sempre, anche sotto
il
rispetto artistico, la taccia di
provinciale, non
la
merita
de jure
e non la merita
de facto,
annoverando un capolavoro, «Le miserie
'd monsù Travèt» di Bersezio, di risonanza non pu–
re italiana ma europea), e quand'anche qualche osti–
nato gliela volesse conservare, Croce ci ha insegnato
a gustare la poesia (che è sempre grande) anche nei
suoi più umili e riposti aspetti; senza dire che in que–
sti nostri tempi di così riacceso interesse linguistico
(con speciale riferimento ai dialetti, che ormai premo–
no sulla lingua madre), siamo perfettamente disposti
a ricevere e pregiare nei suoi molteplici motivi d'inte–
resse, un'antologia dialettale così ricca d'inediti, così
accurata, ragionata e filologicamente severa, come
questa che Torino ha voluto regalare agl'Italiani nel–
l'anno nuovo.
Leo Pestelli


















