
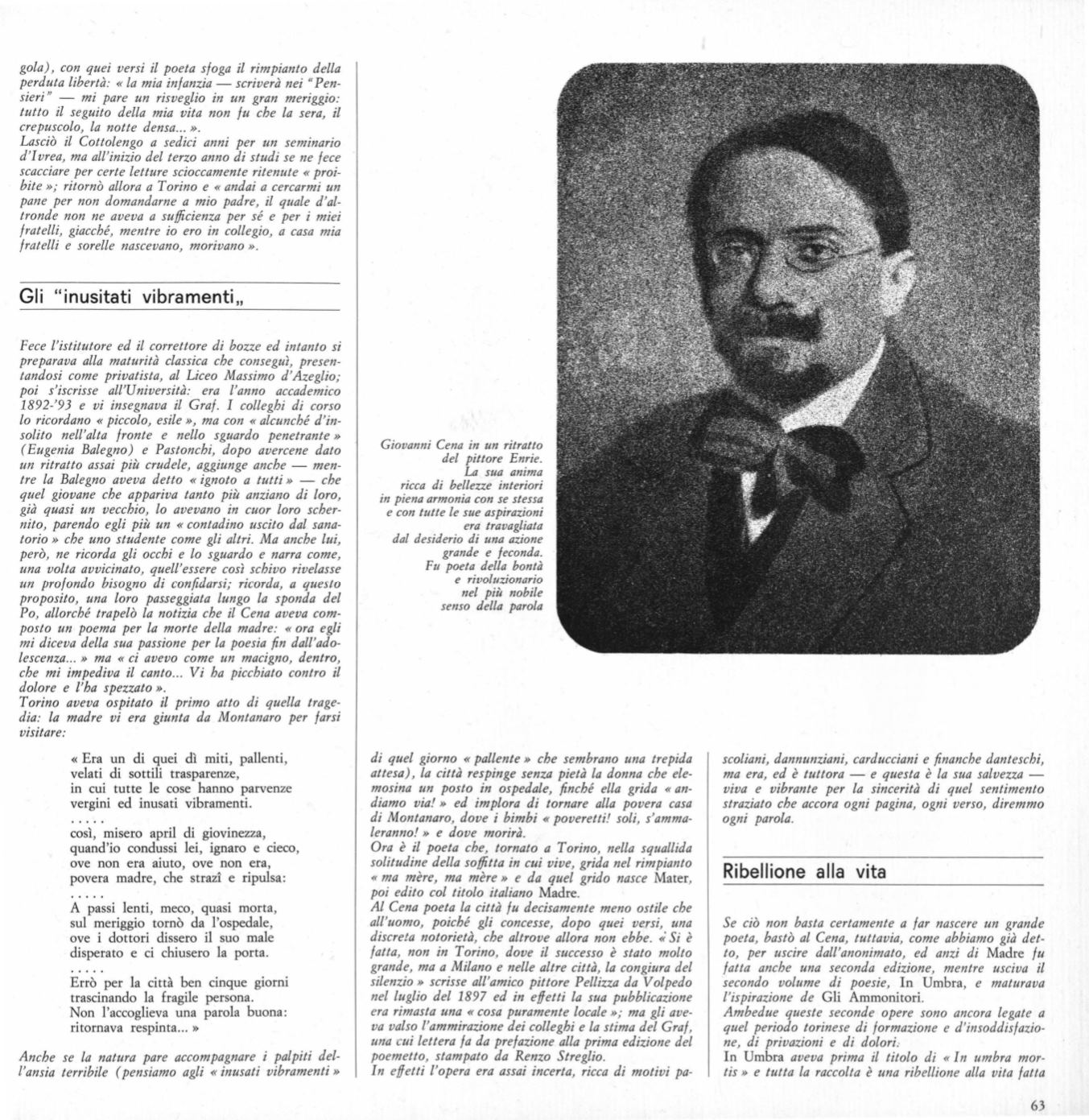
gola), con quei versi il poeta sfoga il rimpianto della
perduta libertà: «la mia infanzia
-
scriverà nei
((
Pen-
sieri
JJ
-
mi pare un risveglio in un gran meriggio:
tutto il seguito della mia vita non fu che la sera, il
crepuscolo, la notte densa...
».
Lasciò il Cottolengo a sedici anni per un seminario
d'Ivrea, ma all'inizio del terzo anno di studi se ne fece
scacciare per certe letture scioccamente ritenute
«
proi–
bite
»;
ritornò allora a
T
orino e
«
andai a cercarmi un
pane per non domandarne a mio padre, il quale d'al–
tronde non ne aveva a sufficienza per sé e per i miei
fratelli, giacché, mentre io ero in collegio, a casa mia
fratelli e sorelle nascevano, morivano
».
GI
i "i
nusitati vi bramenti"
Fece l'istitutore ed il correttore di bozze ed intanto si
preparava alla maturità classica che conseguì, presen–
tandosi come privatista, al Liceo Massimo d'Azeglio;
poi s'iscrisse all'Università: era l'anno accademico
1892-'93 e vi insegnava il Gra/. I colleghi di corso
lo ricordano
«
piccolo, esile
»,
ma con «alcunché d'in–
solito nell'alta fronte e nello sguardo penetrante »
(Eugenia Balegno) e Pastonchi, dopo avercene dato
un ritratto assai più crudele, aggiunge anche
-
men–
tre la Balegno aveva detto «ignoto a tutti »
-
che
quel giovane che appariva tanto più anziano di loro,
già quasi un vecchio, lo avevano in cuor loro scher–
nito, parendo egli più un «contadino uscito dal sana–
torio
»
che uno studente come gli altri. Ma anche lui,
però, ne ricorda gli occhi e lo sguardo e narra come,
una volta avvicinato, quell'essere così schivo rivelasse
un profondo bisogno di confidarsi; ricorda, a questo
proposito, una loro passeggiata lungo la sponda del
Po, allorché trapelò la notizia che il Cena aveva com–
posto un poema per la morte della madre: «ora egli
mi diceva della sua passione per la poesia fin dall'ado–
lescenza...
»
ma
«
ci avevo come un macigno, dentro,
che mi impediva il canto ... Vi ha picchiato contro il
dolore e l'ha spezzato
».
T
orino aveva ospitato il primo atto di quella trage–
dia: la madre vi era giunta da Montanaro per farsi
visitare:
«Era un di quei dì miti, pallenti,
velati di sottili trasparenze,
in cui tutte le cose hanno parvenze
vergini ed inusati vibramenti.
così, misero april di giovinezza,
quand'io condussi lei, ignaro e cieco,
ove non era aiuto, ove non era,
povera madre, che strazì e ripulsa:
A passi lenti, meco, quasi morta,
sul meriggio tornò da l'ospedale,
ove i dottori dissero
il
suo male
disperato e ci chiusero la porta.
Errò per la città ben cinque giorni
trascinando la fragile persona.
Non l'accoglieva una parola buona:
ritornava respinta...
»
Anche se la natura pare accompagnare i palpiti del–
l'ansia terribile (pensiamo agli «inusati vibramenti»
Giovanni Cena in un ritratto
del pittore Enrie.
La sua anima
ricca di bellezze interiori
in piena armonia con se stessa
e con tutte le sue aspirazioni
era travagliata
dal desiderio di una azione
grande e feconda.
Fu poeta della bontà
e rivoluzionario
nel più nobile
senso della parola
di quel giorno
«
pallente» che sembrano una trepida
attesa), la città respinge senza pietà la donna che ele–
mosi1:la un posto in ospedale, finché ella grida «an–
diamo via!» ed implora di tornare alla povera casa
di Montanaro, dove i bimbi
«
poveretti! soli, s'amma–
leranno! » e dove morirà.
Ora è il poeta che, tornato a Torino, nella squallida
solitudine della soffitta in cui vive, grida nel rimpianto
«ma mère, ma mère» e da quel grido nasce
Mater,
poi edito col titolo italiano
Madre.
Al Cena poeta la città fu decisamente meno ostile che
all'uomo, poiché gli concesse, dopo quei versi, una
discreta notorietà, che altrove allora non ebbe. «Si è
fatta, non in Torino , dove il successo è stato molto
grande, ma a Milano e nelle altre città, la congiura del
silenzio» scrisse all'amico pittore Pellizza da Volpedo
nel luglio del
1897
ed in effetti la sua pubblicazione
era rimasta una « cosa puramente locale
»;
ma gli ave–
va valso l'ammirazione dei colleghi e la stima del Graf,
una 'Cui lettera fa da prefazione alla prima edizione del
poemetto, stampato da Renzo Streglio.
In effetti l'opera era assai incerta, ricca di motivi pa-
scoliani, dannunziani, carducciani e finanche danteschi,
ma era, ed è tuttora
-
e questa è la sua salvezza -
viva e vibrante per la sincerità di quel sentimento
straziato che accora ogni pagina, ogni verso, diremmo
ogni parola.
Ribellione alla vita
Se ciò non basta certamente a far nascere un grande
poeta, bastò al Cena, tuttavia, come abbiamo già det–
to, per uscire dall'anonimato, ed anzi di
Madre
fu
fatta anche una seconda edizione, mentre usciva il
secondo volume di poesie,
In Umbra,
e maturava
l'ispirazione de
Gli Ammonitori.
Ambedue queste seconde opere sono ancora legate a
quel periodo torinese di formazione e d'insoddisfazio–
ne, di privazioni e di dolori ..
In Umbra
aveva prima il titolo di « I n umbra mor–
tis» e tutta la raccolta è una ribellione alla vita fatta
63


















