
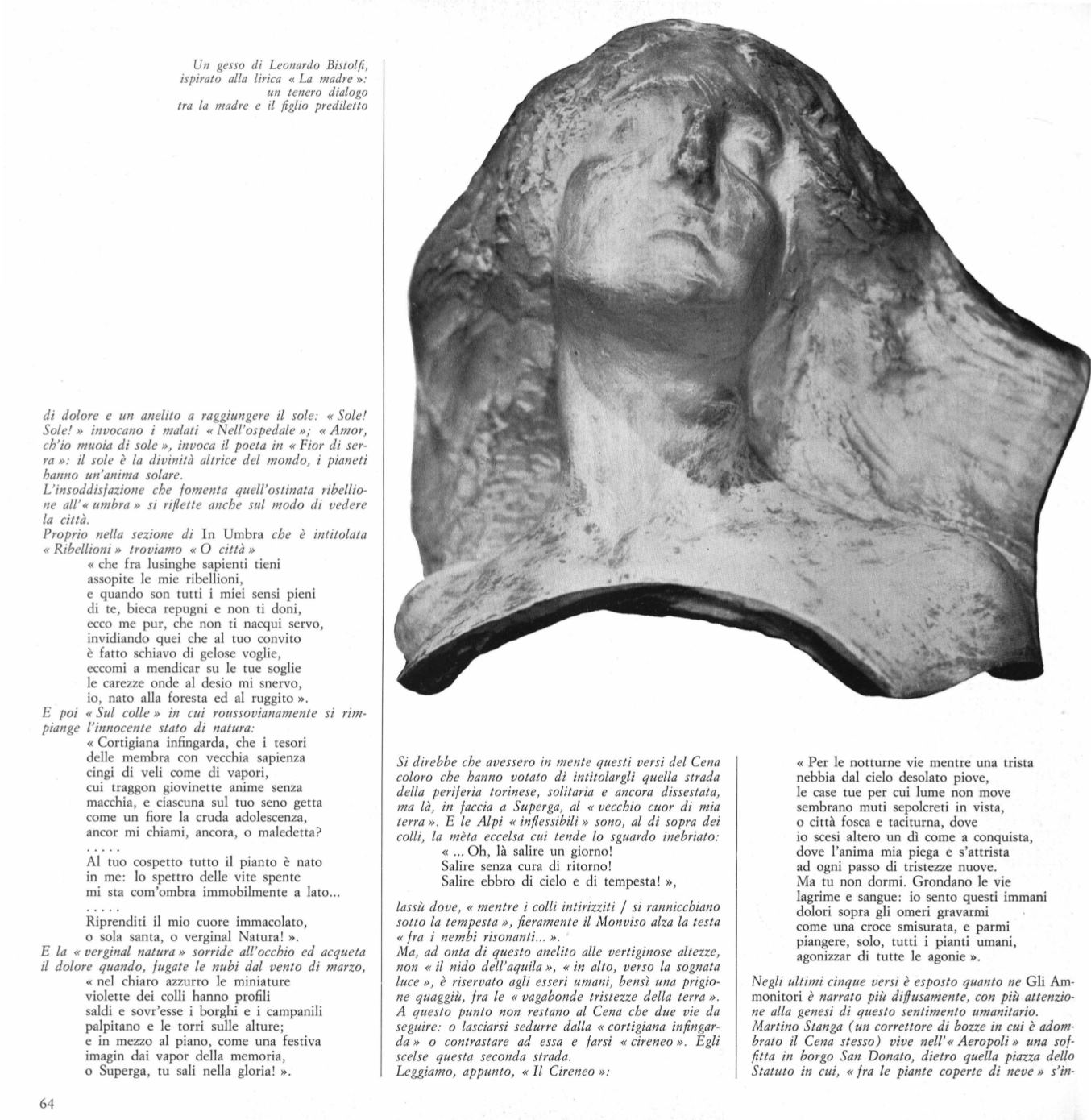
Un gesso di Leonardo Bistolfi,
ispirato alla lirica « La madre
»:
un tenero dialogo
tra la madre e il figlio prediletto
di dolore e un anelito a raggiungere il sole: « Sole'
Sole
l
»
invocano i malati « Nell'ospedale
»;
« Amor,
ch'io muoia di sole
»,
invoca il poeta in « Fior di ser–
ra
»:
il sole è la divinità altrice del mondo, i pianeti
hanno un'anima solare.
L'insoddisfazione che fomenta quell'ostinata ribellio–
ne all'« umbra » si riflette anche sul modo di vedere
la città.
Proprio nella sezione di
In Umbra
che è intitolata
«
Ribellioni» troviamo
« O
città»
«
che fra lusinghe sapienti tieni
assopite le mie ribellioni,
e quando son tutti i miei sensi pieni
di te, bieca repugni e non ti doni,
ecco me pur, che non ti nacqui servo,
invidiando quei che al tuo convito
è
fatto schiavo di gelose voglie,
eccomi a mendicar su le tue soglie
le carezze onde al desio mi snervo,
io, nato alla foresta ed al ruggito
».
E
poi « Sul colle» in cui roussovianamente si rzm–
piange l'innocente stato di natura:
«
Cortigiana innngarda, che i tesori
delle membra con vecchia sapienza
cingi di veli come di vapori,
cui traggon giovinette anime senza
macchia, e ciascuna sul tuo seno getta
come un nore la cruda adolescenza,
ancor mi chiami, ancora, o maledetta?
Al tuo cospetto tutto il pianto è nato
in me: lo spettro delle vite spente
mi sta com'ombra immobilmente a lato ...
Riprenditi il mio cuore immacolato,
o sola santa, o verginal Natura!
».
E
la « verginal natura» sorride all'occhio ed acqueta
il dolore quando, fugate le nubi dal vento di marzo,
«
nel chiaro azzurro le miniature
64
violette dei colli hanno pronli
saldi e sovr'esse i borghi e i campanili
palpitano e le torri sulle alture;
e in mezzo al piano, come una festiva
imagin dai vapor della memoria,
o Superga, tu sali nella gloria!
».
Si direbbe che avessero in mente questi versi del Cena
coloro che hanno votato di intitolargli quella strada
della periferia torinese, solitaria e ancora dissestata,
ma là, in faccia a Superga, al «vecchio cuor di mia
terra
».
E
le Alpi «inflessibili» sono, al di sopra dei
colli, la mèta eccelsa cui tende lo sguardo inebriato:
« ...
Oh, là salire un giorno!
Salire senza cura di ritorno!
Salire ebbro di cielo e di tempesta!
»,
lassù dove,
«
mentre i colli intirizziti
/
si rannicchiano
sotto la tempesta
»,
fieramente il Monviso alza la testa
«
fra i nembi risonanti.. .
».
Ma, ad onta di questo anelito alle vertiginose altezze,
non « il nido dell'aquila
»,
«in alto, verso la sognata
luce
»,
è riservato agli esseri umani, bensì una prigio–
ne quaggiù, fra le «vagabonde tristezze della terra
».
A questo punto non restano al Cena che due vie da
seguire:
o
lasciarsi sedurre dalla «cortigiana infingar–
da»
o
contrastare ad essa e farsi «cireneo
».
Egli
scelse questa seconda strada.
Leggiamo, appunto, « Il Cireneo
»:
«
Per le notturne vie mentre una trista
nebbia dal cielo desolato piove,
le case tue per cui lume non move
sembrano muti sepolcreti in vista,
o città fosca e taciturna, dove
io scesi altero un dì come a conquista,
dove l'anima mia piega e s'attrista
ad ogni passo di tristezze nuove.
Ma tu non dormi. Grondano le vie
lagrime e sangue: io sento questi immani
dolori sopra gli omeri gravarmi
come una croce smisurata, e parmi
piangere, solo, tutti
i
pianti umani,
agonizzar di tutte le agonie
».
Negli ultimi cinque versi è esposto quanto ne
Gli Am–
monitori
è narrato più diffusamente, con più attenzio–
ne alla genesi di questo sentimento umanitario.
Martino Stanga (un correttore di bozze in cui è adom–
brato il Cena stesso) vive nell'« Aeropoli» una sof–
fitta in borgo San Donato, dietro quella piazza dello
Statuto in cui, «fra le piante coperte di neve» s'in-


















