
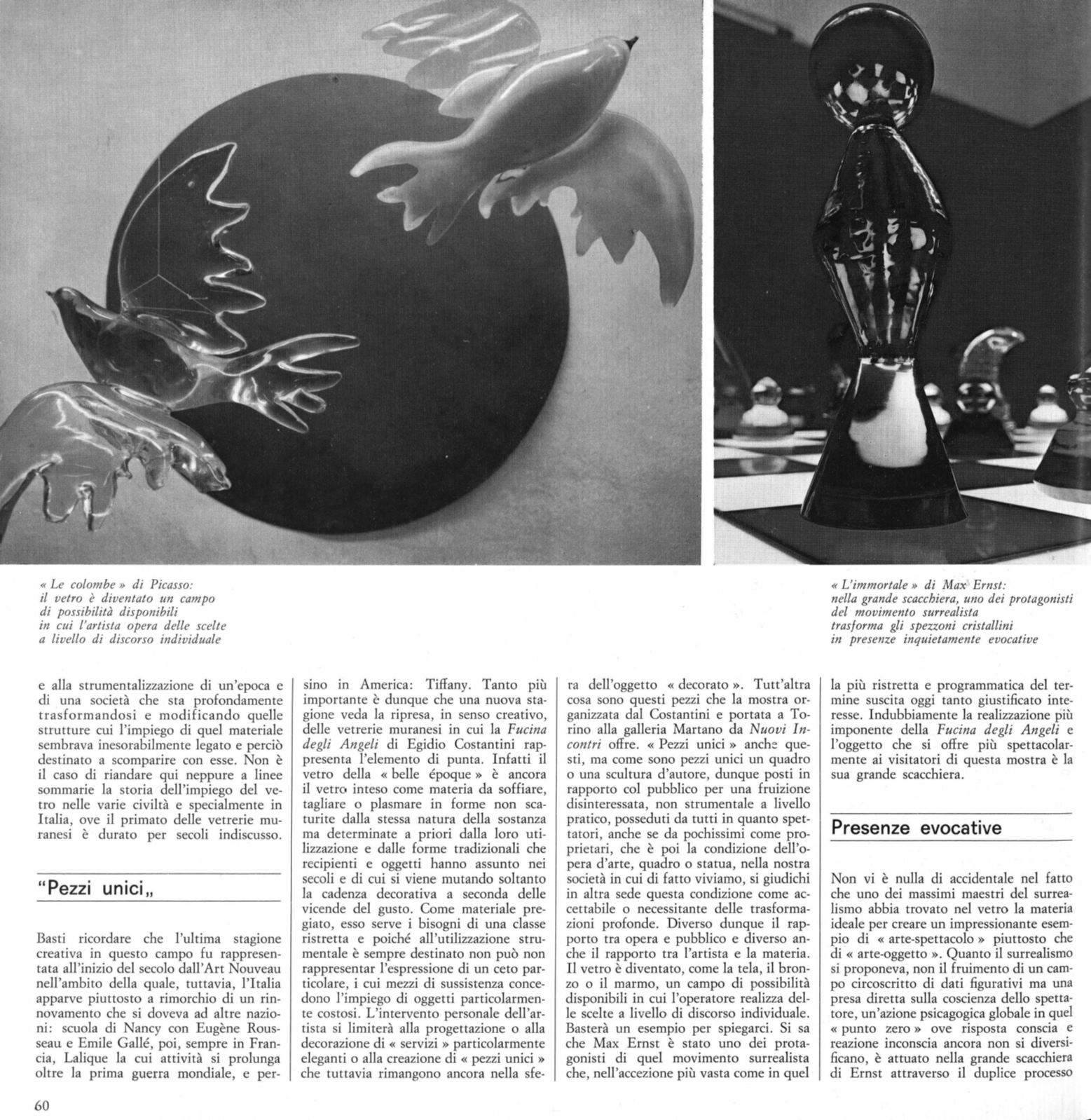
« Le colombe» di Picasso:
il vetro è diventato un campo
di possibilità disponibili
in cui l'artista opera delle scelte
a livello di discorso individuale
e alla strumentalizzazione di un'epoca e
di una società che sta profondamente
trasformandosi e modificando quelle
strutture cui l'impiego di quel materiale
sembrava inesorabilmente legato e perciò
destinato a scomparire con esse. Non è
il caso di riandare qui neppure a linee
sommarie la storia dell 'impiego del ve–
tro nelle varie civiltà e specialmente in
Italia, ave il primato delle vetrerie mu–
ranesi è durato per secoli indiscusso.
"Pezzi
UniCI"
Basti ricordare che l'ultima stagione
creativa in questo campo fu rappresen–
tata all 'inizio del secolo dall'Art Nouveau
nell'ambito della quale, tuttavia, l'Italia
apparve piuttosto a rimorchio
di
un rin–
novamento che si doveva ad altre nazio–
ni: scuola di Nancy con Eugène Rous–
seau e Emile Gallé, poi, sempre in Fran–
cia, Lalique la cui attività si prolunga
oltre la prima guerra mondiale, e per-
60
sino in America: Tiffany. Tanto plU
importante
è
dunque che una nuova sta–
gione veda la ripresa , in senso creativo,
delle vetrerie muranesi in cui la
Fucina
degli Angeli
di Egidio Costantini rap–
presenta l'elemento di punta. Infatti il
vetro della «belle époque» è ancora
il vetro inteso come materia da soffiare,
tagliare o plasmare in forme non sca–
turite dalla stessa natura della sostanza
ma determinate a priori dalla loro uti–
lizzazione e dalle forme tradizionali che
recipienti e oggetti hanno assunto nei
secoli e di cui si viene mutando soltanto
la cadenza decorativa a seconda delle
vicende del gusto. Come materiale pre–
giato, esso serve i bisogni di una classe
ristretta e poiché all'utilizzazione stru–
mentale è sempre destinato non può non
rappresentar l'espressione di un ceto par–
ticolare, i cui mezzi di sussistenza conce–
dono l'impiego di oggetti particolarmen–
te costosi. L'intervento personale dell'ar–
tista si limiterà alla progettazione o alla
decorazione di « servizi» particolarmente
eleganti o alla creazione di « pezzi unici »
che tuttavia rimangono ancora nella sfe-
ra dell'oggetto «decorato ». Tutt'altra
cosa sono questi pezzi che la mostra or–
ganizzata dal Costantini e portata a To–
rino alla galleria Martano da
Nuovi I n–
contri
offre. «Pezzi unici» anche que–
sti, ma come sono pezzi unici un quadro
o una scultura d'autore, dunque posti in
rapporto col pubblico per una fruizione
disinteressata, non strumentale a livello
pratico, posseduti da tutti in quanto spet–
tatori, anche se da pochissimi come pro–
prietari, che è poi la condizione dell'o–
pera d'arte, quadro o statua, nella nostra
società in cui di fatto viviamo, si giudichi
in altra sede questa condizione come ac–
cettabile o necessitante delle trasforma–
zioni profonde. Diverso dunque
il
rap–
porto tra opera e pubblico e diverso an–
che il rapporto tra l'artista e la materia.
Il vetro è diventato, come la tela,
il
bron–
zo o
il
marmo, un campo di possibilità
disponibili in cui l'operatore realizza del–
le scelte a livello di discorso individuale.
Basterà un esempio per spiegarci. Si sa
che Max Ernst è stato uno dei prota–
gonisti di quel movimento surrealista
che, nell'accezione più vasta come in quel
«
L'immortale » di
Max~
Ernst:
nella grande scacchiera, uno dei protagonisti
del movimento surrealista
trasforma gli spezzoni cristallini
in presenze inquietamente evocative
la più ristretta e programmatica del ter–
mine suscita oggi tanto giustificato inte–
resse. Indubbiamente la realizzazione più
imponente della
Fucina degli Angeli
e
l'oggetto che si offre più spettacolar–
mente ai visitatori di questa mostra è la
sua grande scacchiera.
Presenze evocative
Non vi è nulla di accidentale nel fatto
che uno dei massimi maestri del surrea–
lismo abbia trovato nel vetro la materia
ideale per creare un impressionante esem–
pio di «arte-spettacolo» piuttosto che
di « arte-oggetto ». Quanto
il
surrealismo
si proponeva, non il fruimento di un cam–
po circoscritto di dati figurativi ma una
presa diretta sulla coscienza dello spetta–
tore, un'azione psicagogica globale in quel
«punto zero» ave risposta conscia e
reazione inconscia ancora non si diversi–
ficano, è attuato nella grande scacchiera
di Ernst attraverso
il
duplice processo


















