
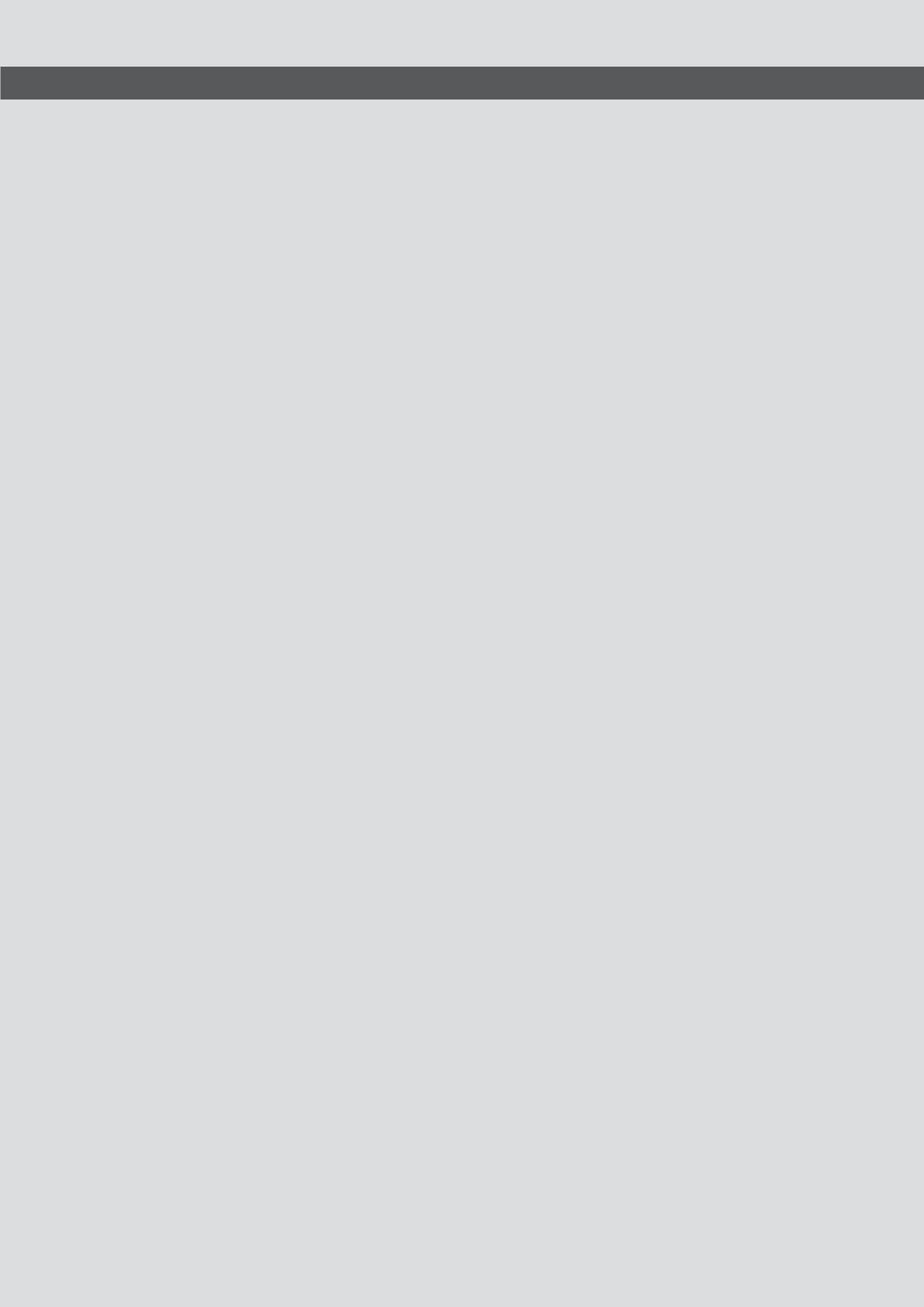
374
La zona di San Paolo ha una propria forte identità, non solo nella connotazione ambientale legata all’architettura, quanto per una
dimensione immateriale, generata dai suoi abitanti, dal loro sentirsi radicati a quel luogo: un luogo in cui loro stessi, o i loro parenti
o i vicini di casa, sono stati nel Novecento i protagonisti della storia del “borgo rosso”, accomunati dalle ideologie politiche e sociali.
Ancor oggi si ritrova quell’atmosfera comunitaria, creata dalle relazioni tra le persone e dal loro modo di vivere gli spazi urbani,
polarizzati dai silenziosi protagonisti della scena socio-ambientale. Il mercato, il negozio, il bar, ma anche la piazza, lo slargo, la via,
sono tutte realtà che accolgono e favoriscono l’incontro, conservando quel radicato rapporto di vicinato, non così frequente in molte
altre zone di Torino prive di una propria storia socio-politica.
Per quanto concerne invece la conformazione urbana odierna della borgata, se ne rileva un’immagine complessivamente caotica,
determinata sia dai molteplici movimenti e suoni nelle strade, sia dalla spazialità, urbana e architettonica, connotata da un impianto
e da un edificato spesso disomogenei. Tale situazione si configura in ogni caso come elemento caratterizzante della borgata,
stranamente gradevole tuttavia per l’autentica vivacità che manifesta nella sua dimensione ambientale.
L’intero territorio di San Paolo è infatti caratterizzato dalla convivenza tra architetture tipologicamente contrastanti: case piccole e
semplici a uno o due piani fuori terra, edifici stilisticamente ricercati (villini e palazzine dei primi decenni del Novecento, spesso di
gusto Liberty o art déco), e palazzi realizzati nella fase di saturazione del settore urbano, dagli anni cinquanta agli anni ottanta del
secolo scorso, che propongono soluzioni volumetriche e cromatiche dissonanti con i caratteri primigeni della borgata. Talemiscellanea
stilistica è ulteriormente frazionata dalla numerosa presenza di case, tra le più antiche, modificate nel tempo da soprelevazioni e
interventi di pelle, che ne hanno snaturato la fisionomia tipologica.
Nell’ampia area costituita da tale tessuto urbano misto, la continuità d’immagine, conferita da edifici con volumetria o tipologia
affine, compare con coerenza solo in brevi tratti, lasciando ampi spazi ad ambienti connotati da una disomogeneità manifesta, che
tuttavia costituisce l’elemento portante per la storia della borgata, formatasi per fasi nel corso del Novecento.
La variabilità diffusa non concerne soltanto l’architettura, bensì anche l’impianto urbanistico. La struttura viaria è infatti impostata
per lo più su tagli radiali e obliqui diversamente direzionati, di collegamento tra i luoghi nodali del tessuto urbano: il fitto intersecarsi
tra tali arterie - importanti sia per l’organizzazione di quella parte di città, sia di connessione con le zone adiacenti - definisce isolati
di dimensione e forma variabile. Tra gli assi viari principali dominano anzitutto gli ampi corsi alberati (Trapani, Ferrucci, Peschiera,
Rosselli e Racconigi, spina dorsale del settore) che caratterizzano l’urbanistica e l’immagine ambientale della borgata, e altrettanto
dominano alcune strade (come le vie Monginevro, Di Nanni, San Paolo) già di antico collegamento tra la città consolidata e i territori
extraurbani, poi integrate nella pianificazione di inizio Novecento.
Il fitto e articolato disegno viario è ulteriormente polarizzato su alcune piazze che sono i poli di un sistema viario radiale, come le
piazze Sabotino e Robilant. Entrambe le piazze costituiscono un fondamentale snodo nella distribuzione stradale, ma si configurano
in modi differenti: la prima si presenta unicamente come un frenetico intersecarsi di percorrenze e non ha alcuno spazio dedicato
all’incontro e alla sosta delle persone, se non i marciapiedi perimetrali; la seconda (perfettamente circolare, con un giardino
baricentrico che ne enfatizza la forma) assolve invece a una duplice funzione, di accoglienza nella zona centrale e di percorrenza
perimetrale.
Tra i numerosi spazi per l’incontro all’aperto, oltre a giardini e aree verdi, assume una particolare funzione la presenza dei mercati,
di antica tradizione in tutta la storia della borgata, che costituiscono una realtà con capacità attrattive notevoli, configurandosi
come luoghi identitari, a livello sia funzionale sia sociale. Il mercato quotidiano di corso Racconigi, uno dei più grandi di Torino,
sviluppandosi lungo gran parte del corso, ne genera una diversa configurazione dell’immagine ambientale durante l’arco della
giornata; mentre quello di via Di Nanni, di dimensioni molto minori, risulta comunque un importante luogo di aggregazione per
un’ampia zona della borgata.
L’ultima via citata, già via Villafranca, si configura come una delle strade di maggiore richiamo, sia per l’intensa attività commerciale del
mercato e dei negozi, sia per la presenza di spazi e luoghi d’incontro, soprattutto nel tratto prospiciente la chiesa di San Bernardino.
L’edificio ecclesiastico, importante fulcro visivo e funzionale, odierno e nella storia della borgata, costituisce per la comunità di
San Paolo un luogo identitario, di aggregazione e di riferimento visivo, come cardine dell’infilata prospettica di via Di Nanni e come
emergenza, un po’ ovunque, con l’alta guglia del suo campanile.
In una borgata dai così diffusi caratteri vitali, per quanto concerne invece una specifica connotazione ambientale, non risulta
praticabile una individuazione generalizzabile, bensì si rende necessario procedere a un esame per singoli settori.
Le vie Di Nanni e Monginevro (oggi le due strade commerciali più attrattive della zona) hanno mantenuto l’antico ruolo primario nella
distribuzione viaria e, insieme ai corsi Peschiera e Racconigi, si differenziano dagli altri assi, sia per la fitta presenza di negozi, sia per il
loro aspetto, caratterizzato da architetture formalmente abbastanza ricercate, pur proponendo ognuno una configurazione propria.
Il tratto delle dette vie a nord di corso Peschiera ha caratteri comuni, con edifici di media altezza (tre-cinque piani), abbastanza
uniformi nella volumetria e nello stile, spesso di gusto Liberty, che creano in molti tratti una cortina continua, interrotta da pochi
edifici incoerenti con l’immagine globale. Entrambe le strade, nel loro sviluppo meridionale, presentano invece un inserimento
più consistente di edifici con caratteri architettonici autonomi e difformi rispetto ai caratteri originari della borgata, creando una
notevole discontinuità dei fronti.
Il corso Peschiera è caratterizzato da una notevole variabilità tra edifici borghigiani di piccola dimensione e alti palazzi più recenti che
ne connotano l’immagine preponderante. Corso Racconigi, invece, è caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali che palesano
una certa ricercatezza formale e stilistica che, abbinata a un contenuto sviluppo in altezza (dai due ai cinque-sei piani), contribuisce a
creare la continuità prevalente delle cortine. Una continuità scandita però dalla presenza di una rete di costruzioni di notevole livello
per la produzione e i servizi: edifici industriali (ora convertiti ad altre funzioni), scuole, quartieri di edilizia popolare, si configurano
come un vero patrimonio dell’architettura della prima metà del Novecento. Un patrimonio che nobilita il tessuto urbano gravitante
sul corso Racconigi, che invece perde quasi completamente ogni connotazione ambientale nel settore occidentale.
RILIEVO URBANO


















