
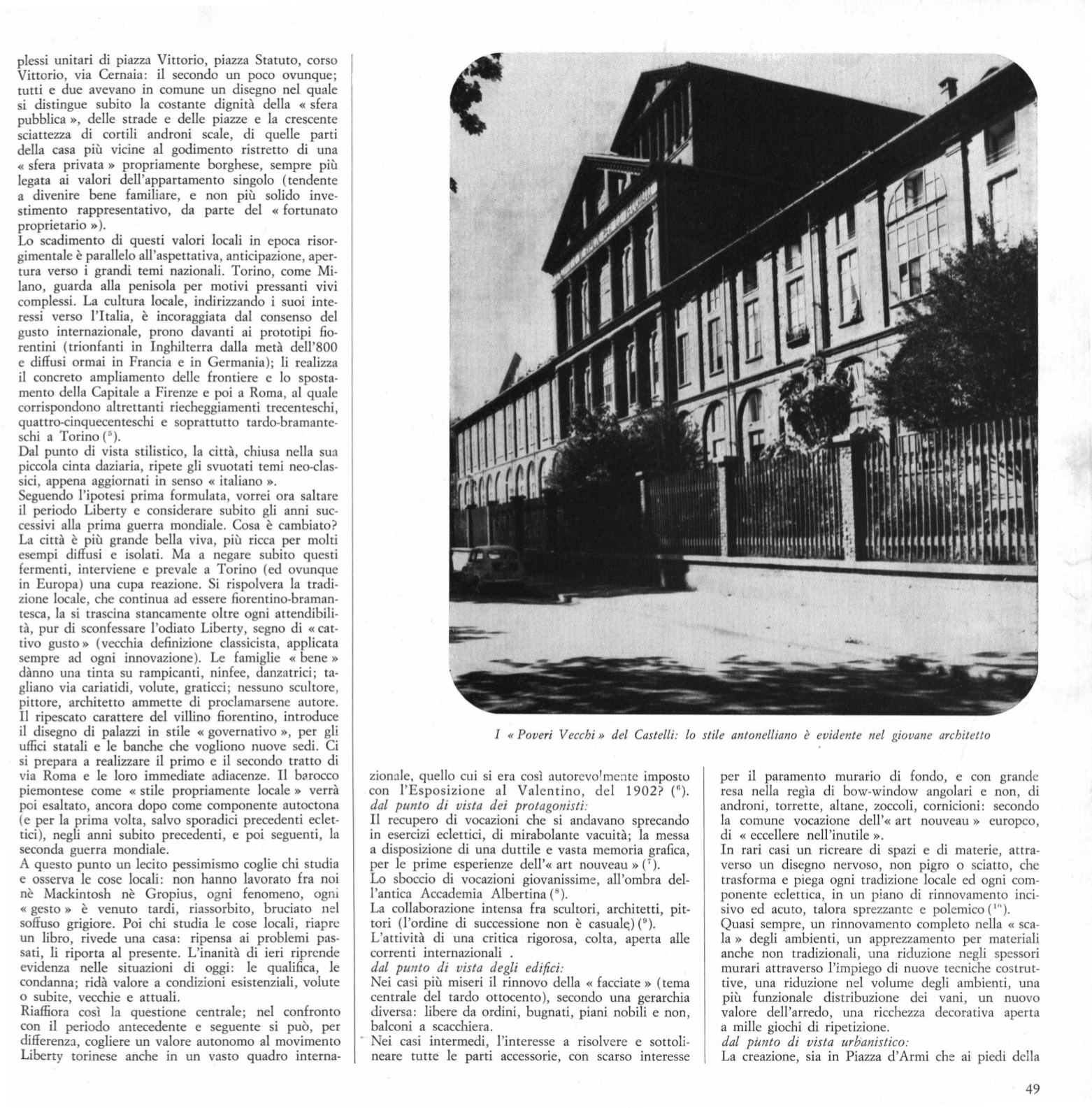
plessi unitari di piazza Vittorio, piazza Statuto, corso
Vittorio, via Cernaia: il secondo un poco ovunque;
tutti e due avevano in comune un disegno nel quale
si distingue subito la costante dignità della «sfera
pubblica », delle strade e delle piazze e la cre¢e
sciattezza di cortili androni scale, di quelle parti
della casa più vicine al godimento ristretto di una
«sfera privata» propriamente borghese, sempre più
legata ai valori dell'appartamento singolo (tendente
a divenire bene familiare, e non più solido inve–
stimento rappresentativo, da parte del «fortunato
proprietario »).
Lo scadimento di questi valori locali in epoca risor–
gimentale è parallelo all'aspettativa, anticipazione, aper–
tura verso i grandi temi nazionali. Torino, come Mi–
lano, guarda alla penisola per motivi pressanti vivi
complessi. La cultura locale, indirizzando i suoi inte–
ressi verso l'Italia, è incoraggiata dal consenso del
gusto internazionale, prono davanti ai prototipi fio–
rentini (trionfanti in Inghilterra dalla metà dell'800
e diffusi ormai in Francia e in Germania); li realizza
il concreto ampliamento delle frontiere e lo sposta–
mento della Capitale a Firenze e poi a Roma, al quale
corrispondono altrettanti riecheggiamenti trecenteschi,
quattro-cinquecenteschi e soprattutto tardo-bramante–
schi a Torino
(5).
Dal punto di vista stilistico, la città, chiusa nella sua
piccola cinta daziaria, ripete gli svuotati temi neo-clas–
sici, appena aggiornati in senso « italiano ».
Seguendo l'ipotesi prima formulata, vorrei ora saltare
il periodo Liberty e considerare subito gli anni suc–
cessivi alla prima guerra mondiale. Cosa è cambiato?
La città è più grande bella viva, più ricca per molti
esempi diffusi e isolati. Ma a negare subito questi
fermenti, interviene e prevale a Torino (ed ovunque
in Europa) una cupa reazione . Si rispolvera la tradi–
zione locale, che continua ad essere fiorentino-braman–
tesca, la si trascina stancamente oltre ogni attendibili–
tà, pur di sconfessare l'odiato Liberty, segno di «cat–
tivo gusto» (vecchia definizione classicista, applicata
sempre ad ogni innovazione). Le famiglie «bene»
dànno una tinta su rampicanti, ninfee, danzatrici; ta–
gliano via cariatidi, volute, graticci; nessuno scultore,
pittore, architetto ammette di proclamarsene autore.
Il ripescato carattere del villino fiorentino, introduce
il disegno di palazzi in stile «governativo », per gli
uffici statali e le banche che vogliono nuove sedi. Ci
si prepara a realizzare il primo e il secondo tratto di
via Roma e le loro immediate adiacenze. Il barocco
piemontese come «stile propriamente locale» verrà
poi esaltato, ancora dopo come componente autoctona
(e per la prima volta, salvo sporadici precedenti eclet–
tici), negli anni subito precedenti, e poi seguenti, la
seconda guerra mondiale.
A questo punto un lecito pessimismo coglie chi studia
e osserva le cose locali: non hanno lavorato fra noi
nè Mackintosh nè Gropius, ogni fenomeno, ogni
« gesto» è venuto tardi, riassorbito, bruciato nel
soffuso grigiore. Poi chi studia le cose locali, riapre
un libro, rivede una casa: ripensa ai problemi pas–
sati,
li
riporta al presente. L'inanità di ieri riprende
evidenza nelle situazioni di oggi: le qualifica, le
condanna; ridà valore a condizioni esistenziali, volute
o subite, vecchie e attuali.
Riaffiora così la questione centrale; nel confronto
con il periodo antecedente e seguente si può, per
differenza, cogliere un valore autonomo al movimento
Liberty torinese anche in un vasto quadro interna-
I «Poveri Vecchi» del Castelli: lo stile antonelliano è evidente nel giovane architetto
zionale, quello cui si era così autorevolmente imposto
con l'Esposizione al Valentino, del 1902?
(6).
dal punto di vista dei protagonisti:
Il recupero di vocazioni che si andavano sprecando
in esercizi eclettici, di mirabolante vacuità; la messa
a disposizione di una duttile e vasta memoria grafica,
per le prime esperienze dell'« art nouveau» (').
Lo sboccio di vocazioni giovanissime, all'ombra del–
l'antica Accademia Albertina
(8).
La collaborazione intensa fra scultori, architetti, pit–
tori (l'ordine di successione non è
casblal~)
e).
L'attività di una critica rigorosa, colta, aperta alle
correnti internazionali .
dal punto di vista degli edifici:
Nei casi più miseri il rinnovo della « facciate» (tema
centrale del tardo ottocento), secondo una gerarchia
diversa: libere da ordini, bugnati, piani nobili e non,
balconi a scacchiera.
• Nei casi intermedi, l'interesse a risolvere e sottoli–
neare tutte le parti accessorie, con scarso interesse
per il paramento murario di fondo, e con grande
resa nella regìa di bow-window angolari e non, di
androni, torrette, altane, zoccoli, cornicioni: secondo
la comune vocazione dell'« art nouveau» europco,
di «eccellere nell'inutile ».
In rari casi un ricreare di spazi e di materie, attra–
verso un disegno nervoso, non pigro o sciatto, che
trasforma e piega ogni tradizione locale ed ogni com–
ponente eclettica, in un piano di rinnovamento inci–
sivo ed acu to, talora sprezzante e polemico (''').
Quasi sempre, un rinnovamento completo nella « sca–
la» degli ambienti, un apprezzamento per materiali
anche non tradizionali, una riduzione negli spessori
murari attraverso l'impiego di nuove tecniche costrut–
tive, una riduzione nel volume degli ambienti, una
più funzionale distribuzione dei vani, un nuovo
valore dell'arredo, una ricchezza decorativa aperta
a mille giochi di ripetizione.
dal punto di vista urbanistico:
La creazione, sia in Piazza d'Armi che ai piedi della
49


















