
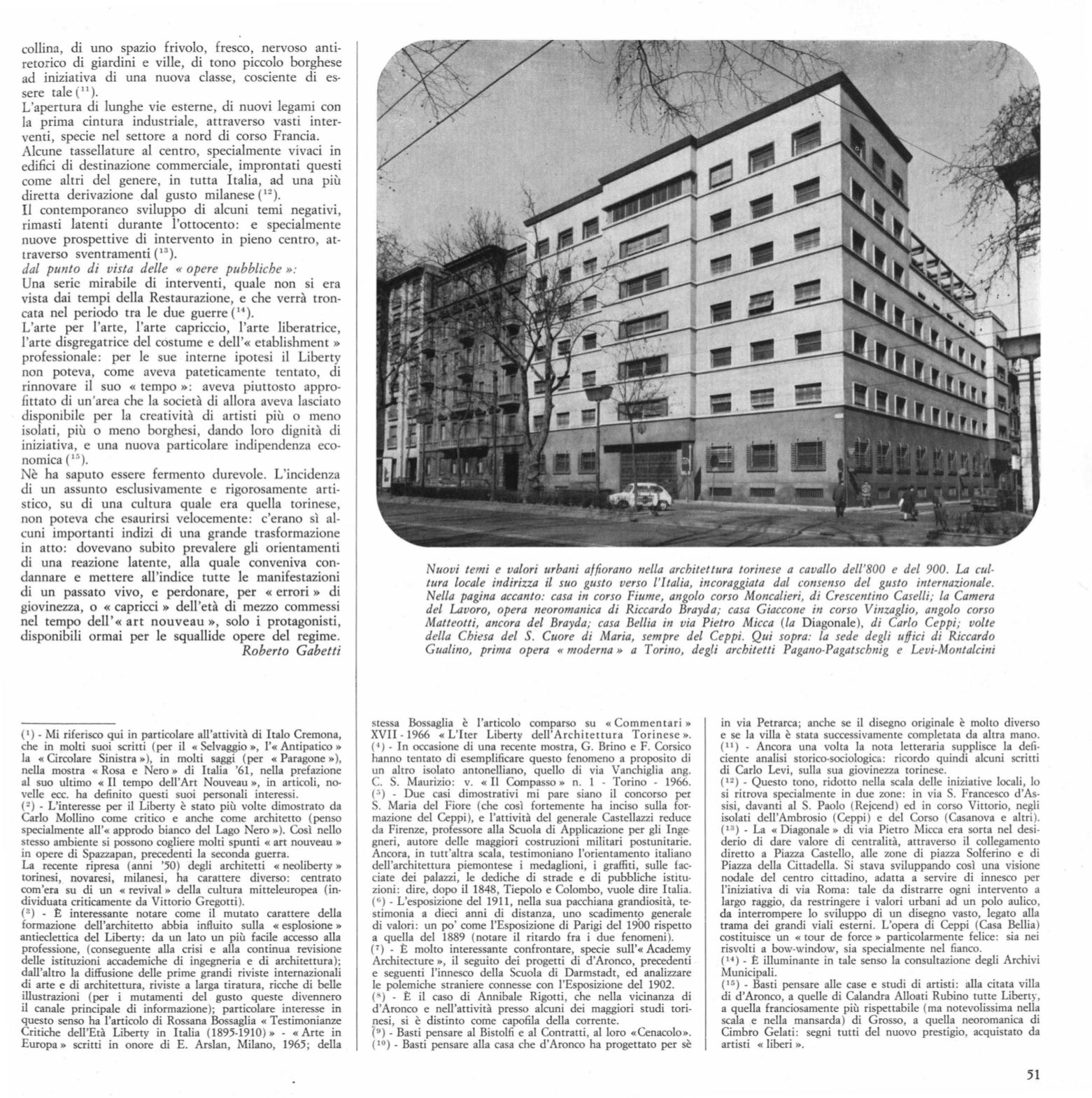
collina, di uno spazio frivolo, fresco, nervoso anti–
retorico di giardini e ville, di tono piccolo borghese
ad iniziativa di una nuova classe, cosciente di es–
sere tale (" )_
L'apertura di lunghe vie esterne, di nuovi legami con
la prima cintura industriale, attraverso vasti inter–
venti, specie nel settore a nord di corso Francia_
Alcune tassellature al centro, specialmente vivaci in
edifici di destinazione commerciale, improntati questi
come altri del genere, in tutta Italia, ad una più
diretta derivazione dal gusto milanese
('2)_
Il
contemporaneo sviluppo di alcuni temi negativI,
rimasti latenti durante l'ottocento : e specialmente
nuove prospettive di intervento in pieno centro, at–
traverso sventramenti
('3)_
dal punto di vista delle «opere pubbliche
» :
Una serie mirabile di interventi, quale non si era
vista dai tempi della Restaurazione, e che verrà tron–
cata nel periodo tra le due guerre
(14)_
L'arte per l'arte, l'arte capriccio, l'arte liberatrice,
l'arte disgregatrice del costume e dell'« etablishment »
professionale: per le sue interne ipotesi il Liberty
non poteva, come aveva pateticamente tentato, di
rinnovare il suo «tempo »: aveva piuttosto appro–
fittato
di
un'area che la società di allora aveva lasciato
disponibile per la creatività di artisti più o meno
isolati, più o meno borghesi, dando loro dignità di
iniziativa, e una nuova particolare indipendenza eco–
nomica
(15 )_
Nè
ha saputo essere fermento durevole _ L'incidenza
di un assunto esclusivamente e rigorosamente arti–
stico, su di una cultura quale era quella torinese ,
non poteva che esaurirsi velocemente : c'erano sì al–
cuni importanti indizi di una grande trasformazione
in atto: dovevano subito prevalere gli orientamenti
di una reazione latente, alla quale conveniva con–
dannare e mettere all'indice tutte le manifestazioni
di un passato vivo, e perdonare, per «errori» di
giovinezza, o «capricci» dell'età di mezzo commessi
nel tempo dell'« art nouveau », solo
i
protagonisti,
disponibili ormai per le squallide opere del regime_
Roberto Gabetti
(1) -
Mi riferisco qui in particolare all'attività di Italo Cremona,
che in molti suoi scritti (per il «Selvaggio », 1'« Antipatico
»
la «Circolare Sinistra»), in molti saggi (per «Paragone»),
nella mostra « Rosa e Nero » di Italia '61, nella prefazione
al suo ultimo «Il tempo dell'Art Nouveau
»,
in articoli, no–
velle ecc. ha definito questi suoi personali interessi.
(2) _
L'interesse per il Liberty è stato più volte dimostrato da
Carlo Mollino come critico e anche come architetto (penso
specialmente all'« approdo bianco del Lago Nero »)_ Cos1 nello
stesso ambiente si possono cogliere molti spunti « art nouveau »
in opere di Spazzapan, precedenti la seconda guerra.
La recente ripresa (anni '50) degli architetti «neoliberty»
torinesi, novaresi, milanesi, ha carattere diverso: centrato
com'era su di un «revival» della cultura mitteleuropea (in–
dividuata criticamente da Vittorio Gregotti).
(3) _
È
interessante notare come il mutato carattere della
formazione dell'architetto abbia influito sulla «esplosione»
antieclettica del Liberty: da un lato un più facile accesso alla
professione, (conseguente alla crisi e alla continua revisione
delle istituzioni accademiche di ingegneria e di architettura);
dall'altro la diffusione delle prime grandi riviste internazionali
di
arte e di architettura, riviste a larga tiratura, ricche di belle
illustrazioni (per i mutamenti del gusto queste divennero
il canale principale di informazione); particolare interesse
in
questo senso ha l'articolo di Rossana Bossaglia « Testimonianze
Critiche dell'Età Liberty in Italia (1895-1910)>> - «Arte in
Europa» scritti in onore di E. Arslan, Milano, 1965; della
Nuovi temi e valori urbani affiorano nella architettura torinese a cavallo dell'800 e del 900. La cul–
tura locale indirizza il suo gusto verso l'Italia, incoraggiata dal consenso del gusto internazionale.
Nella pagina accanto: casa in corso Fiume, angolo corso Moncalieri, di Crescentino Caselli; la Camera
del Lavoro, opera neoromanica di Riccardo Brayda; casa Giaccone in corso Vinzaglio, angolo corso
Matteotti, ancora del Brayda; casa BelZia in via Pietro Micca (la
Diagonale),
di Carlo Ceppi; volte
della Chiesa del
S.
Cuore di Maria, sempre del Ceppi. Qui sopra: la sede degli uffici di Riccardo
Gualino, prima opera «moderna» a Torino, degli architetti Pagano-Pagatschnig e Levi-Montalcini
stessa Bossaglia è l'articolo comparso su «Commentari »
XVII -1966 «L'Iter Liberty dell'Architettura Torinese ».
(,l) _
In occasione di una recente mostra, G. Brino e F. Corsico
hanno tentato di esemplificare questo fenomeno a proposito di
un altro isolato antonelliano, quello di via Vanchiglia ang.
C.
S. Maurizio: v. «Il Compasso» n. 1 - Torino - 1966.
(;;) - Due casi dimostrativi mi pare siano il concorso per
S. Maria del Fiore (che cosÌ fortemente ha inciso sulla for–
mazione del Ceppi), e l'attività del generale Castellazzi reduce
da Firenze, professore alla Scuola di Applicazione per gli Inge·
gneri, autore delle maggiori costruzioni militari postunitarie.
Ancora, in tutt'altra scala, testimoniano l'orientamento italiano
dell'architettura piemontese i medaglioni, i graffiti, sulle fac–
ciate dei palazzi, le dediche di strade e di pubbliche istitu–
zioni: dire, dopo il 1848, Tiepolo e Colombo, vuole dire Italia.
(6) _
L'esposizione del 1911, nella sua pacchiana grandiosità, te–
stimonia a dieci anni di distanza, uno
scadiment~
generale
di valori: un po' come l'Esposizione di Parigi del 1900 rispetto
a quella del 1889 (notare il ritardo fra i due fenomeni).
(7) _
È
molto interessante confrontare, specie sull'« Academy
Architecture », il seguito dei progetti di d'Aronco, precedenti
e seguenti l'innesco della Scuola di Darmstadt, ed analizzare
le polemiche straniere connesse con l'Esposizione del 1902.
(8) _
È
il caso di Annibale Rigotti, che nella vicinanza di
d'Aronco e nell'attività presso alcuni dei maggiori studi tori–
nesi, si è distinto come capofila della corrente.
(9 ) _
Basti pensare al Bistolfi e al Contratti, alloro «Cenacolo».
(IO) -
Basti pensare alla casa che d'Aronco ha progettato per sè
in via Petrarca; anche se il disegno originale
è
molto diverso
e se la villa è stata successivamente completata da altra mano.
(11) _
Ancora una volta la nota letteraria supplisce la defi–
ciente analisi storico-sociologicli: ricordo quindi alcuni scritti
di
Carlo Levi, sulla sua giovinezza torinese.
(12) -
Questo tono, ridotto nella scala delle iniziative locali, lo
si ritrova specialmente in due zone: in via S. Francesco d'As–
sisi, davanti al S. Paolo (Rejcend) ed in corso Vittorio, negli
isolati dell'Ambrosio (Ceppi) e del Corso (Casanova e altri).
('3) _
La « Diagonale » di via Pietro Micca era sorta nel desi–
derio di dare valore di centralità, attraverso il collegamento
diretto a Piazza Castello, alle zone di piazza Solferino e di
Piazza della Cittadella. Si stava sviluppando cos1 una visione
nodale del centro cittadino, adatta a servire di innesco per
l'iniziativa di via Roma: tale da distrarre ogni intervento a
largo raggio, da restringere i valori urbani ad un polo aulico,
da interrompere lo sviluppo di un disegno vasto, legato alla
trama dei grandi viali esterni. L'opera di Ceppi (Casa Bellia)
costituisce un « tour de farce » particolarmente felice: sia nei
risvolti a bow-window, sia specialmente nel fianco.
(14) _
È
illuminante in tale senso la consultazione degli Archivi
Municipali.
(15) _
Basti pensare alle case e studi di artisti: alla citata villa
di d'Aronco, a quelle di Calandra Alloati Rubino tutte Liberty,
a quella franciosamente più rispettabile (ma notevolissima nella
scala e nella mansarda) di Grosso, a quella neoromanica di
Cimbro Gelati: segni tutti del nuovo prestigio, acquistato da
artisti « liberi ».
51


















