
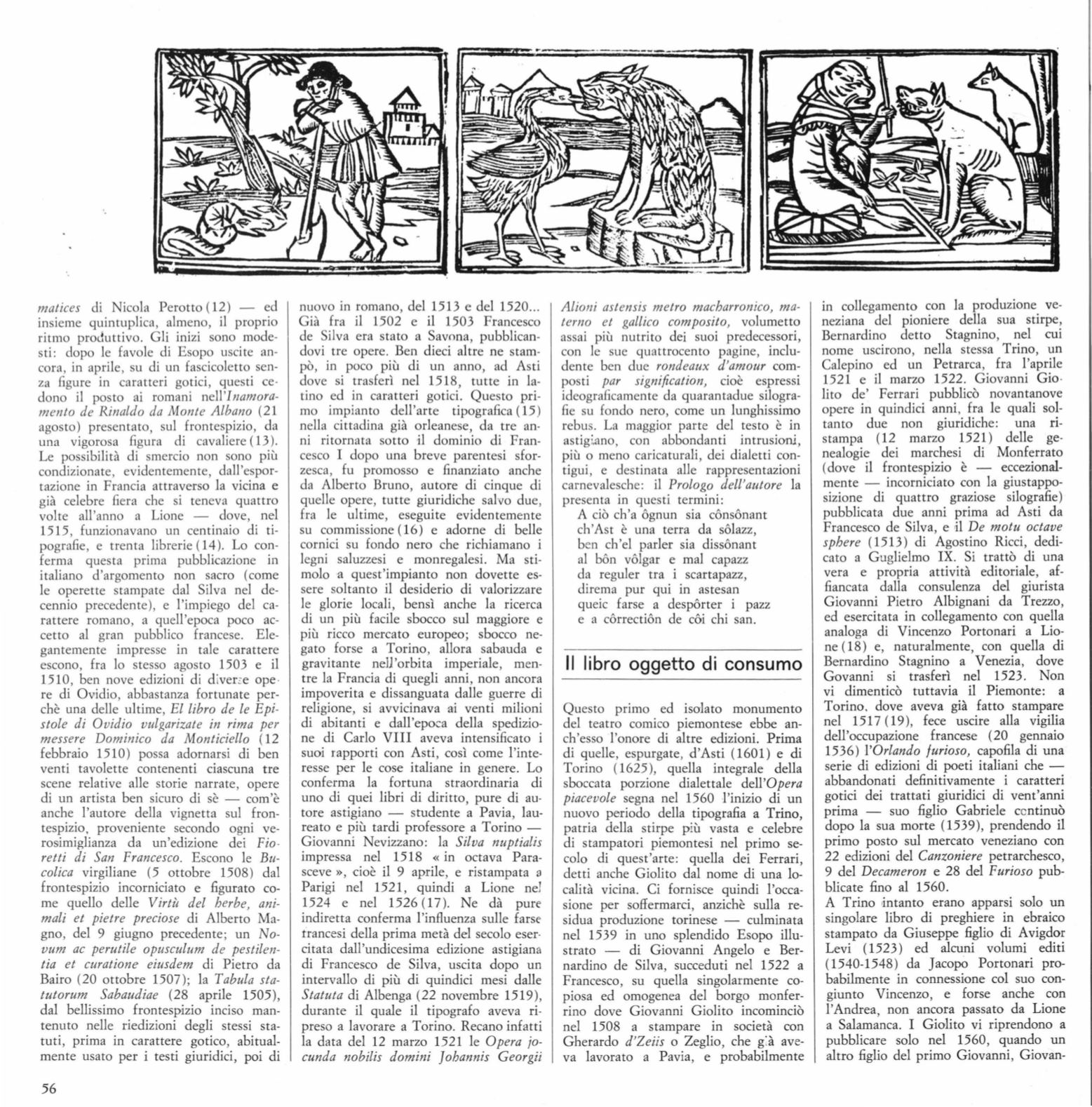
matices
di Nicola Perotto (12) - ed
insieme quintuplica, almeno, il proprio
ritmo produttivo. Gli inizi sono mode–
sti: dopo le favole di Esopo uscite an–
cora, in aprile, su di un fascicoletto sen–
za figure in caratteri gotici, questi ce·
dono il posto ai romani
nell'Inamora–
mento de Rinaldo da Monte Albano (21
agosto) presentato, sul frontespizio, da
una vigorosa figura di cavaliere (13) .
Le possibilità di smercio non sono più
condizionate, evidentemente, dall'espor–
tazione in Francia attraverso la vicina e
già celebre fiera che si teneva quattro
volte all'anno a Lione - dove , nel
1515, funzionavano un centinaio di ti–
pograne , e trenta librerie (14). Lo con–
ferma questa prima pubblicazione in
italiano d'argomen to non sacro (come
le operette stampate dal Silva nel de–
cennio precedente) , e l'impiego del ca–
rattere romano, a quell'epoca poco ac–
cetto al gran pubblico francese. Ele–
gantemente impresse in tale carattere
escono, fra lo stesso agosto 1503 e il
1510, ben nove edizioni di d iver::e ope
re di Ovidio, abbastanza fortunate per–
chè una delle ultime,
El libro de le Epi–
stole di Ovidio vulgarizate in rima per
messere Dominica da Monticiello
(1 2
febbraio 1510) possa adornarsi di ben
venti tavolette contenenti ciascuna tre
scene relative alle storie narrate, opere
di un artista ben sicuro di sè - com'è
anche l'autore della vignetta sul fron–
tespizio, proveniente secondo ogni ve–
rosimiglianza da un'edizione dei
Fio ·
retti di San Francesco.
Escono le
Bu–
colica
virgiliane (5 ottobre 1508) dal
frontespizio incorniciato e figurato co–
me quello delle
Virtù del herbe, ani–
mali et pietre preciose
di Alberto Ma–
gno, del 9 giugno precedente ; un
No–
vum ac perutile opusculum de pestilen–
tia et curatione eiusdem
di Pietro da
Bairo (20 ottobre 1507); la
Tabula sta–
tutorum Sabaudiae
(28 aprile 1505),
dal bellissimo frontespizio inciso man–
tenuto nelle riedizioni degli stessi sta–
tuti , prima in carattere gotico , abitual–
mente usato per i testi giuridici, poi di
56
nuovo in romano, del 1513 e del 1520.. .
Già fra il 1502 e il 1503 Francesco
de Silva era stato a Savona, pubblican–
dovi tre opere. Ben dieci altre ne stam–
pò, in poco più di un anno, ad Asti
dove si trasferÌ nel 1518, tutte in la–
tino ed in caratteri gotici. Questo pri–
mo impianto dell'arte tipografica (15)
nella cittadina già orleanese, da tre an–
ni ritornata so tto
il
dominio di Fran–
cesco I dopo una breve parentesi sfor–
zesca, fu promosso e finanziato anche
da Alberto Bruno, autore di cinque di
quelle opere, tutte giuridiche salvo due,
fra le ultime , eseguite evidentemente
su commissione (16) e adorne di belle
cornici su fondo nero che richiamano i
legni saluzzesi e monregalesi. Ma sti–
molo ·a quest'impianto non dovette es–
sere soltanto il desiderio di valorizzare
le glorie locali , bensì anche la ricerca
di un più facile sbocco sul maggiore e
più ricco mercato europeo; sbocco ne–
ga to forse a Torino, allora sabauda e
gravitante nell'orbita imperiale, men–
tre la Francia di quegli anni, non ancora
impoverita e dissanguata dalle guerre di
religione, si avvicinava ai venti milioni
di abitanti e dall'epo::a della spedizio–
ne di Carlo VIII aveva intensificato i
suoi rapporti con Asti, così come l'inte–
resse per le cose italiane in genere. Lo
conferma la fortuna straordinaria di
uno di quei libri di diritto, pure di au–
tore astigiano - studente a Pavia, lau–
rea to e più tardi professore a Torino -
Giovanni Nevizzano : la
Silva nuptialis
impressa nel 1518 « in octava Para–
sceve »,cioè il 9 aprile , e ristampata a
Parigi nel 1521 , quindi a Lione nel
1524 e nel 1526 (17 ). Ne dà pure
indiretta conferma l 'influenza sulle farse
trancesi della prima metà del secolo eser·
citata dall 'undicesima edizione astigiana
di Francesco de Silva, usci ta dopo un
intervallo di più di quindici mesi dalle
Statuta
di Albenga (22 novembre 1519),
duran te
il
quale
il
tipografo aveva ri·
preso a lavorare a Torino. Recano infatti
la data del 12 marzo 1521 le
Opera jo–
cunda nobilis domini
]
ohannis Georgii
Alioni astensis metro macharronico, ma–
terno et gallico composito,
volumetto
assai più nutri to dei suoi predecessori,
con le sue quattrocento pagine, inclu–
dente ben due
rondeaux d'amour
com–
posti
par signification,
cioè espressi
ideograncamente da quarantadue silogra–
ne su fondo nero, come un lunghissimo
rebu s. La maggior parte del testo è in
astigi,ano, con abbondanti intrusion.i,
più o meno carica turali, dei dialetti con–
tigui, e destinata alle rappresentazioni
carnevalesche: il
Prologo dell'autore
la
presenta in questi termini:
A ciò ch'a agnun sia cansanant
ch'Ast è una terra da salazz,
ben ch'el parler sia dissanant
al ban valgar e mal capazz
da reguler tra i scartapazz,
direma pur qui in astesan
queic farse a desparter i pazz
e a carrectian de còi chi san.
Il libro oggetto di consumo
Questo primo ed isolato monumento
del tea tro comico piemontese ebbe an–
ch'esso l'onore di altre edizioni. Prima
di quelle, espurgate, d'Asti (1601) e di
Torino (1625), quella integrale della
sboccata porzione dialettale
dell'Opera
piacevole
segna nel 1560 -l'inizio di un
nuovo periodo della tipografia a Trino,
patria della stirpe più vasta e celebre
di stampatori piemontesi nel primo se–
colo di ques t'arte: quella dei Ferrari,
detti anche Giolito dal nome di una lo–
calità vicina. Ci fornisce quindi l'occa–
sione per sofIermarci, anzichè sulla re–
sidua produzione torinese - culminata
nel 1539 in uno splendido Esopo illu–
strato - di Giovanni Angelo e Ber–
nardino de Silva, succeduti nel 1522 a
Francesco, su quella singolarmente co–
piosa ed omogenea del borgo monfer–
rino dove Giovanni Giolito incominciò
nel 1508 a stampare in società con
Gherardo
d'Zeiis
o Zeglio, che g:à ave–
va lavorato a Pavia, e probabilmente
in collegamento con la produzione ve–
neziana del pioniere della sua stirpe,
Bernardino detto Stagnino, nel cui
nome uscirono, nella stessa Trino, un
Calepino ed un Petrarca, fra l'aprile
1521 e il marzo 1522. Giovanni Gio ·
lito de' Ferrari pubblicò novantanove
opere in quindici anni , fra le quali sol–
tanto due non giuridiche: una ri–
stampa (12 marzo 1521) delle geo
nealogie dei marchesi di Monferrato
(dove il frontespizio è - eccezional–
mente - incorniciato con la giustappo–
sizione di quattro graziose silografie)
pubblicata due anni prima ad Asti da
Francesco de Silva, e
il
De motu octave
sphere
(1513) di Agostino Ricci, dedi–
cato a Guglielmo IX. Si trattò di una
vera e propria attività editoriale, af–
fiancata dalla consulenza del giurista
Giovanni Pietro Albignani da T rezzo,
ed esercitata in collegamento con quella
analoga di Vincenzo Portonari a Lio–
ne (18) e, naturalmente, con quella di
Bernardino Stagnino a Venezia, dove
Govanni si trasferl nel 1523 . Non
vi dimenticò tuttavia il Piemonte: a
Torino. dove aveva già fatto stampare
nel 1517 (19), fece uscire alla vigilia
dell'occupazione francese (20 gennaio
1536) l'Orlando furioso,
capofila di una
serie di edizioni di poeti italiani che -
abbandonati definitivamente i caratteri
gotici dei trattati giuridici di vent'anni
prima - suo figlio Gabriele ccntinuò
dopo la sua morte (1539), prendendo
il
primo posto sul mercato veneziano con
22 edizioni del
Canzoniere
petrarchesco,
9 del
Decameron
e 28 del
Furioso
pub–
blicate fino al 1560.
A Trino ,intanto erano apparsi solo un
singolare libro di preghiere in ebraico
stampato da Giuseppe figlio di Avigdor
Levi (1523) ed alcuni volumi editi
(1540-1548) da JacopO Portonari pro–
babilmente in connessione col suo con–
giunto Vincenzo, e forse anche con
l'Andrea, non ancora passato da Lione
a Salamanca. I Gialito vi riprendono a
pubblicare solo nel 1560, quando un
altro figlio del primo Giovanni, Giovan-


















