
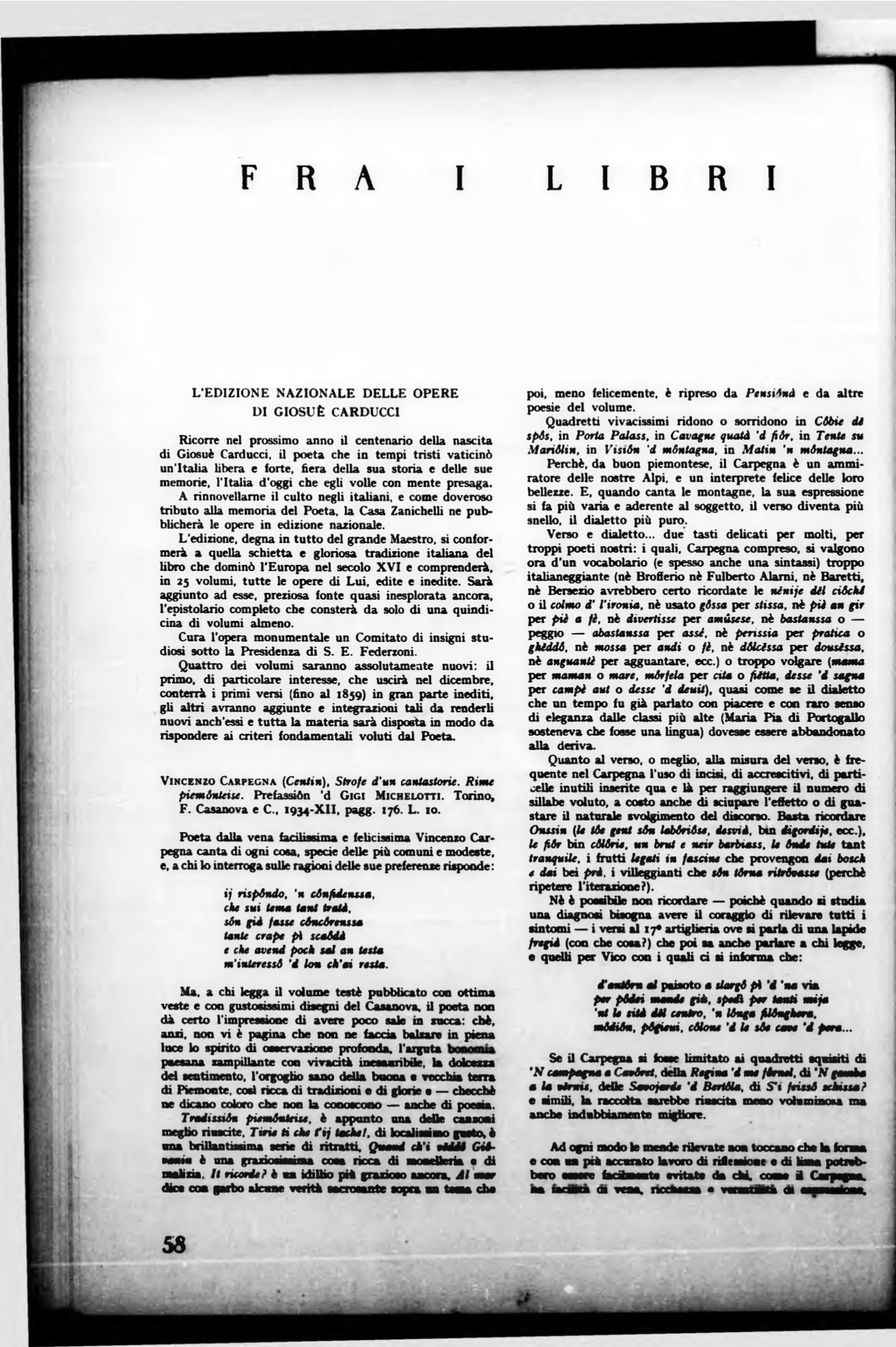
F R A
I
L I B R I
L ’EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE
DI GIOSUÈ CARDUCCI
Ricorre nel prossimo anno il centenario della nascita
di Giosuè Carducci, il poeta che in tempi tristi vaticinò
un'Italia libera e forte, fiera della sua storia e delle sue
memorie, l’Italia d’oggi che egli volle con mente presaga.
A rinnovellame il culto negli italiani, e come doveroso
tributo alla memoria del Poeta, la Casa Zanichelli ne pub
blicherà le opere in edizione nazionale.
L'edizione, degna in tutto del grande Maestro, si confor
merà a quella schietta e gloriosa tradizione italiana del
libro che dominò l’Europa nel secolo XVI e comprenderà,
in 25 volumi, tutte le opere di Lui, edite e inedite. Sarà
aggiunto ad esse, preziosa fonte quasi inesplorata ancora,
l’epistolario completo che consterà da solo di una quindi
cina di volumi almeno.
Cura l'opera monumentale un Comitato di insigni stu
diosi sotto la Presidenza di S. E. Federzoni.
Quattro dei volumi saranno assolutamente nuovi: il
primo, di particolare interesse, che uscirà nel dicembre,
conterrà i primi versi (fino al 1859) in gran parte inediti,
gli altri avranno aggiunte e integrazioni tali da renderli
nuovi anch’essi e tutta la materia sarà disposta in modo da
rispondere ai criteri fondamentali voluti dal Poeta.
Vincenzo Carpegna
(Ceniin), Strofe d'un cantastorie. Rime
piemónteise.
Prefassiòn ’d Gigi Michelotti. Torino,
F. Casanova e C., 1934-XII, pagg. 176. L. 10.
Poeta dalla vena facilissima e felicissima Vincenzo Car
pegna canta di ogni cosa, specie delle più comuni e modeste,
e, a chi lo interroga sulle ragioni delle sue preferenze risponde:
ij rispóndo, ’n cónfdenssa,
che
sui
tema tant tratà,
són già fosse c&ncórenssa
tante crape pi scaódà
e che avend poch sai an testa
m’interessi ’i lon ch’ai resta.
Ma. a chi legga il volume testé pubblicato con ottima
veste e con gustosissimi disegni del Casanova, il poeta non
dà certo l'impressione di avere poco sale in zucca: cbè,
anzi, non vi è pagina che non ne faccia balzare in piena
luce Io spirito di osservazione profonda, l'arguta
paesana zampillante con vivacità inesauribile, la dolcezza
del sentimento, l’orgoglio sano della buona e vecchia tetra
di Piemonte, cosi ricca di tradizioni e di glorie e — checché
ne dicano coloro che non la conoscono — anche di poesia.
Tradissión piemónteise,
è appunto una delle canzoni
meglio riuscite,
Tùie
h
che f i j ticket,
di loraliwimo gusto,è
una brillantissima serie di ritratti,
Quetnd
ch’i
viddó
Gió
vani*
è una graziosissima cosa ricca di monelleria e di
maliria.
It ricorde?
è un idillio più grazioso ancora.
A l mm
dice con garbo alcune verità sacrosante sopra aa tana chc
poi, meno felicemente, è ripreso da
Pensionò
e da altre
poesie del volume.
Quadretti vivacissimi ridono o sorridono in
Cóbie di
spós,
in
Porta Palass,
in
Cavagne quatà ’d fiór,
in
Tente
su
Mariólin,
in rsstdw
’d móntagna,
in
Matin ’n móntagna...
Perchè, da buon piemontese, il Carpegna è un ammi
ratore delle nostre Alpi, e un interprete felice delle loro
bellezze. E, quando canta le montagne, la sua espressione
si fa più varia e aderente al soggetto, il verso diventa più
snello, il dialetto più puro.
Verso e dialetto... due tasti delicati per molti, per
troppi poeti nostri: i quali, Carpegna compreso, si valgono
ora d’un vocabolario (e spesso anche una sintassi) troppo
italianeggiante (nè Brofferio nè Fulberto Alami, nè Baretti,
nè Bersezio avrebbero certo ricordate le
ninije dii cióchi
o il
colmo d'l'ironia,
nè usato
góssa
per
stissa,
nè
pii an gir
per
p ii a fi,
nè
divertisse
per
amùsese,
nè
bastanssa
o —
peggio —
abastanssa
per
assi,
nè
perissia
per
pratica
o
ghiddó,
nè
mossa
per
andi o fi,
nè
dólcissa
per
dousissa,
nè
anguanti
per agguantare, ecc.) o troppo volgare
(marna
per
maman o mare, mórfela
per
cita
o
pitta, desse ’d sagno
per
campi aut o desse ’d deuit),
quasi come se il dialetto
che un tempo fu già parlato con piacere e con raro senso
di eleganza dalle classi più alte (Maria Pia di Portogallo
sosteneva che fosse una lingua) dovesse essere abbandonato
alla deriva.
Quanto al verso, o meglio, alla misura del verso, è fre
quente nel Carpegna l’uso di incisi, di accrescitivi, di parti-
celle inutili inserite qua e là per raggiungere il numero di
sillabe voluto, a costo anche di sciupare l’effetto o di gua
stare il naturale svolgimento del discorso. Basta ricordare
Onssin
(le tóe geni són labórióse, desiti
I, bin
digordije,
ecc.),
le fiór
bin
cólórie, un brut e neir barbiass, le ónde tute
tant
tranquile,
i frutti
legati
tu
fascine
che provengon
dai bosch
e dai
bei
prà,
i villeggianti che
són tóma ritróviuse
(perchè
ripetere l’iterazione?).
Nè è possibile non ricordare — poiché quando si studia
una diagnosi bisogna avere il coraggio di rilevare tutti i
sintomi — i versi al 17° artiglieria ove si parla di una lapide
fregiò
(con che cosa?) che poi sa anche parlare a chi legge,
e quelli per Vico con i quali d si informa che:
d’antón al
paisoto
a slargò pi ’d ’na
via
per pódei monde già, spedì por tonti màjo
’nt le s iti dii centro, ’n lóngo filónghera,
módión, pógieui. Mone ’d le site cene ’d poro...
Se il Carpegna si fosse limitato ai quadretti squisiti di
’N compagno 0 Cavóret,
della
Regino ’d me fóruel,
di
’N gambo
o lo viruts,
delle
Savoiarde ’d Bertóla,
di S*t
feissó sckisso?
e simili, la raccolta sarebbe riuscita meno voluminosa ma
anche indubbiamente migliore.
Ad ogni modo le mende rilevate non toccano che la forma
e con un più accurato lavoro di riflessione e di lima potreb
bero essere facilmente evitate da dà, come fl Carpegna.
u t ucmtm ai m a , nccnessa • w n su x ta di
m v q m o m
,
58


















