
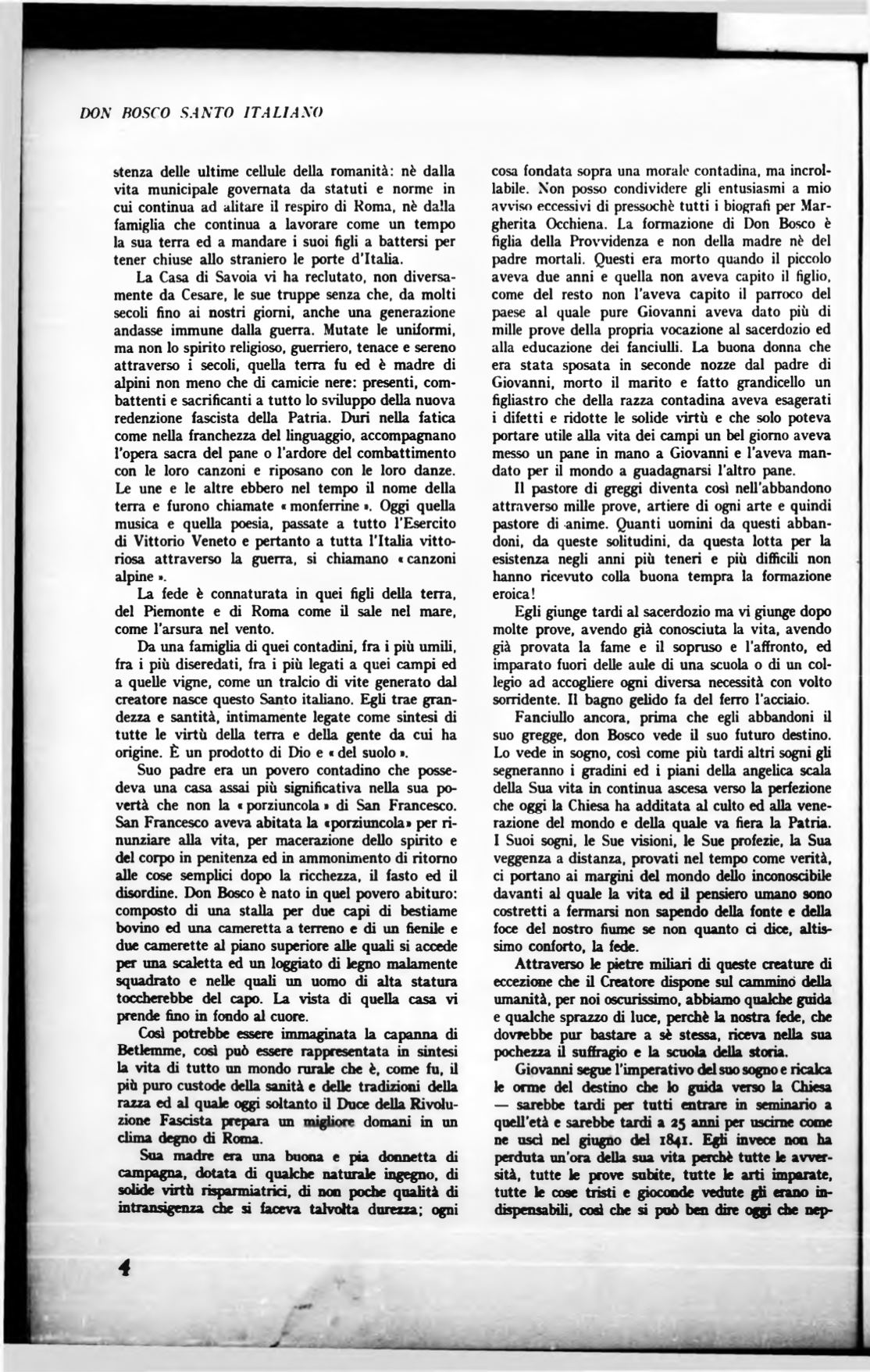
DON ROSCO SANTO ITAL IANO
stenza delle ultime cellule della romanità: nè dalla
vita municipale governata da statuti e norme in
cui continua ad alitare il respiro di Roma, nè dalla
famiglia che continua a lavorare come un tempo
la sua terra ed a mandare i suoi figli a battersi per
tener chiuse allo straniero le porte d’Italia.
La Casa di Savoia vi ha reclutato, non diversa-
mente da Cesare, le sue truppe senza che, da molti
secoli fino ai nostri giorni, anche una generazione
andasse immune dalla guerra. Mutate le uniformi,
ma non lo spirito religioso, guerriero, tenace e sereno
attraverso i secoli, quella terra fu ed è madre di
alpini non meno che di camicie nere: presenti, com
battenti e sacrificanti a tutto lo sviluppo della nuova
redenzione fascista della Patria. Duri nella fatica
come nella franchezza del linguaggio, accompagnano
l’opera sacra del pane o l’ardore del combattimento
con le loro canzoni e riposano con le loro danze.
Le une e le altre ebbero nel tempo il nome della
terra e furono chiamate «monferrine ». Oggi quella
musica e quella poesia, passate a tutto l’Esercito
di Vittorio Veneto e pertanto a tutta l’Italia vitto
riosa attraverso la guerra, si chiamano «canzoni
alpine ».
La fede è connaturata in quei figli della terra,
del Piemonte e di Roma come il sale nel mare,
come l’arsura nel vento.
Da ima famiglia di quei contadini, fra i più umili,
fra i più diseredati, fra i più legati a quei campi ed
a quelle vigne, come un tralcio di vite generato dal
creatore nasce questo Santo italiano. Egli trae gran
dezza e santità, intimamente legate come sintesi di
tutte le virtù della terra e della gente da cui ha
origine. È un prodotto di Dio e «del suolo ».
Suo padre era un povero contadino che posse
deva una casa assai più significativa nella sua po
vertà che non la «porziuncola » di San Francesco.
San Francesco aveva abitata la «porziuncola» per ri
nunziare alla vita, per macerazione dello spirito e
del corpo in penitenza ed in ammonimento di ritorno
alle cose semplici dopo la ricchezza, il fasto ed il
disordine. Don Bosco è nato in quel povero abituro:
composto di una stalla per due capi di bestiame
bovino ed una cameretta a terreno e di un fienile e
due camerette al piano superiore alle quali si accede
per ima scaletta ed un loggiato di legno malamente
squadrato e nelle quali un uomo di alta statura
toccherebbe del capo. La vista di quella casa vi
prende fino in fondo al cuore.
Così potrebbe essere immaginata la capanna di
Betlemme, così può essere rappresentata in sintesi
la vita di tutto un mondo rurale che è, come fu, il
più puro custode della sanità e delle tradizioni della
razza ed al quale oggi soltanto il Duce della Rivolu
zione Fascista prepara un migliore domani in un
clima degno di Roma.
Sua madre era una buona e pia donnetta di
campagna, dotata di qualche naturale ingegno, di
solide virtù risparmiatrid, di non poche qualità di
intransigenza che si faceva talvolta durezza; ogni
cosa fondata sopra una morale contadina, ma incrol
labile. Non posso condividere gli entusiasmi a mio
avviso eccessivi di pressoché tutti i biografi per Mar
gherita Occhiena. La formazione di Don Bosco è
figlia della Provvidenza e non della madre nè del
padre mortali. Questi era morto quando il piccolo
aveva due anni e quella non aveva capito il figlio,
come del resto non l’aveva capito il parroco del
paese al quale pure Giovanni aveva dato più di
mille prove della propria vocazione al sacerdozio ed
alla educazione dei fanciulli. La buona donna che
era stata sposata in seconde nozze dal padre di
Giovanni, morto il marito e fatto grandicello un
figliastro che della razza contadina aveva esagerati
i difetti e ridotte le solide virtù e che solo poteva
portare utile alla vita dei campi un bel giorno aveva
messo un pane in mano a Giovanni e l’aveva man
dato per il mondo a guadagnarsi l’altro pane.
Il
pastore di greggi diventa così nell’abbandono
attraverso mille prove, artiere di ogni arte e quindi
pastore di -anime. Quanti uomini da questi abban
doni, da queste solitudini, da questa lotta per la
esistenza negli anni più teneri e più difficili non
hanno ricevuto colla buona tempra la formazione
eroica!
Egli giunge tardi al sacerdozio ma vi giunge dopo
molte prove, avendo già conosciuta la vita, avendo
già provata la fame e il sopruso e l’affronto, ed
imparato fuori delle aule di una scuola o di un col
legio ad accogliere ogni diversa necessità con volto
sorridente. Il bagno gelido fa del ferro l’acciaio.
Fanciullo ancora, prima che egli abbandoni il
suo gregge, don Bosco vede il suo futuro destino.
Lo vede in sogno, così come più tardi altri sogni gli
segneranno i gradini ed i piani della angelica scala
della Sua vita in continua ascesa verso la perfezione
che oggi la Chiesa ha additata al culto ed alla vene
razione del mondo e della quale va fiera la Patria.
I Suoi sogni, le Sue visioni, le Sue profezie, la Sua
veggenza a distanza, provati nel tempo come verità,
ci portano ai margini del mondo dello inconoscibile
davanti al quale la vita ed il pensiero umano sono
costretti a fermarsi non sapendo della fonte e della
foce del nostro fiume se non quanto d dice, altis
simo conforto, la fede.
Attraverso le pietre miliari di queste creature di
eccezione che il Creatore dispone sul camminò della
umanità, per noi oscurissimo, abbiamo qualche guida
e qualche sprazzo di luce, perchè la nostra fede, che
dovrebbe pur bastare a sé stessa, riceva nella sua
pochezza Ù suffragio e la scuola della storia.
Giovanni segue l’imperativo del suosognoe ricalca
le orme del destino che lo guida verso la Chiesa
— sarebbe tardi per tutti entrare in seminario a
quell’età e sarebbe tardi a 25 anni per uscirne come
ne uscì nd giugno dd 1841. Egli invece non ha
perduta un’ora della sua vita perchè tutte le avver
sità, tutte le prove subite, tutte le arti imparate,
tutte le cose tristi e gioconde vedute gli erano in
dispensabili, così che si può ben dire oggi die nep
4


















