
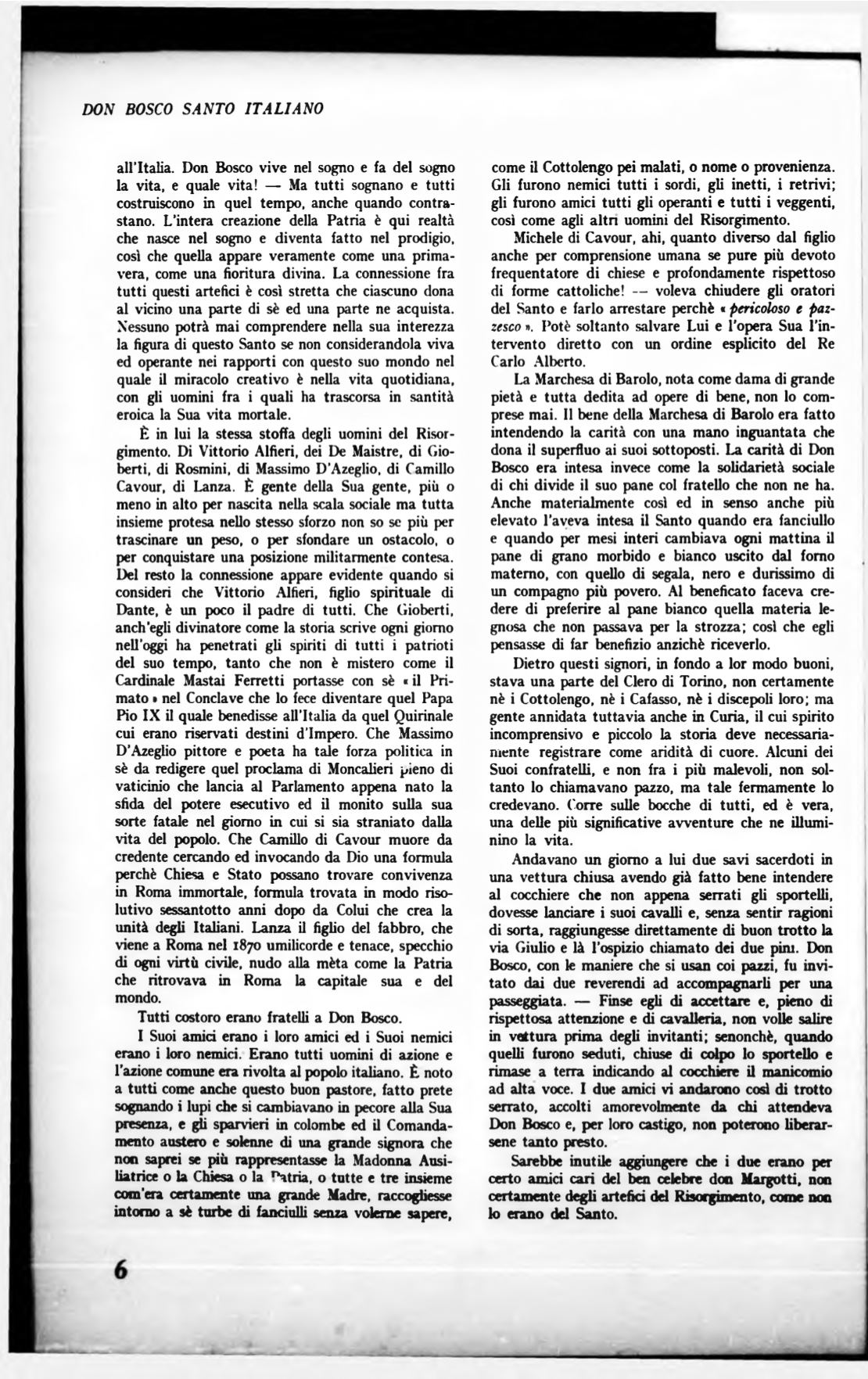
DON BOSCO SANTO ITAL IANO
all’Italia. Don Bosco vive nel sogno e fa del sogno
la vita, e quale vita! — Ma tutti sognano e tutti
costruiscono in quel tempo, anche quando contra
stano. L’intera creazione della Patria è qui realtà
che nasce nel sogno e diventa fatto nel prodigio,
così che quella appare veramente come una prima
vera, come una fioritura divina. La connessione fra
tutti questi artefici è così stretta che ciascuno dona
al vicino una parte di sè ed una parte ne acquista.
Nessuno potrà mai comprendere nella sua interezza
la figura di questo Santo se non considerandola viva
ed operante nei rapporti con questo suo mondo nel
quale il miracolo creativo è nella vita quotidiana,
con gli uomini fra i quali ha trascorsa in santità
eroica la Sua vita mortale.
È in lui la stessa stoffa degli uomini del Risor
gimento. Di Vittorio Alfieri, dei De Maistre, di Gio
berti, di Rosmini, di Massimo D’Azeglio, di Camillo
Cavour, di Lanza. È gente della Sua gente, più o
meno in alto per nascita nella scala sociale ma tutta
insieme protesa nello stesso sforzo non so se più per
trascinare un peso, o per sfondare un ostacolo, o
per conquistare una posizione militarmente contesa.
Del resto la connessione appare evidente quando si
consideri che Vittorio Alfieri, figlio spirituale di
Dante, è un poco il padre di tutti. Che Gioberti,
anch’egli divinatore come la storia scrive ogni giorno
nell’oggi ha penetrati gli spiriti di tutti i patrioti
del suo tempo, tanto che non è mistero come il
Cardinale Mastai Ferretti portasse con sè «il Pri
mato »nel Conclave che lo fece diventare quel Papa
Pio IX il quale benedisse all’Italia da quel Quirinale
cui erano riservati destini d’impero. Che Massimo
D’Azeglio pittore e poeta ha tale forza politica in
sè da redigere quel proclama di Moncalieri pieno di
vaticinio che lancia al Parlamento appena nato la
sfida del potere esecutivo ed il monito sulla sua
sorte fatale nel giorno in cui si sia straniato dalla
vita del popolo. Che Camillo di Cavour muore da
credente cercando ed invocando da Dio una formula
perchè Chiesa e Stato possano trovare convivenza
in Roma immortale, formula trovata in modo riso
lutivo sessantotto anni dopo da Colui che crea la
unità degli Italiani. Lanza il figlio del fabbro, che
viene a Roma nel 1870 umilicorde e tenace, specchio
di ogni virtù civile, nudo alla mèta come la Patria
che ritrovava in Roma la capitale sua e del
mondo.
Tutti costoro erano fratelli a Don Bosco.
I
Suoi amici erano i loro amici ed i Suoi nemici
erano i loro nemici. Erano tutti uomini di azione e
l’azione comune era rivolta al popolo italiano. È noto
a tutti come anche questo buon pastore, fatto prete
sognando i lupi che si cambiavano in pecore alla Sua
presenza, e gli sparvieri in colombe ed il Comanda
mento austero e solenne di una grande signora che
non saprei se più rappresentasse la Madonna Ausi-
liatrice o la Chiesa o la natria, o tutte e tre insieme
com’era certamente una grande Madre, raccogliesse
intorno a si turbe di fanciulli senza volerne sapere,
come il Cottolengo pei malati, o nome o provenienza.
Gli furono nemici tutti i sordi, gli inetti, i retrivi;
gli furono amici tutti gli operanti e tutti i veggenti,
così come agli altri uomini del Risorgimento.
Michele di Cavour, ahi, quanto diverso dal figlio
anche per comprensione umana se pure più devoto
frequentatore di chiese e profondamente rispettoso
di forme cattoliche! — voleva chiudere gli oratori
del Santo e farlo arrestare perchè «
pericoloso e paz
zesco
». Potè soltanto salvare Lui e l'opera Sua l’in
tervento diretto con un ordine esplicito del Re
Carlo Alberto.
La Marchesa di Barolo, nota come dama di grande
pietà e tutta dedita ad opere di bene, non lo com
prese mai. Il bene della Marchesa di Barolo era fatto
intendendo la carità con una mano inguantata che
dona il superfluo ai suoi sottoposti. La carità di Don
Bosco era intesa invece come la solidarietà sociale
di chi divide il suo pane col fratello che non ne ha.
Anche materialmente così ed in senso anche più
elevato l’aveva intesa il Santo quando era fanciullo
e quando per mesi interi cambiava ogni mattina il
pane di grano morbido e bianco uscito dal forno
materno, con quello di segala, nero e durissimo di
un compagno più povero. Al beneficato faceva cre
dere di preferire al pane bianco quella materia le
gnosa che non passava per la strozza; così che egli
pensasse di far benefìzio anziché riceverlo.
Dietro questi signori, in fondo a lor modo buoni,
stava una parte del Clero di Torino, non certamente
nè i Cottolengo, nè i Cafasso, nè i discepoli loro; ma
gente annidata tuttavia anche in Curia, il cui spirito
incomprensivo e piccolo la storia deve necessaria
mente registrare come aridità di cuore. Alcuni dei
Suoi confratelli, e non fra i più malevoli, non sol
tanto lo chiamavano pazzo, ma tale fermamente lo
credevano. Corre sulle bocche di tutti, ed è vera,
una delle più significative avventure che ne illumi
nino la vita.
Andavano un giorno a lui due savi sacerdoti in
ima vettura chiusa avendo già fatto bene intendere
al cocchiere che non appena serrati gli sportelli,
dovesse lanciare i suoi cavalli e, senza sentir ragioni
di sorta, raggiungesse direttamente di buon trotto la
via Giulio e là l’ospizio chiamato dei due pini. Don
Bosco, con le maniere che si usan coi pazzi, fu invi
tato dai due reverendi ad accompagnarli per una
passeggiata. — Finse egli di accettare e, pieno di
rispettosa attenzione e di cavalleria, non volle salire
in vettura prima degli invitanti; senonchè, quando
quelli furono seduti, chiuse di colpo lo sportello e
rimase a terra indicando al cocchiere il manicomio
ad alta voce. I due amici vi andarono così di trotto
serrato, accolti amorevolmente da chi attendeva
Don Bosco e, per loro castigo, non poterono liberar
sene tanto presto.
Sarebbe inutile aggiungere che i due erano per
certo amici cari del ben celebre don Margotti, non
certamente degli artefici del Risorgimento, come non
lo erano del Santo.


















