
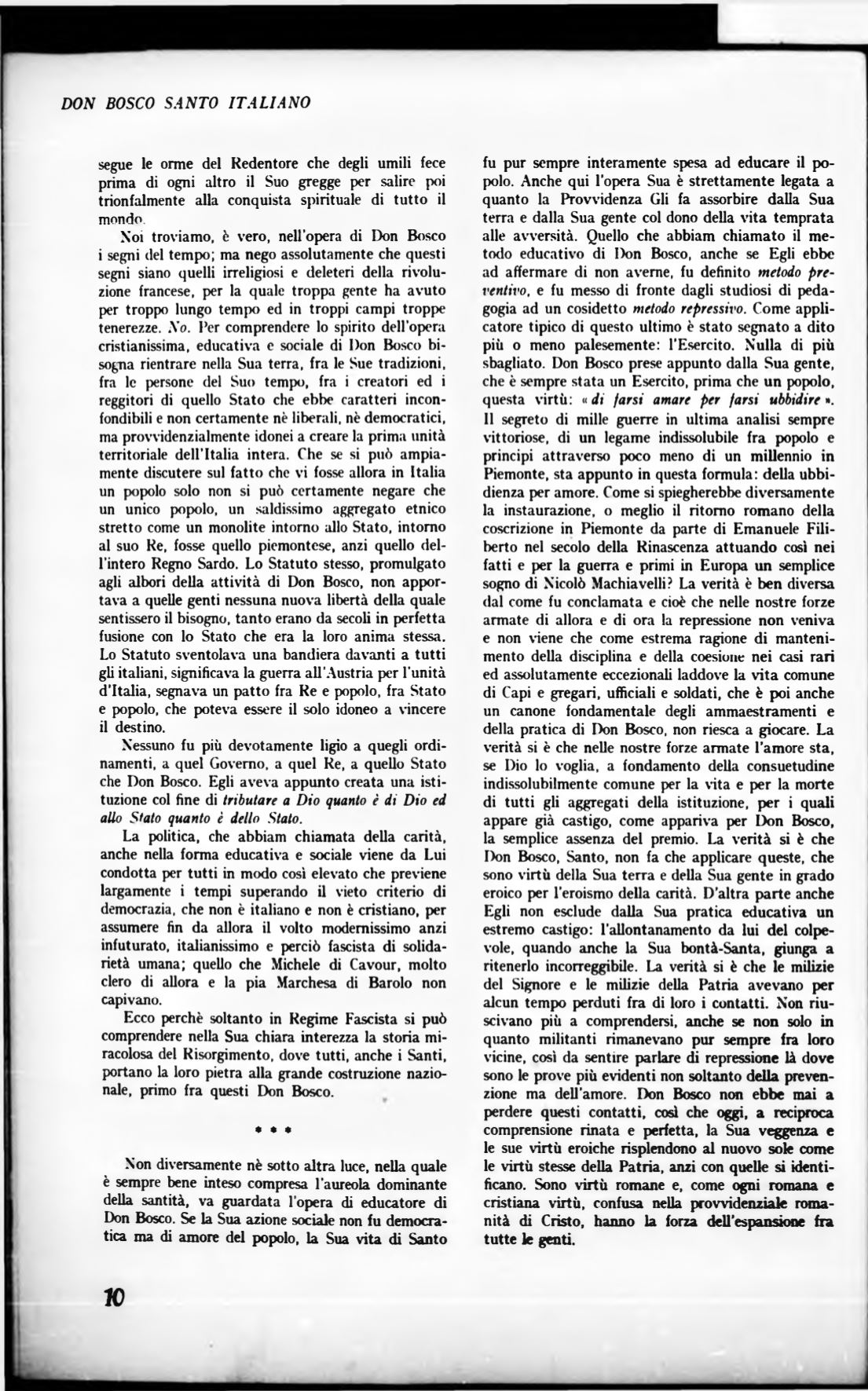
DON BOSCO SANTO ITAL IANO
segue le orme del Redentore che degli umili fece
prima di ogni altro il Suo gregge per salire poi
trionfalmente alla conquista spirituale di tutto il
mondo.
Noi troviamo, è vero, nell’opera di Don Bosco
i segni del tempo; ma nego assolutamente che questi
segni siano quelli irreligiosi e deleteri della rivolu
zione francese, per la quale troppa gente ha avuto
per troppo lungo tempo ed in troppi campi troppe
tenerezze.
No.
Per comprendere lo spirito dell’opera
cristianissima, educativa e sociale di Don Bosco bi
sogna rientrare nella Sua terra, fra le Sue tradizioni,
fra le persone del Suo tempo, fra i creatori ed i
reggitori di quello Stato che ebbe caratteri incon
fondibili e non certamente nè liberali, nè democratici,
ma provvidenzialmente idonei a creare la prima unità
territoriale dell’Italia intera. Che se si può ampia
mente discutere sul fatto che vi fosse allora in Italia
un popolo solo non si può certamente negare che
un unico popolo, un saldissimo aggregato etnico
stretto come un monolite intorno allo Stato, intorno
al suo Re, fosse quello piemontese, anzi quello del
l’intero Regno Sardo. Lo Statuto stesso, promulgato
agli albori della attività di Don Bosco, non appor
tava a quelle genti nessuna nuova libertà della quale
sentissero il bisogno, tanto erano da secoli in perfetta
fusione con lo Stato che era la loro anima stessa.
Lo Statuto sventolava una bandiera davanti a tutti
gli italiani, significava la guerra all’Austria per l’unità
d’Italia, segnava un patto fra Re e popolo, fra Stato
e popolo, che poteva essere il solo idoneo a vincere
il destino.
Nessuno fu più devotamente ligio a quegli ordi
namenti, a quel Governo, a quel Re, a quello Stato
che Don Bosco. Egli aveva appunto creata una isti
tuzione col fine di
tributare a Dio quanto è di Dio ed
allo Stato quanto è dello Stato.
La politica, che abbiam chiamata della carità,
anche nella forma educativa e sociale viene da Lui
condotta per tutti in modo così elevato che previene
largamente i tempi superando il vieto criterio di
democrazia, che non è italiano e non è cristiano, per
assumere fin da allora il volto modernissimo anzi
infuturato, italianissimo e perciò fascista di solida
rietà umana; quello che Michele di Cavour, molto
clero di allora e la pia Marchesa di Barolo non
capivano.
Ecco perchè soltanto in Regime Fascista si può
comprendere nella Sua chiara interezza la storia mi
racolosa del Risorgimento, dove tutti, anche i Santi,
portano la loro pietra alla grande costruzione nazio
nale, primo fra questi Don Bosco.
* * *
Non diversamente nè sotto altra luce, nella quale
è sempre bene inteso compresa l'aureola dominante
della santità, va guardata l’opera di educatore di
Don Bosco. Se la Sua azione sociale non fu democra
tica ma di amore del popolo, la Sua vita di Santo
fu pur sempre interamente spesa ad educare il po
polo. Anche qui l’opera Sua è strettamente legata a
quanto la Provvidenza Gli fa assorbire dalla Sua
terra e dalla Sua gente col dono della vita temprata
alle avversità. Quello che abbiam chiamato il me
todo educativo di Don Bosco, anche se Egli ebbe
ad affermare di non averne, fu definito
metodo pre
ventivo,
e fu messo di fronte dagli studiosi di peda
gogia ad un cosidetto
metodo repressivo.
Come appli-
catore tipico di questo ultimo è stato segnato a dito
più o meno palesemente: l’Esercito. Nulla di più
sbagliato. Don Bosco prese appunto dalla Sua gente,
che è sempre stata un Esercito, prima che un popolo,
questa virtù: «
di farsi amare per farsi ubbidire
».
Il segreto di mille guerre in ultima analisi sempre
vittoriose, di un legame indissolubile fra popolo e
principi attraverso poco meno di un millennio in
Piemonte, sta appunto in questa formula: della ubbi
dienza per amore. Come si spiegherebbe diversamente
la instaurazione, o meglio il ritorno romano della
coscrizione in Piemonte da parte di Emanuele Fili
berto nel secolo della Rinascenza attuando così nei
fatti e per la guerra e primi in Europa un semplice
sogno di Nicolò Machiavelli? La verità è ben diversa
dal come fu conclamata e cioè che nelle nostre forze
armate di allora e di ora la repressione non veniva
e non viene che come estrema ragione di manteni
mento della disciplina e della coesione nei casi rari
ed assolutamente eccezionali laddove la vita comune
di Capi e gregari, ufficiali e soldati, che è poi anche
un canone fondamentale degli ammaestramenti e
della pratica di Don Bosco, non riesca a giocare. La
verità si è che nelle nostre forze armate l’amore sta,
se Dio lo voglia, a fondamento della consuetudine
indissolubilmente comune per la vita e per la morte
di tutti gli aggregati della istituzione, per i quali
appare già castigo, come appariva per Don Bosco,
la semplice assenza del premio. La verità si è che
Don Bosco, Santo, non fa che applicare queste, che
sono virtù della Sua terra e della Sua gente in grado
eroico per l’eroismo della carità. D’altra parte anche
Egli non esclude dalla Sua pratica educativa un
estremo castigo: l’allontanamento da lui del colpe
vole, quando anche la Sua bontà-Santa, giunga a
ritenerlo incorreggibile. La verità si è che le milizie
del Signore e le milizie della Patria avevano per
alcun tempo perduti fra di loro i contatti. Non riu
scivano più a comprendersi, anche se non solo in
quanto militanti rimanevano pur sempre fra loro
vicine, così da sentire parlare di repressione là dove
sono le prove più evidenti non soltanto della preven
zione ma dell’amore. Don Bosco non ebbe mai a
perdere questi contatti, così che oggi, a reciproca
comprensione rinata e perfetta, la Sua veggenza e
le sue virtù eroiche risplendono al nuovo sole come
le virtù stesse della Patria, anzi con quelle si identi
ficano. Sono virtù romane e, come ogni romana e
cristiana virtù, confusa nella provvidenziale roma
nità di Cristo, hanno la forza dell’espansione fra
tutte le genti.
10


















