
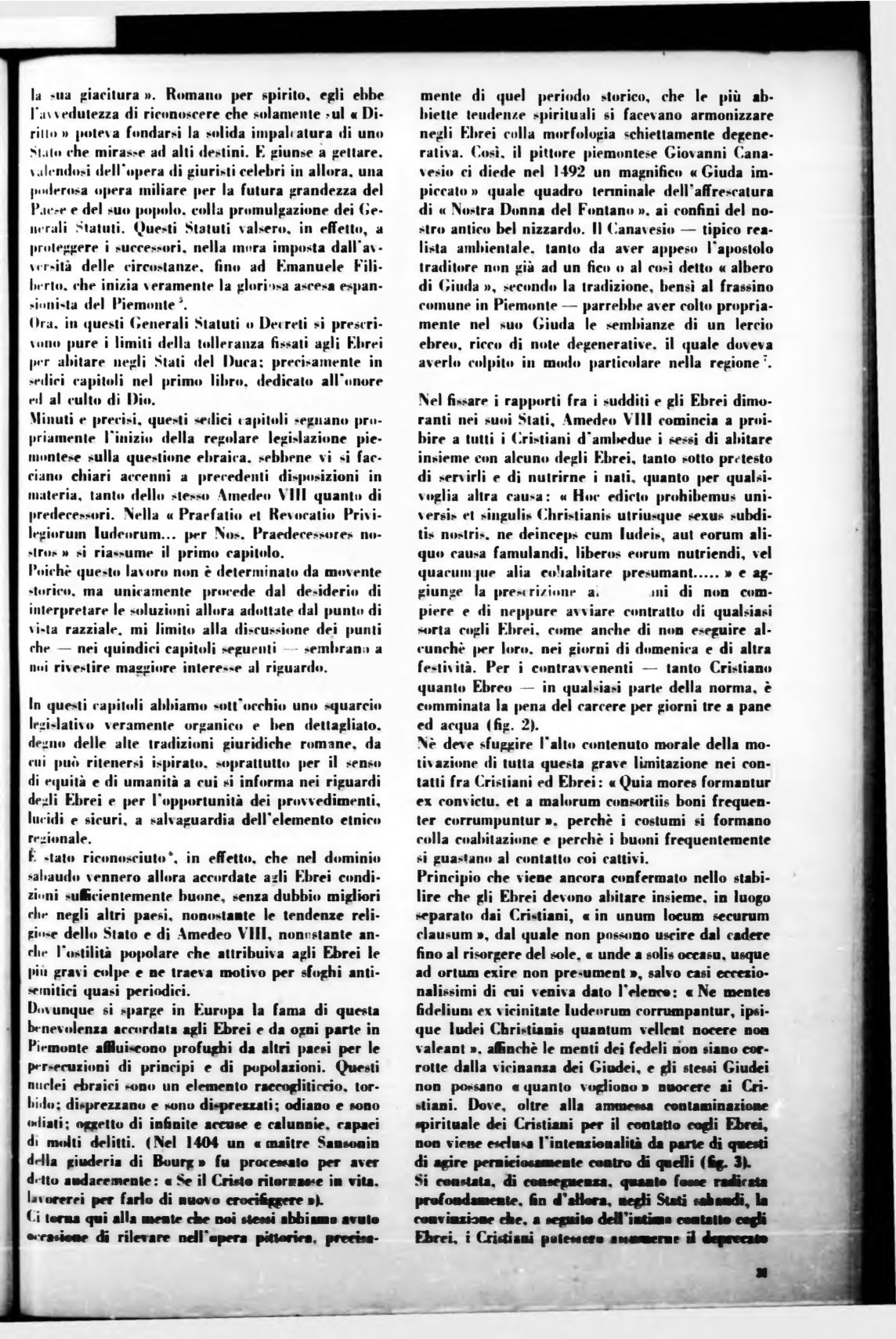
la -uà giacitura ». Romano per spirito, egli ebbe
l'avvedutezza di riconoscere che solamente ?ul « Di-
riiio
» poteva fondarsi la solida impanatura di uno
Stato
che mirasse ad alti destini. E giunse a gettare,
valendosi dell'opera di giuristi celebri in allora, una
poderosa
opera miliare per la futura grandezza del
Pae.-e
e del suo popolo, colla promulgazione dei Ge-
aerali
Statuti. Questi Statuti valsero, in effetto, a
proteggere i successori, nella mera imposta dall'av-
v
r i
-ita delle circostanze, fino ad Emanuele Fili*
lierto,
che inizia veramente la gloriosa ascesa espan
sionista del Piemonte'’.
Ora,
iti questi Generali Statuti o Dei reti si prescri
vono pure i limiti della tolleranza (issati agli Kitrei
per
abitare negli Stati del Duca; precisamente in
sedici capitoli nel primo libro, dedicalo aU'unore
ed al culto di Dio.
Minuti e precisi, questi sedici «apitoli -evitano pro
priamente l'inizio della regolare levitazione pie
montese sulla questione ebraica, sebbene vi si fac
ciano chiari accenni a precedenti disposizioni in
materia, tanto dello stesso Amedeo Nili quanto di
predecessori. Nella « Praefatio et Revocatio Privi*
le<:ioruin ludeorum... per Nos. Praedecessores no-
stro p
» si riassume il primo capitolo.
Poiché que-to lavoro non è determinato da movente
storico, ma unicamente procede dal desiderio di
interpretare le soluzioni allora adottate dal punto di
vi-ta razziale, mi limito alla discussione dei punti
che — nei quindici capitoli seguenti — sembrane a
noi rivestire maggiore interesse al riguardo.
In questi capitoli abbiamo
so tt'o cch io
uno squarcio
legislativo veramente organico e ben dettagliato.
He;:uo delle alle tradizioni giuridiche romane, da
cui può ritenersi ispirato, soprattutto per il senso
Hi equità e di umanità a cui si informa nei riguardi
depli Ebrei e per l'opportunità dei provvedimenti,
lucidi e sicuri, a salvaguardia dell'elemento etnico
regionale.
K -tato riconosciuto \ in effetto, che nel dominio
sabaudo vennero allora accordate axli Ebrei condi
zioni sufficientemente buone, senza dubbio migliori
eli** negli altri paesi, nonostante le tendenze reli
giose
dello Stato e di Amedeo V ili, nonostante an
elo* l'ostilità popolare che attribuiva agli Ebrei le
pio gravi colpe e ne traeva motivo per sfoghi anti
semitici quasi periodici.
Dovunque si >>parge in Europa la fama di questa
benevolenza accordata agli Ebrei e da ogni parte in
Piemonte affluiscono profughi da altri parsi per le
persecuzioni di principi e di popolazioni. Questi
nuclei ebraici sono un elemento raccogliticcio, tor
bido; disprezzano e sono di»prczzati; odiano e sono
odiati; oggetto di infinite accuse e calunnie, rapaci
di midti delitti. (Nel 1404 un « maitre Sansonin
di lla giuderia
di
Bourg »
fu processalo per aver
d*ito
audacemente : « Se il Cristo ritorcale
in
vita,
lav
tirerei
per farlo di nuovo crocifiggere •}.
Ci
torna qni alla niente rbe noi ileni abbiamo avuto
occasione di rilevare nell'opera pittorica, precisa
mente di quel periodo storico, che le più ab
biette teuden/.e spirituali si facevano armonizzare
negli Ebrei colla morfologia schiettamente degene
rativa. Così, il pittore piemontese Giovanni Cana-
vesio ci diede nel 1492 un magnifico «Giuda im
piccato » quale quadro tenninale deU'affrescatura
di « Nostra Donna del Fontano », ai confini del no
stro antico bel nizzardo. Il Canavesio — tipico rea
lista ambientale, tanto da aver appeso l'apostolo
traditore non già ad un fico o al così detto « albero
di Giuda », secondo la tradizione, bensì al frassino
comune in Piemonte — parrebbe aver collo propria
mente nel suo Giuda le sembianze di un lercio
ebreo, ricco di note degenerative, il quale doveva
averlo colpito iu modo particolare nella regione7.
Nel fissare i rapporti fra i sudditi e gli Ebrei dimo
ranti nei suoi Stati, Amedeo V ili comincia a proi
bire a tutti i Cristiani d'amliedue i sessi di abitare
insieme con alcuno degli Ebrei, tanto sotto pretesto
di servirli e di nutrirne i nati, quanto per qualsi
voglia altra causa: « Hoc edicto prohibemus uni-
versis et siugulis Christianis utriusque sexus suhdi-
tis nostris. ne deinceps cum Iudeis, aut eorum ali-
quo causa famulandi, liberos eorum nutriendi, vel
quartini pie alia coliabitare presumant......» e ag
giunge la prescrizione a.
ini di non com
piere e di neppure avviare contratto di qualsiasi
sorta cogli Ebrei, come anche di non eseguire al
cunché |»er loro, nei giorni di domenica e di altra
fe»ti\ità. Per i contravvenenti — tanto Cristiano
quanto Ebreo — in qualsiasi parte della norma, è
comminata la pena del carcere per giorni tre a pane
ed acqua (fig. 2).
Né deve sfuggire l'alto contenuto morale della mo
tivazione di tutta questa grave limitazione nei con
tatti fra Cristiani ed Ebrei : « Quia mores formantur
ex convictu. et a malorum consortiis boni frequen-
ter corrumpuntur ». perchè i costumi si formano
colla coabitazione e perchè i buoni frequentemente
si guastano al contatto coi cattivi.
Principio che viene ancora confermato nello stabi
lire che gli Ebrei devono abitare insieme, in luogo
separato dai Cristiani, « in unum locum securum
clausum », dal quale non possono uscire dal cadere
fino al risorgere del sole. « unde a solis occasu, usque
ad ortum exire non pre-ument » , salvo casi eccezio
nalissimi di cui veniva dato l'elenco; «N e mente*
fideli uni ex vicinitate ludeorum corrompantur, ipsi-
que ludei Christianis quantum vcllcnt nocere non
valeant ». affinchè le menti dei fedeli non siano
cor
rotte dalla vicinanza dei Giudei, e gli stessi Giudei
non possano « quanto vogliono » nuocere ai Cri
stiani. Dove, oltre alla ammessa contaminazione
spirituale dei Cristiani
per
il contatto eofji
Ebrei,
non viene esclusa l'intenzionalità
da parte di qwesti
di agire perniciosamente contro di quelli (fig. 3).
Si constata, di conseguenza, quanto fosse radirata
profondamente, fin d'allora, negli Stati uh—di, la
convinzione che. a segnilo ddTintimn contatto eogft
Ebrei,
i
Cristiani palmeto anunarrnr il depreca»
M


















