
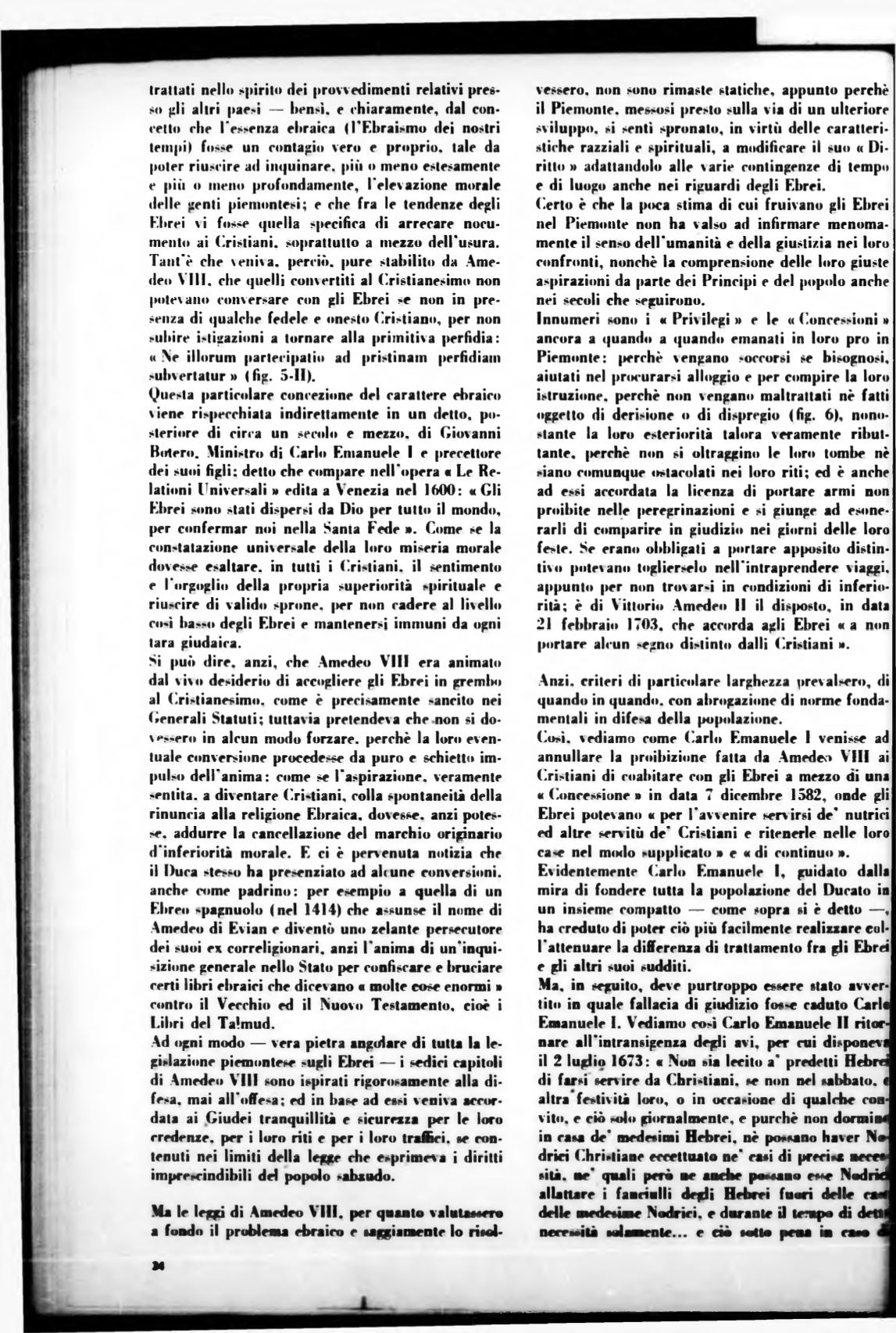
trattati nello spirito dei provvedimenti relativi pres
so ^li altri paesi — bensì, e chiaramente, dal con
cetto che l'essenza ebraica (PEbraismo dei nostri
tempi) fosse un contacio vero e proprio, tale da
poter riuscire ad inquinare, più o meno estesamente
e più o meno profondamente, l’ elevazione morale
delle «lenti piemontesi; e che fra le tendenze degli
Ebrei \i fosse quella specifica di arrecare nocu
mento ai Cristiani, soprattutto a mezzo dell'usura.
Tant'è che \eni\a. perciò, pure stabilito da Ame
deo V ili, che quelli convertiti al Cristianesimo non
potexano conversare con gli Ebrei se non in pre
senza di qualche fedele e onesto Cristiano, per non
subire istigazioni a tornare alla primitiva perfidia:
« Ne illorum partecipati»» ad pristinain perfidiali!
subvertatur » ( fig. 5-II).
(Questa particolare concezione del carattere ebraico
viene rispecchiata indirettamente in un detto, po
steriore di circa un secolo e mezzo, di Giovanni
Bolero. Ministro di Carlo Emanuele I e precettore
dei suoi figli; detto che compare nell'opera « Le Re-
lationi Universali » edita a Venezia nel 1600: «G li
Ebrei sono stati dispersi da Dio per tutto il mondo,
per confermar noi nella Santa Fede ». Come se la
constatazione universale della loro miseria morale
doveste esaltare, in tutti i Cristiani, il sentimento
e l'orgoglio della propria superiorità spirituale e
riuscire di valido sprone, per non cadere al livello
cosi basso degli Ebrei e mantenersi immuni da ogni
tara giudaica.
Si può dire, anzi, che Amedeo V ili era animato
dal vivo desiderio di accogliere gli Ebrei in grembo
al Cristianesimo, come è precisamente sancito nei
Generali Statuti; tuttavia pretendeva che non si do
tassero in alcun modo forzare, perchè la loro even
tuale conversione procedesse da puro e schietti» im
pulso dell'anima: come se l'aspirazione, veramente
sentita, a diventare Cristiani, colla spontaneità della
rinuncia alla religione Ebraica, dovesse, anzi potes
se. addurre la cancellazione del marchio originario
d’ inferiorità morale. E ci è pervenuta notizia che
il Duca stesso ha presenziato ad ahune conversioni,
anche come padrino: per esempio a quella di un
Ebreo spagnuolo (nel 1414) che assunse il nume di
Amedeo di Evian e diventò uno zelante persecutore
dei suoi ex correligionari, anzi l'anima di un'inqui
sizione generale nello Stato per confiscare e bruciare
certi libri ebraici che dicevano « molte cose enormi »
contro il Vecchio ed il Nuovo Testamento, cioè i
Libri del Talmud.
Ad ogni modo — vera pietra angolare di tutta la le
gislazione piemontese sugli Ebrei — i sedici capitoli
di Amedeo V ili sono ispirati rigorosamente alla di
fesa. mai all'offesa; ed in base ad essi veniva accor
data ai Giudei tranquillità e sicurezza per le loro
credenze, per i loro riti e per i loro traffici. »e con
tenuti nei limiti della legge che esprimeva i diritti
imprescindibili del popolo sabaudo.
Ma le leggi di Amedeo Vili, per quanto valutassero
a fondo il problema ebraico e saggiamente lo risol-
M
vesserò, non sono rimaste statiche, appunto perchè
il Piemonte, messosi presto sulla via di un ulteriore
sviluppi», si sentì spronato, in virtù delle caratteri
stiche razziali e spirituali, a modificare il suo « Di
ritto » adattandolo alle varie contingenze di tempo
e di luogo anche nei riguardi degli Ebrei.
Certo è che la poca stima di cui fruivano gli Ebrei
nel Piemonte non ha valso ad infirmare menoma
mente il senso dell'umanità e della giustizia nei loro
confronti, nonché la comprensione delle loro giuste
aspirazioni da parte dei Principi e del popolo anche
nei secoli che seguirono.
Innumeri sono i « Priv ilegi » e le « Concessioni »
ancora a quando a quando emanati in loro prò in
Piemonte: perchè vengano soccorsi se bisognosi,
aiutati nel prm-urarsi alloggio e per compire la loro
istruzione, perchè non vengano maltrattati nè fatti
oggetto di derisione o di dispregio (fig. 6), nono
stante la loro esteriorità talora veramente ribut
tante, |»erchè non si oltraggino le loro tombe nè
siano comunque <»starolati nei loro riti; ed è anche
ad essi accordata la licenza di portare armi non
proibite nelle peregrinazioni e si giunge ad esone
rarli di comparire in giudizio nei giorni delle loro
feste. Se erano obbligati a portare apposito distin
tivo pote\ano toglierselo nell'intraprendere viaggi,
appunto per non trovar-i in condizioni di inferio
rità; è di Vittorio Amedeo II il disposto, in data
21 febbraio 1703. che accorda agli Ebrei « a non
portare alcun segno distinto dalli Cristiani >».
Anzi, criteri di particolare larghezza prevalsero, di
quando in quando, con abrogazione di norme fonda-
mentali in difesa della popolazione.
Così, vediamo come Carlo Emanuele I venisse ad
annullare la proibizione fatta da Amedeo V ili ai
Cristiani di coabitare con gli Ebrei a mezzo di una
«Concessione» in data 7 dicembre 1582, onde gli
Ebrei potevano « per l'avvenire servirsi de* nutrici
ed altre servitù de* Cristiani e ritenerle nelle loro
ca*e nel mmlo supplicato » e « di continuo ».
Evidentemente Carlo Emanuele I, guidato dalla
mira di fondere tutta la popolazione del Ducato in
un insieme compatto — come sopra si è detto —,
ha creduto di poter ciò più facilmente realizzare cui*
l'attenuare la differenza di trattamento fra gli Ebrei
e gli altri suoi sudditi.
Ma, in seguito, deve purtroppo essere stato avver
tito in quale fallacia di giudizio fos*e caduto Carla
Emanuele I. Vediamo così Carlo Emanuele II ritor
nare all'intransigenza degli avi, per cui disponevi
il
2
luglio
1673: «
Non sia lecito a* predetti Hebrei
di farsi servire da Christiani. se non nel sabbato. «
altra festività loro,
o
in occasione di qualche con
vito. e ciò
solo
giornalmente, e purché non donnina
in rasa de* medesimi Hebrei, nè possano haver No-
drici Christiane eccettuato ne* rasi di precisa nere»
sità. ne* quali però ne anche possano esse Nodric
allattare i fanciulli degli Hebrei fuori delle ca4
delle medesime Nodriei. e durante il tempo di dett
necessità solamente... e ciò sotto pena in raao


















