
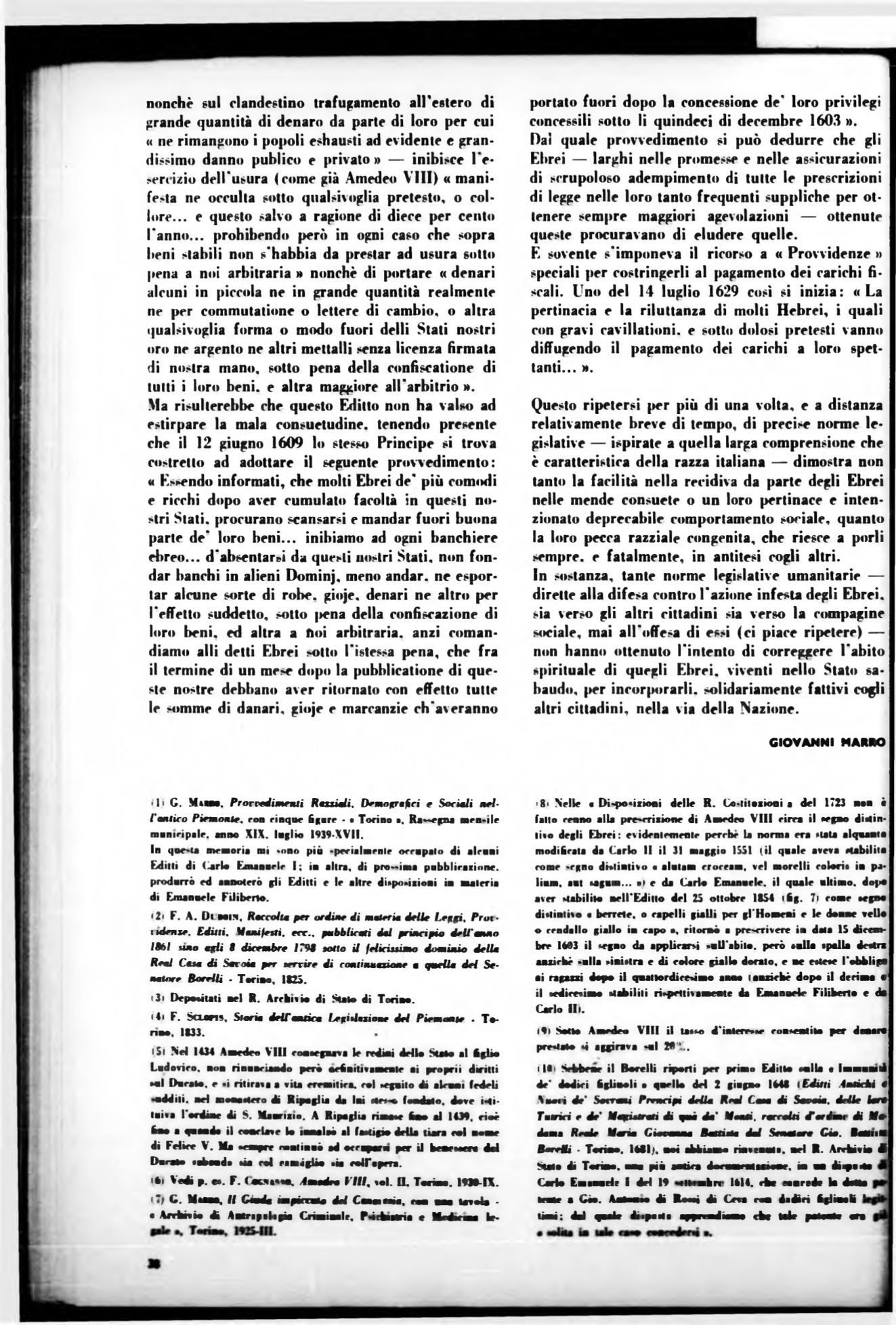
nonché sul clandestino trafugamento all'estero di
grande quantità di denaro da parte di loro per cui
« ne rimangono i popoli eshausti ad evidente e gran
dissimo danno publico e privato » — inibisce le*
i n i z i o dell'usura (come già Amedeo V ili) « mani
festa ne occulta sotto qualsivoglia pretesto, o col-
lore... e questo salvo a ragione di diece per cento
l'anno... prohibendo però in ogni caso che sopra
beni stabili non s'habbia da prestar ad usura gotto
|»ena a noi arbitraria » nonché di portare « denari
alcuni in piccola ne in grande quantità realmente
ne per commutatone o lettere di cambio, o altra
qualsivoglia forma o modo fuori delli Stati nostri
oro ne argento ne altri mettalli senza licenza firmata
di nostra mano, sotto pena della confiscatone di
tutti i loro beni, e altra maggiore all'arbitrio ».
Ma risulterebbe che questo Editto non ha valso ad
estirpare la mala consuetudine, tenendo presente
che il 12 giugno 1609 lo stesso Principe si trova
costretto ad adottare il seguente provvedimento:
« Kssendo informati, che molti Ebrei de* più comodi
e ricchi dopo aver cumulato facoltà in questi no
stri Stati, procurano scansarsi e mandar fuori buona
parte de* loro beni... inibiamo ad ogni banchiere
ebreo... d'absentarei da questi nostri Stati, non fon
dar banchi in alieni Dominj. meno andar, ne espor
tar alcune sorte di robe, gioje. denari ne altro per
I*effetto suddetto, sotto |>ena della confìscazione di
loro beni, ed altra a fioi arbitraria, anzi coman
diamo alli detti Ebrei sotto l'istessa pena, che fra
il termine di un me>e dopo la pubblicatione di que
ste nostre debbano aver ritornato con effetto tutte
le somme di danari, gioje e marcanzie ch'averanno
portato fuori dopo la concessione de' loro privilegi
concessili sotto li quindeci di decembre 1603 ».
Dai quale provvedimento si può dedurre che gli
Ebrei — larghi nelle promesse e nelle assicurazioni
di scrupoloso adempimento di tutte le prescrizioni
di legge nelle loro tanto frequenti suppliche per ot
tenere sempre maggiori agevolazioni — ottenute
queste procuravano di eludere quelle.
E sovente s'imponeva il ricorso a « Provvidenze »
speciali per costringerli al pagamento dei carichi fi
scali. Uno del 14 luglio 1629 così si inizia: «La
pertinacia e la riluttanza di molti Hebrei, i quali
con gravi cavillationi. e sotto dolosi pretesti vanno
diffugendo il pagamento dei carichi a loro spet
tanti... ».
Questo ripetersi per più di una volta, e a distanza
relativamente breve di tempo, di precise nonne le
gislative — ispirate a quella larga comprensione che
é caratteristica della razza italiana — dimostra non
tanto la facilità nella recidiva da parte degli Ebrei
nelle mende consuete o un loro pertinace e inten
zionato deprecabile comportamento sociale, quanto
la loro pecca razziale congenita, che riesce a porli
sempre, e fatalmente, in antitesi cogli altri.
In sostanza, tante norme legislative umanitarie —
dirette alla difesa contro l'azione infesta degli Ebrei,
sia verso gli altri cittadini sia verso la compagine
sociale, mai all'offesa di essi (ci piace ripetere) —
non hanno ottenuto l'intento di correggere l'abito
spirituale di quegli Ebrei, viventi nello Stato sa
baudo, per incorporarli, solidariamente fattivi cogli
altri cittadini, nella via della Nazione.
GIOVANNI MAURO
•li C. M ino.
Prorredimenti Razziali. Demografici e Sociali nel
l'antico Piemonte,
con cinque figure •• Torino ». Ra—-egna mcn-ile
municipale, anno XIX. luglio 1939-XVII.
In que-la memoria mi -«no piò *peeialmcnle occupalo di alcuni
Editti di (ir lo Emanuele I; in altra, di prò—ima pubblicazione,
produrrò ed annoterò gii Editti e le altre deposizioni in materia
di Emanuele Filiberto.
•2i F. A. Dt aoi>,
Raccolta per ordine ili materia delle Leggi, Proi-
i utenze. Editti. Mani/etti. ecc.. pubblicali dal principio dell'anno
1861
uno agli 8 dicembre
1798
sotto il felicissimo dominio della
Reai Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del Se
natore Barelli .
Torino, 1825.
i3i Depositati nel R. Archivio di Stalo di Torino.
»4i F. Stxarts,
Storia dell'antica I* filiazione del Piemonte
. To
rino, 1833.
(Si Nei 1434 Amedeo V ili consegnava le redini dello Stato al figlio
Ludovico, non rinunciando però oeinitivineale ai proprii diritti
hi
I Duralo, e *i ritirava a vita eremitica, coi seguito di alevai fedeli
-udditi. nel motta»»ero di Ripaglia da Ini rtes-o fondalo, dove isti
tuiva l'ordine di S. Maurizio. A Ripaglia rinutt fino al 1439, cioè
fino a quando il conclave io innalzò al fattigio della tiara eoi nome
di Felice V. Ma sempre continuò ad occupar»! per il bene—ere del
Ducato «abanda óa eoi ramigli» sia coll*«pera.
iti Vedi p. e*. F. (« v tv s a .
Ammira
FI#/, voi. IL Torino. IW -IX .
'
~)
t . Maana, fi
Giuda impiccatu del Cmmetia,
con
urna
tavola -
• Archivio di Antrip iligia Criminale, f irlnatria « Medicina le-
>8> Nelle • Disposizioni delle R. Co-mozioni a del 1723 non
è
fatto cenno alla prescrizione di Amedeo V ili eirra il segno distin
tivo degli Ebrei : evidentemente perche la norma era stata alquanta
modificata da Carlo II il 31 maggio ISSI (il quale aveva «abilita
rome «cgno distintivo « alutam rroream, vel morelli colori» in pa
limi!. aut sagum... al e da Carlo Emanuele, il quale ultimo, dopa
aver stabilito nell'Editto del 2S ottobre 1854 tfig. 7i come segno
distintivo • berrete, o capelli gialli per gl'Homeni e le donne velia
o ccndallo giallo in rapo a, ritornò a prescrivere in data 15 dicem
bre 1603 il segno da applicarsi sull'abito, però sulla «palla deatra
anziché -alla sinistra e di colore giallo doralo, e ne estese l'obbligo
ai ragazzi dopo il quattordicesimo anno (anziché dopo il derima a
il sedicesimo stabiliti rispettivaaaeate da Emanuele Filiberto e da
Carlo Ili.
iti Sotto Amedeo V ili il tasso d'interesse consentito per d fa ra
prestato *i aggirava >«l 2A’\,.
1
10. Sebbene il Rorelli riporti per primo Editto Milla a Immanili
de' dodici figlinoli a quello del 2 giugno IMS I
Editti Antichi
«
Nuoti de’
Sovrani Prencipi della Reai Casa di Savoia, delie U n
Tutrici e de’ Magistrati di qui da’ Monti, raccolti rf
or dm i
di
IH»
dama
Reale
N «ia
Giovanna Battista dui Senatore Giù.
BattìiM
Barelli ■
Torino. IMI.), noi abbiamo rinvenni», nel R. Archivia di
Stalo di Torino, una più antica Jammrntarianr. in
mm
dilu ita
Carla Fmannrlr I del 19 rttrmhn 1*14. che tnnrrde la ddU
tonte a Gàa. Antonio di b o i di Crva con dadiri figlineli *
timi; dal quale di «parta apprendiamo « k tale patente ara


















