
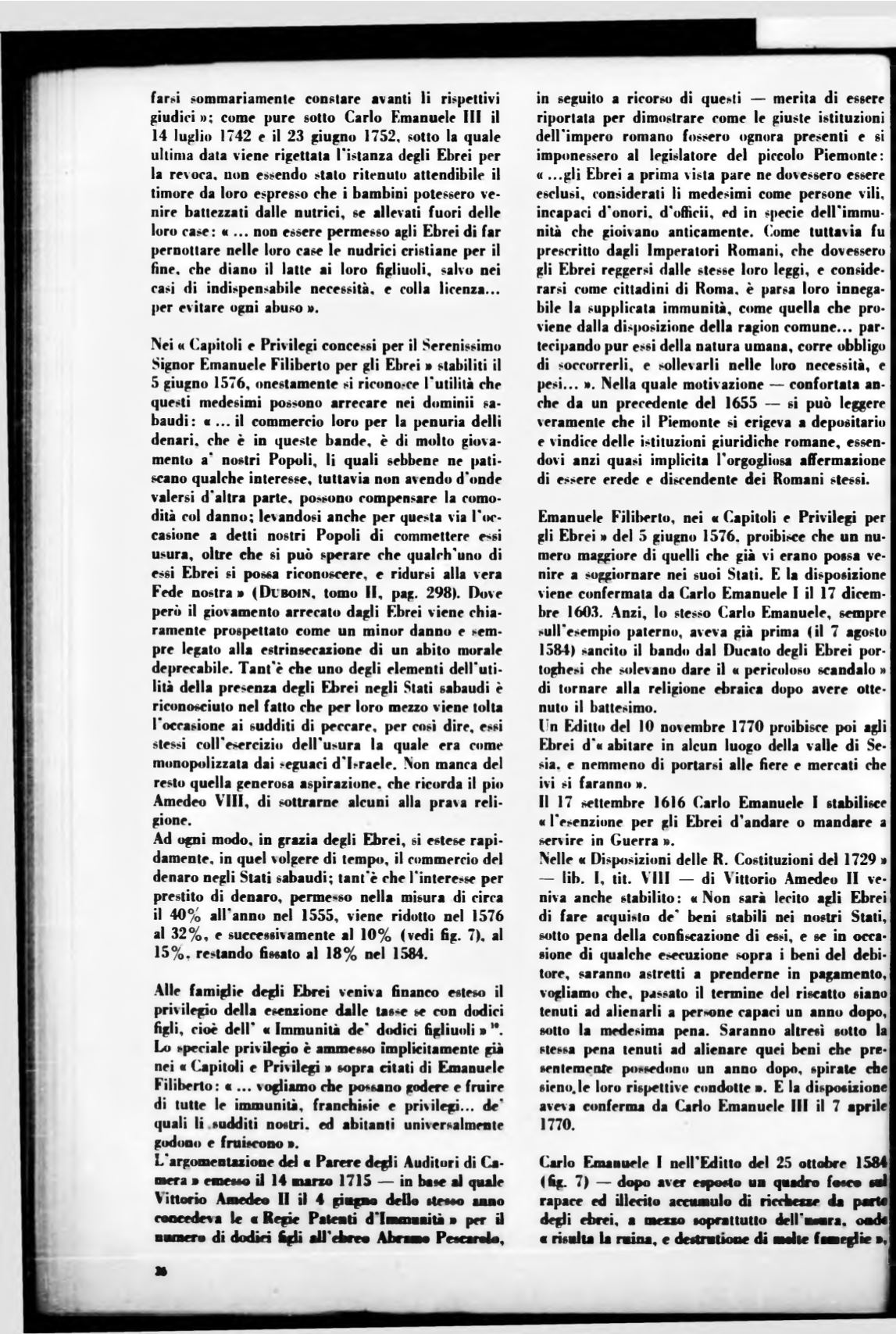
farsi sommariamente constare avanti li rispettivi
giudici » ; come pure sotto Carlo Emanuele III il
14 luglio 1742 e il 23 giugno 1752, sotto la quale
ultima data viene rigettata l'istanza degli Ebrei per
la revoca, non essendo stato ritenuto attendibile il
timore da loro espresso che i bambini potessero ve
nire battezzati dalle nutrici, se allevati fuori delle
loro case: « . . . non essere permesso agli Ebrei di far
pernottare nelle loro case le nudrici cristiane per il
fine, che diano il latte ai loro figliuoli, salvo nei
casi di indispensabile necessità, e colla licenza...
per evitare ogni abuso ».
Nei « Capitoli e Privilegi concessi per il Serenissimo
Signor Emanuele Filiberto per gli Ebrei » stabiliti il
5 giugno 1576, onestamente si ricono-ce l'utilità che
questi medesimi possono arrecare nei dominii sa
baudi: « ... il commercio loro per la penuria delli
denari, che è in queste bande, è di molto giova
mento a' nostri Popoli, li quali sebbene ne pati
scano qualche interesse, tuttavia non avendo d'onde
valersi d'altra parte, possono compensare la como
dità col danno; levandosi anche per questa via l'oc
casione a detti nostri Popoli di commettere essi
usura, oltre che si può sperare che qualrh'uno di
essi Ebrei si possa riconoscere, e ridursi alla vera
Fede nostra»
( D
l b o i n
,
tomo II, pag. 298). Dove
però il giovamento arrecato dagli Ebrei viene chia
ramente prospettato come un minor danno e sem
pre legato alla estrinsecazione di un abito morale
deprecabile. Tant'è che uno degli elementi dell'uti
lità della presenza degli Ebrei negli Stati sabaudi è
riconosciuto nel fatto che per loro mezzo viene tolta
l'occasione ai sudditi di peccare, per cosi dire, essi
stessi coll'esercizio dell'usura la quale era come
monopolizzata dai seguaci d'Israele. Non manca del
resto quella generosa aspirazione, che ricorda il pio
Amedeo V ili, di sottrarne alcuni alla prava reli
gione.
Ad ogni modo, in grazia degli Ebrei, si estese rapi
damente, in quel volgere di tempo, il commercio del
denaro negli Stati sabaudi; tant'è rhe l'interesse per
prestito di denaro, permesso nella misura di circa
il 40% all'anno nel 1555, viene ridotto nel 1576
al 32% , e successivamente al 10% (vedi fig. 7), al
15%, restando fissato al 18% nel 1584.
Alle famiglie degli Ebrei veniva financo esteso il
priv ilegio della esenzione dalle tasse se con dodici
figli, cioè dell* « Immunità de* dodici figliuoli » " ,
Lo speciale privilegio è ammesso implicitamente già
nei « Capitoli e Privilegi » sopra citati di Emanuele
Filiberto: « ... vogliamo che possano godere e fruire
di tutte le immunità, franchisie e privilegi... de*
quali li sudditi nostri, ed abitanti universalmente
godono e fruiscono ».
L'argomentazione del « Parere degli Auditori di Ca
mera » emesso il 14 nano 1715 — in base al quale
Vittorio Amedeo li il 4 giugno dello stesso anno
concedeva le « Regie Patenti d'immanità » per il
numero di dodici figli all'ebreo Abramo Pescaiolo,
in seguito a ricorso di questi — merita di essere
riportata per dimostrare come le giuste istituzioni
deII*impero romano fossero ognora presenti e si
imponessero al legislatore del piccolo Piemonte:
« ...gli Ebrei a prima vista pare ne dovessero essere
esclusi, considerati li medesimi come persone vili,
incapaci d’ onori, d'officii, ed in specie dell'immu
nità che gioivano anticamente. Come tuttavia fu
prescritto dagli Imperatori Romani, che dovessero
gli Ebrei reggersi dalle stesse loro leggi, e conside
rarsi come cittadini di Roma, è parsa loro innega
bile la supplicata immunità, come quella che pro
viene dalla disposizione della ragion comune... par
tecipando pur essi della natura umana, corre obbligo
di soccorrerli, e sollevarli nelle loro necessità, e
pesi... ». Nella quale motivazione — confortata an
che da un precedente del 1655 — si può leggere
veramente che il Piemonte si erigeva a depositario
e vindice delle istituzioni giuridiche romane, essen
dovi anzi quasi implicita l'orgogliosa affermazione
di essere erede e discendente dei Romani stessi.
Emanuele Filiberto, nei « Capitoli e Privilegi per
gli Ebrei » del 5 giugno 1576. proibisce che un nu
mero maggiore di quelli che già vi erano possa ve
nire a soggiornare nei suoi Stati. E la disposizione
viene confermata da Carlo Emanuele I il 17 dicem
bre 1603. Anzi, lo stesso Carlo Emanuele, sempre
sull*esempio paterno, aveva già prima (il 7 agosto
1584) sancito il bando dal Ducato degli Ebrei por
toghesi che solevano dare il « pericoloso scandalo »
di tornare alla religione ebraica dopo avere otte
nuto il battesimo.
lln Editto del 10 novembre 1770 proibisce poi agli
Ebrei d ‘ « abitare in alcun luogo della valle di Se
sia. e nemmeno di portarsi alle fiere e mercati che
ivi si faranno ».
Il 17 settembre 1616 Carlo Emanuele I stabilisce
« l'esenzione per gli Ebrei d'andare o mandare a
servire in Guerra ».
Nelle « Disposizioni delle R. Costituzioni del 1729 »
— lib. I, tit.
Vili
— di
V
ittorio Amedeo II ve
niva anche stabilito : « Non sarà lecito agli Ebrei
di fare acquisto de* beni stabili nei nostri Stati,
sotto pena della confiscazione di essi, e se in occa
sione di qualche esecuzione sopra i beni del debi
tore, saranno astretti a prenderne in pagamento,
vogliamo che, passato il termine del riscatto siano
tenuti ad alienarli a persone capaci un anno dopo,
sotto la medesima pena. Saranno altresì sotto la
stessa pena tenuti ad alienare quei beni che pre
sentemente possedono un anno dopo, spirate che
sieno.leloro rispettive condotte ». E la disposizione
aveva conferma da Carlo Emanuele III il 7 aprile
1770.
Carlo Emanuele I nell'Editto del
25
ottobre 1584
(fig.
7)
— dopo aver esposto un quadro fosco tal
rapace ed illecito accumulo di riccbcsae da parte
degli ebrei, a mezzo soprattutto dell'usura, onde
« risalta la mina, e destraUose di amile f—ieglie »,
»


















