
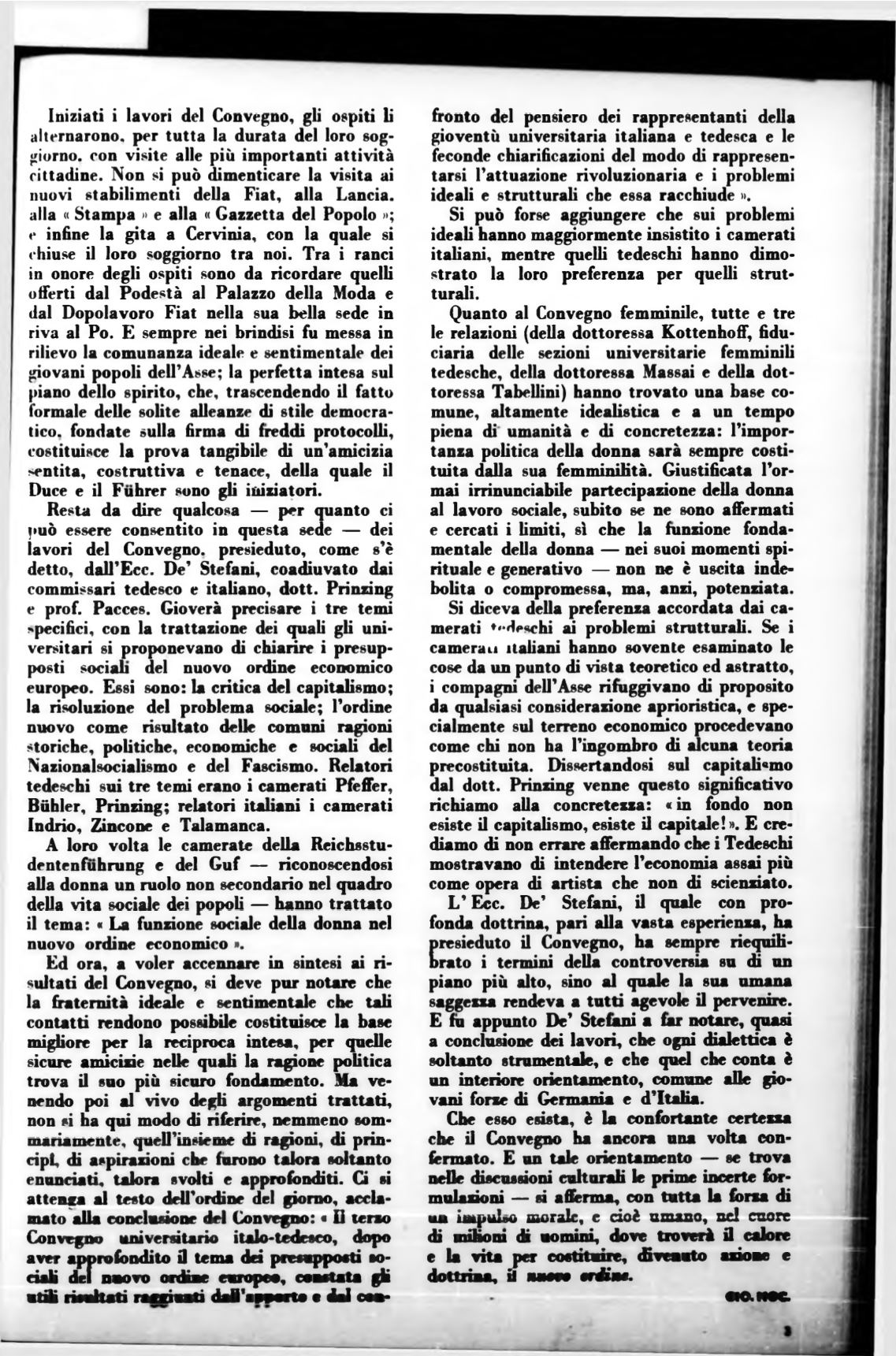
Iniziati i lavori del Convegno, gli ospiti li
alternarono, per tutta la durata del loro sog
giorno. con visite alle più importanti attività
cittadine. Non si può dimenticare la visita ai
nuovi stabilimenti della Fiat, alla Lancia,
alla « Stampa » e alla «Gazzetta del Popolo »;
e
infine la gita a Cervinia, con la quale si
chiuse il loro soggiorno tra noi. Tra i ranci
in onore degli ospiti sono da ricordare quelli
offerti dal Podestà al Palazzo della Moda e
dal Dopolavoro Fiat nella sua bella sede in
riva al Po. E sempre nei brindisi fu messa in
rilievo la comunanza ideale e sentimentale dei
giovani popoli dell’Asse; la perfetta intesa sul
piano dello spirito, che, trascendendo il fatto
formale delle solite alleanze di stile democra
tico. fondate sulla firma di freddi protocolli,
costituisce la prova tangibile di un’amicizia
sentita, costruttiva e tenace, della quale il
Duce e il Fuhrer sono gli iniziatori.
Resta da dire qualcosa — per quanto ci
può essere consentito in questa sede — dei
lavori del Convegno, presieduto, come s’è
detto, dall’Ecc. De’ Stefani, coadiuvato dai
commissari tedesco e italiano, dott. Prinzing
e prof. Pacces. Gioverà precisare i tre temi
specifici, con la trattazione dei quali gli uni
versitari si proponevano di chiarire i presup
posti sociali del nuovo ordine economico
europeo. Essi sono: la critica del capitalismo;
la risoluzione del problema sociale; l’ordine
nuovo come risultato delle comuni ragioni
storiche, politiche, economiche e sociali del
Nazionalsocialismo e del Fascismo. Relatori
tedeschi sui tre temi erano i camerati Pfeffer,
Biihler, Prinzing; relatori italiani i camerati
Indrio, Zincone e Talamanca.
A loro volta le camerate della Reichsstu-
dentenfuhrung e del Guf — riconoscendosi
alla donna un ruolo non secondario nel quadro
della vita sociale dei popoli — hanno tra tta to
il tema: « La funzione sociale della donna nel
nuovo ordine economico ».
Ed ora, a voler accennare in sintesi ai ri
sultati del Convegno, si deve pur notare che
la fraternità ideale e sentimentale che tali
contatti rendono possibile costituisce la base
migliore per la reciproca intesa, per quelle
sicure amicizie nelle quali la ragione politica
trova il suo più sicuro fondamento. Ma ve
nendo poi al vivo degli argomenti tra tta ti,
non si ha qui modo di riferire, nemmeno som
mariamente, quell’insieme di ragioni, di prin
cipi, di aspirazioni che furono talora soltanto
enunciati, talora svolti e approfonditi. Ci si
attenga al testo dell’ordine del giorno, accla
mato
alla conclusione
del
Convegno:
• 0 terso
Convegno universitario italo-tedesco, dopo
aver approfondito il tema dei presupposti so
ciali del nnovo ordine europeo, constata gli
utili
r isa lu t i
rad ian ti dall’apporto • dal con
fronto del pensiero dei rappresentanti della
gioventù universitaria italiana e tedesca e le
feconde chiarificazioni del modo di rappresen
tarsi l’attuazione rivoluzionaria e i problemi
ideali e strutturali che essa racchiude ».
Si può forse aggiungere che sui problemi
ideali hanno maggiormente insistito i camerati
italiani, mentre quelli tedeschi hanno dimo
strato la loro preferenza per quelli strut
turali.
Quanto al Convegno femminile, tutte e tre
le relazioni (della dottoressa Kottenhoff, fidu
ciaria delle sezioni universitarie femminili
tedesche, della dottoressa Massai e della dot
toressa Tabellini) hanno trovato una base co
mune, altamente idealistica e a un tempo
piena di umanità e di concretezza: l’impor
tanza politica della donna sarà sempre costi
tuita dalla sua femminilità. Giustificata l’or
mai irrinunciabile partecipazione della donna
al lavoro sociale, subito se ne sono affermati
e cercati i limiti, sì che la funzione fonda-
mentale della donna — nei suoi momenti spi
rituale e generativo — non ne è uscita inde
bolita o compromessa, ma, anzi, potenziata.
Si diceva della preferenza accordata dai ca
merati ♦'•Hpschi ai problemi strutturali. Se i
camerati italiani hanno sovente esaminato le
cose da un punto di vista teoretico ed astratto,
i compagni dell’Asse rifuggivano di proposito
da qualsiasi considerazione aprioristica, e spe
cialmente sul terreno economico procedevano
come chi non ha l’ingombro di alcuna teoria
precostituita. Dissertandosi sul capitali«mo
dal dott. Prinzing venne questo significativo
richiamo alla concretezza: « in fondo non
esiste il capitalismo, esiste il capitale!». E cre
diamo di non errare affermando che i Tedeschi
mostravano di intendere l’economia assai più
come opera di artista che non di scienziato.
L ’ Ecc. De’ Stefani, il quale con pro
fonda dottrina, pari alla vasta esperienza, ha
C
resieduto il Convegno, ha sempre riequili-
rato i termini della controvenia su di un
piano più alto, sino al quale la sua umana
saggezza rendeva a tu t t i agevole il pervenire.
E fu appunto De’ Stefani a far notare, quasi
a conclusione dei lavori, che ogni dialettica è
soltanto strumentale, e che quel che conta è
un interiore orientamento, comune alle gio
vani forze di Germania e d’Italia.
Che esso esista, è la confortante certezza
che il Convegno ha ancora una volta con
fermato. E un tale orientamento — se trova
nelle discussioni culturali le prime incerte for
mulazioni — si afferma, con tu tta la fona di
un impulso
morale, e
cioè umano,
nel cuore
di milioni di uomini, dove troverà il calore
e la vita per costituire, «Svenuto azione e
dottrina, il nuovo o
riime.
•M .M C


















