
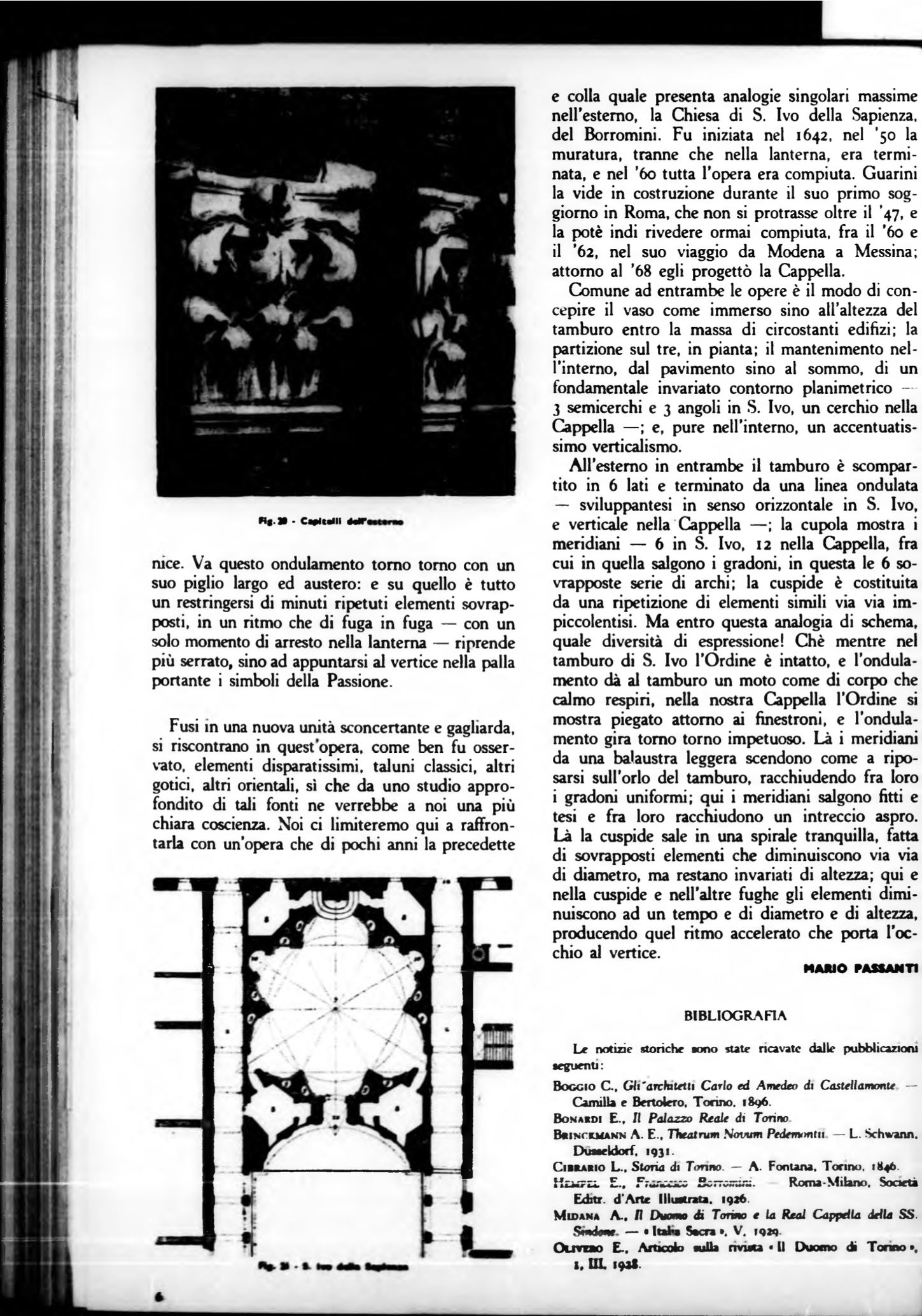
e colla quale presenta analogie singolari massime
nell'esterno, la Chiesa di S. Ivo della Sapienza,
del Borromini. Fu iniziata nel 1642, nel '50 la
muratura, tranne che nella lanterna, era termi
nata, e nel ’6o tutta l’opera era compiuta. Guarini
la vide in costruzione durante il suo primo sog
giorno in Roma, che non si protrasse oltre il *47, e
la potè indi rivedere ormai compiuta, fra il ’6o e
il ’Ó2, nel suo viaggio da Modena a Messina;
attorno al ’68 egli progettò la Cappella.
Comune ad entrambe le opere è il modo di con
cepire il vaso come immerso sino all’altezza del
tamburo entro la massa di circostanti edifizi; la
partizione sul tre, in pianta; il mantenimento nel
l’interno, dal pavimento sino al sommo, di un
fondamentale invariato contorno pianimetrico —
3 semicerchi e 3 angoli in S. Ivo, un cerchio nella
Cappella —; e, pure nell’interno, un accentuatis
simo verticalismo.
All’esterno in entrambe il tamburo è scompar
tito in 6 lati e terminato da una linea ondulata
— sviluppatesi in senso orizzontale in S. Ivo,
e verticale nella Cappella —; la cupola mostra i
meridiani — 6 in S. Ivo, 12 nella Cappella, fra
cui in quella salgono i gradoni, in questa le 6 so
vrapposte serie di archi; la cuspide è costituita
da una ripetizione di elementi simili via via im-
piccolentisi. Ma entro questa analogia di schema,
quale diversità di espressione! Chè mentre nel
tamburo di S. Ivo l’Ordine è intatto, e l’ondula-
mento dà al tamburo un moto come di corpo che
calmo respiri, nella nostra Cappella l’Ordine si
mostra piegato attorno ai finestroni, e l’ondula-
mento gira tomo torno impetuoso. Là i meridiani
da una balaustra leggera scendono come a ripo
sarsi sull’orlo del tamburo, racchiudendo fra loro
i gradoni uniformi; qui i meridiani salgono fìtti e
tesi e fra loro racchiudono un intreccio aspro.
Là la cuspide sale in una spirale tranquilla, fatta
di sovrapposti elementi che diminuiscono via via
di diametro, ma restano invariati di altezza; qui e
nella cuspide e nell’altre fughe gli elementi dimi
nuiscono ad un tempo e di diametro e di altezza,
producendo quel ritmo accelerato che porta l’oc
chio al vertice.
M AR IO PASSANTI
BIBLIOGRAFIA
Le notizie storiche sono state ricavate dalle pubblicazioni
seguenti:
Boccio C.,
Gli
'architetti
Carlo ed Amedeo di Castellamonte
—
Camilla
e
Bertolero, Torino,
18 9 6
.
Bosakdi E-,
II Palazzo Reale di Torino
Bmnckmann A. E.,
Theatrum Novum Pedenumt
11
— L. Schwann.
Dusseldorf,
1 9 3 1
.
C
ibrario
L.. Storia di
Tonno.
— A. Fontana, Torino,
1846
.
lizuFZi.
E., FiM&vas So rressi.
Roma-Milano,
Società
Editr. d’Arte Illustrata.
19 2 6
.
M idana
A - ,
Il
Duomo
d i T o rin o e la R e a i C a p p e lla della S S .
Smdone
— • Ital-a Sacra ». V,
19 29
.
O
l iv o
»
E - , A r t ic o lo s u lla riv is ta « Il D u o m o d i T o n n o »,
I. 111. t9*S.
nice. Va questo ondulamento tomo tomo con un
suo piglio largo ed austero: e su quello è tutto
un restringersi di minuti ripetuti elementi sovrap
posti, in un ritmo che di fuga in fuga — con un
solo momento di arresto nella lanterna — riprende
più serrato, sino ad appuntarsi al vertice nella palla
portante i simboli della Passione.
Fusi in una nuova unità sconcertante e gagliarda,
si riscontrano in questopera, come ben fu osser
vato, elementi disparatissimi, taluni classici, altri
gotici, altri orientali, sì che da uno studio appro
fondito di tali fonti ne verrebbe a noi una più
chiara coscienza. Noi ci limiteremo qui a raffron
tarla con un’opera che di pochi anni la precedette
F ig .M - C a n te lli « « ir a


















