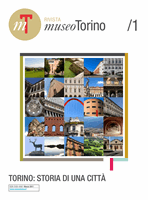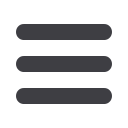
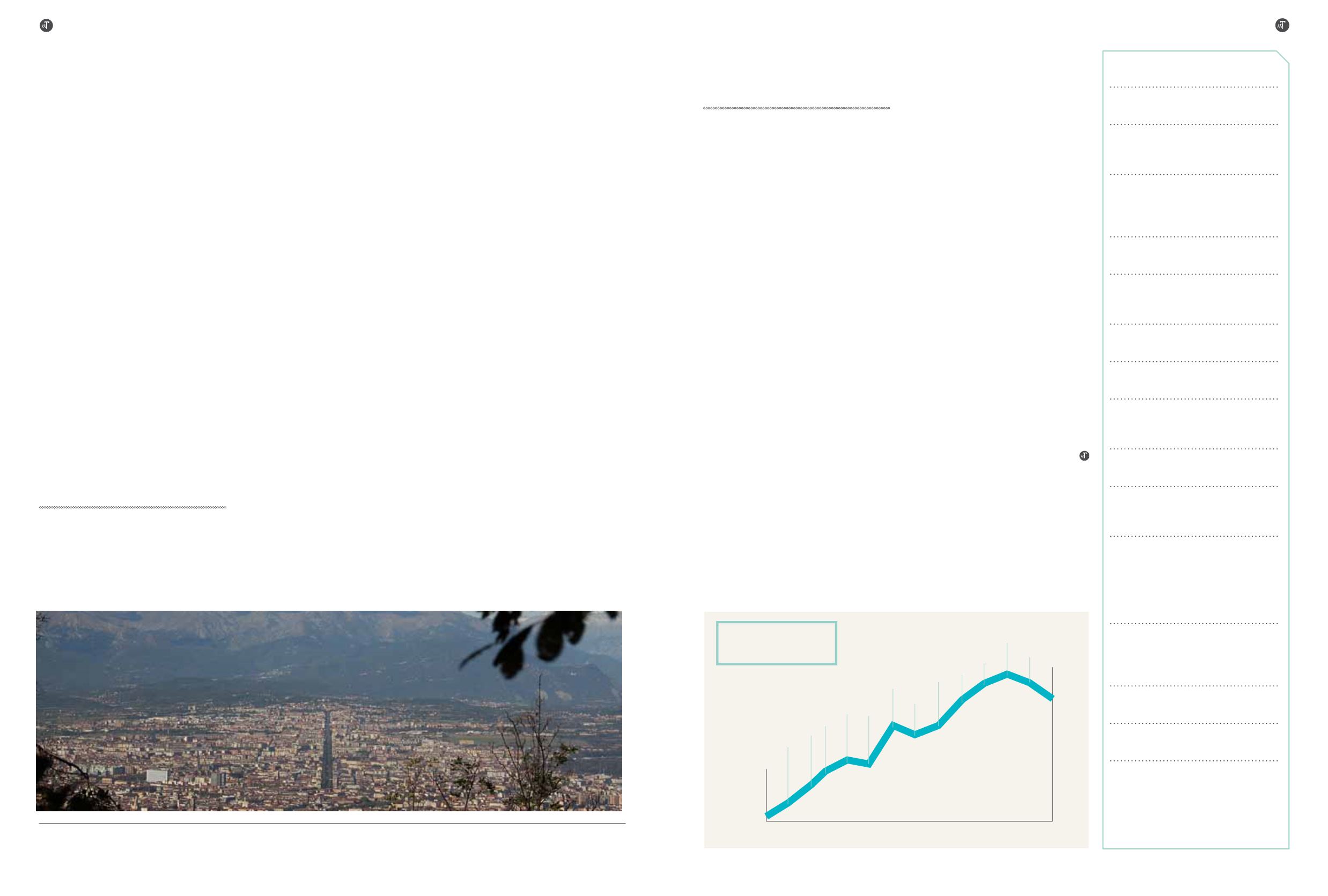
La città moderna
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
48
49
Da Leggere
M. Passanti,
Nel magico mondo di Guarino Guari-
ni
, Toso, Torino 1963
P. Portoghesi,
Bernardo Vittone architetto tra
Illuminismo e Rococò
, Edizioni dell’Elefante,
Roma 1966
A. Cavallari Murat (a cura di),
Forma urbana e
architettura nella Torino barocca. Dalle premesse
classiche alle conclusioni neoclassiche
, 2 voll.,
Utet, Torino 1968
A. Bellini,
Benedetto Alfieri. L’opera completa
,
Electa, Milano 1978
A. Griseri, G. Romano (a cura di),
Filippo Juvarra a
Torino. Nuovi progetti per la città
, Cassa di Rispar-
mio di Torino, Torino 1989
C. Roggero Bardelli, M.G. Vinardi, V. Defabiani,
Vil-
le sabaude
, Rusconi, Milano 1990
G. Gritella,
Filippo Juvarra. L’architettura
, 2 voll.,
Panini, Modena 1992
V. Comoli Mandracci, A. Griseri (a cura di),
Filippo
Juvarra architetto delle capitali. Da Torino a Ma-
drid
1714-1736, Rizzoli, Milano 1995
V. Comoli Mandracci (a cura di),
Itinerari juvarriani
,
Celid, Torino 1995
H.A. Millon (a cura di),
I trionfi del Barocco. Ar-
chitettura in Europa 1600-1750
, catalogo della
mostra, Bompiani, Milano 1999
V. Comoli Mandracci,
L’urbanistica della città ca-
pitale e del territorio e L’urbanistica per la città
capitale e il territorio nella «politica del Regno»
, in
G. Ricuperati (a cura di),
Storia di Torino
, IV,
La cit-
tà fra crisi e ripresa (1630-1730)
, Einaudi, Torino
2002, pp. 431-461 e pp. 939-967
C. Roggero,
L’urbanistica nel secondo Settecen-
to
, in G. Ricuperati (a cura di),
Storia di Torino
, V,
Dalla città razionale alla crisi dello Stato d’Antico
Regime (1730)
, Einaudi, Torino 2002, pp. 799-819
R. Pommer,
Architettura del Settecento in Piemon-
te
, Allemandi, Torino 2003
G. Dardanello, S. Klaiber, H.A. Millon (a cura di),
Guarino Guarini
, Allemandi, Torino 2006
P. Dardanello, R. Tamborrino (a cura di),
Guarini,
Juvarra e Antonelli. Segni e simboli per Torino
, Sil-
vana editoriale, Cinisello Balsamo 2008
POPOLAZIONE DI TORINO
POPOLAZIONE
ANNO
1500 1571 1612 1631 1703 1706 1726 1735 1746 1766 1786 1796 1796 1800
8.000
24.410
36.694
42.866 41.822
64.805
59.485
65.052
79.588
89.752
95.076
90.272
80.752
14.244
la ricostruzione delle quinte unitari dei
nuovi palazzi settecenteschi.
La città dell’assolutismo
Il segno della continuità programmatica con
l’opera riformista di Vittorio Amedeo II ca-
ratterizza il lungo regno di Carlo Emanuele
III (1730-1773) e quindi di Vittorio Ame-
deo III (1773-96). Nel corso del Settecento
maturano piani e progetti per la capitale sa-
bauda, nel pragmatico definirsi di modelli
urbanistici e architettonici alle diverse scale:
dal territorio alla città, ai complessi monu-
mentali e al tessuto edilizio. Se si escludono
due momenti di stasi edilizia, conseguenti al
forte coinvolgimento del Piemonte sabaudo
nelle
guerre di successione polacca
(1733-
35) e di
successione austriaca
(1742-48), il
periodo è contrassegnato dal consolidarsi del-
le linee già tracciate, con apertura a riflessioni
suggerite dallo spirito di razionalità di stam-
po illuminista di
Benedetto Alfieri
, primo
architetto regio dal 1739 al 1767, anno della
sua morte. Quindi sono le magistrature e le
strutture burocratiche centralizzate, sostenute
da valenti architetti di sicura professionalità,
a programmare e gestire – in un quadro che
poco concede all’innovazione e più agli aspet-
ti funzionali e d’uso – il progetto di trasfor-
mazione della città dell’assolutismo, fino agli
anni della dominazione francese.
Risponde al volere del sovrano l’aderenza ad
un unico progetto globale, restituito dalla
morfologia stessa della città fortificata d’im-
pianto ellittico, organizzata al suo interno
secondo una rigida
struttura viaria centri-
peta
, sostenuta da assi rettori che collegano
le quattro porte urbane alla piazza Castello
con il Palazzo Reale, ragione ideologica del
suo essere “metropoli” dello stato. Verso la
metà del Settecento con unità di intenti Car-
lo Emanuele III e Benedetto Alfieri tracciano
il nuovo profilo della capitale che sostituisce
all’idea scenografica juvarriana il
rigore della
dimensione urbanistica
, intesa come attivi-
tà di controllo esercitato attraverso gli stru-
menti legislativi sull’intero processo di tra-
sformazione della città al fine di promuovere
un’architettura pubblica e privata uniformata
nella configurazione formale attenta agli
aspetti funzionali. L’obiettivo è molteplice:
definire attraverso nuovi edifici il complesso
articolarsi delle attività di governo (dello stato
e della municipalità) che impongono il mol-
tiplicarsi delle sedi. In parallelo si vuole coin-
volgere la nuova classe imprenditoriale nobili-
tata, accolta a corte in seguito all’acquisizione
del titolo, a operare attivamente nell’edilizia
mediante innovativi progetti d’investimento
privato legati alla rendita urbana, nel quadro
delle “ristrutturazioni” avviate nel centro più
antico e degradato della città. La rappresen-
tatività del casato si lega a un modello sociale
che prevede per i ceti emergenti il possesso
di una residenza urbana, di una vigna o sede
collinare e di una cascina agricola produttiva
in pianura. Il programma è ampio e guarda
alla città e al territorio, anche nella diffusa
presenza dei cantieri aperti presso le
residen-
ze sabaude suburbane
nel corso di tutto il
secolo XVIII, di cui si conferma l’importanza
come sistema territoriale barocco, sia attraver-
so progetti di trasformazione e ampliamento,
sia incrementando la rete dei viali alberati di
collegamento con la capitale.
Giuseppe Dardanello è professore associato presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli
Studi di Torino.
Costanza Roggero è professore ordinario presso la
II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
tra le principali contrade cittadine – assi
rettori dei tre ampliamenti – e le grandi
direttrici di collegamento col territorio.
Nel progettare la nuova Porta Susina, su
cui si attesta lo “stradone di Francia” trac-
ciato ancora dal Garove (1711) come viale
rettilineo che unisce Torino con il
castello
di Rivoli
, Juvarra impone un nuovo mo-
dello architettonico. La nuova porta ur-
bana costituita dagli edifici dei
Quartieri
Militari
(1716) sull’incrocio dell’attuale
via del Carmine con corso Palestro, non
è più pensata come monumento isolato di
controllo, ma come architettura che de-
finisce uno spazio di ingresso aulico alla
città. Le due caserme di San Celso e di
San Daniele sono pensate come un unico
blocco edilizio tagliato al centro dalla via
principale, e il loro fronte a ordine archi-
tettonico unico detto “gigante” è conno-
tato dalla presenza di portici. Le ali latera-
li aperte accolgono visitatori e viaggiatori
orientando il loro percorso verso la piazza
del Castello, centro del potere. Tale solu-
zione è riproposta dallo stesso architetto
in anni successivi (1729) per l’ingresso
urbano a nord nella piazza di Porta Pa-
lazzo, all’imbocco dell’attuale via Milano,
dove realizza in testa alla via i due grandi
isolati di Santa Croce e di Sant’Ignazio,
di proprietà dell’Ordine Magistrale dei
santi Maurizio e Lazzaro e della Città di
Torino.
L’architettura a servizio
della nuova idea di capitale “regia”
Se nel suo ruolo di primo architetto re-
gio Juvarra traccia il piano urbanistico
per l’espansione occidentale confermando
il principio dell’
ortogonalità
viaria già
applicato nel Seicento, in qualità di pro-
gettista incaricato da diversi committenti
interviene anche sulla scala architettonica
e costruisce la chiesa del Carmine, atten-
de al progetto della
Curia Massima
, lun-
go l’attuale via Corte d’Appello, nonché
al palazzo Martini di Cigala sulla nuova
piazza Susina (piazza Savoia).
In parallelo Juvarra traduce in monumen-
tali progetti d’architettura la nuova idea
del “regno” di Vittorio Amedeo II. Nel
confermare il ruolo baricentrico di Palaz-
zo Reale nella città, egli precisa le nuove
funzioni che, in uno stato moderno, si af-
fiancano a quella tradizionale di residen-
za sovrana. Su una linea già prefigurata da
Amedeo di Castellamonte
, egli sviluppa
l’idea di un “polo reale” aggregato e am-
pliato che si articola a partire dal Palazzo
Reale e raduna tutte le funzioni pubbliche
di governo, elaborando un “Piano genera-
le” (1730) per la realizzazione dei palazzi
delle
Segreterie di stato, Archivi di cor-
te, Teatro Regio e Accademia militare
,
situati nella piazza Castello e via della
Zecca.
Con questa interpretazione innovativa
di un’architettura in grado di esprimere
la concezione settecentesca dello stato,
Juvarra intreccia il grande tema della di-
nastia, elaborando un grandioso progetto
(non realizzato) per il castello di Rivoli in-
terpretato come reggia del sovrano e della
corte, mentre avvia la costruzione della
basilica di Superga
(1716) sul crinale
della collina torinese. Situati entrambe
in posizione elevata e visibili da lontano
rispettivamente per chi giunge dalla Fran-
cia e dalla Pianura Padana, i due comples-
si regi – residenza dinastica dei Savoia e
chiesa destinata ad accogliere le tombe
reali – compongono insieme un inedito
riferimento architettonico e visivo pensa-
to sulla dimensione regionale.
Questi tre complessi –
il Palazzo del
governo, la reggia e le tombe sabaude
– diversi per funzioni e ideazione archi-
tettonica ma tra loro accomunati dall’ele-
mento della rappresentatività della com-
mittenza, entrano a far parte di un’unica
idea compositiva che li lega e li pone in
relazione all’interno del progetto dinasti-
co. Il coronamento conclusivo del disegno
juvarriano per il territorio della capitale è
dato ancora dal progetto (1729) per la
nuova palazzina di caccia di Stupinigi.
I numerosi edifici – civili e religiosi, pub-
blici e privati – costruiti a Torino da Ju-
varra, documentati da numerosi schizzi e
“pensieri”, rispondono all’esigenza di ri-
spondere in termini di architettura ai que-
siti discussi sul livello urbano, anche con
l’intento di introdurre una forte valenza
scenografica nella città. Il progetto per la
nuova facciata, fino ad allora incompiuta,
della chiesa di
Santa Cristina
in piazza
San Carlo, conferma l’importanza della
piazza nel momento in cui propone per il
prospetto un canone architettonico emer-
gente e monumentale. In analogia il pro-
getto (1715) di ricostruzione della chiesa
guariniana di
San Filippo Neri
accetta il
confronto con il prospiciente fabbricato
del Collegio dei Nobili e la mole di Pa-
lazzo Carignano. Anche la
nuova facciata
occidentale di Palazzo Madama
, con lo
straordinario scalone (1718), rivolta verso
via Dora Grossa (ora via Garibaldi), si co-
stituisce in senso urbanistico come l’ine-
dito fondale scenografico per una quinta
edilizia già prefigurata nel suo concreto
divenire e pensata sulla lunga dimensione
della via. Se nel 1735 Juvarra lascia Torino
e si trasferisce a Madrid, chiamato alla co-
struzione del Palazzo Reale di Filippo V di
Borbone, già nell’anno successivo (1736)
è decretata la ristrutturazione della con-
trada, destinata ad ospitare botteghe del
grande commercio di tessuti, oro e merci
preziose, ridefinita attraverso un progetto
che prevede, oltre l’allargamento della via,
Corso Francia, lungo circa 13 chilometri, viene tracciato dall’architetto ducale Michelangelo Garove tra il 1711 e il 1712, su commissione e per editto regio di Vittorio Amedeo II. Già
ai tempi del Garove la strada si caratterizza come ampio e scenografico viale alberato (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).