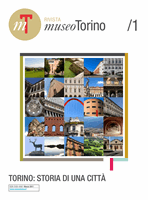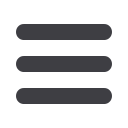

La città moderna
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
44
45
Palazzo Reale (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).
LA CITTÀ Moderna
Capitale di uno Stato a cavallo delle Alpi, la città, immagine del sovrano e della dinastia, si sviluppa
per parti, impostata su una griglia ortogonale e sulla uniformità di facciata, e guarda ai grandi modelli internazionali.
Al disegno degli ingegneri militari si accosta il “meraviglioso” dei fulcri architettonici urbani e della
“corona di delitie” nel territorio. È la città di Vitozzi e dei Castellamonte, di Guarini, di Garove, di Juvarra e di Alfieri.
di
Giuseppe Dardanello
e
Costanza Roggero
T
ra 1580 e 1680, nell’arco di un seco-
lo, la città di Torino raddoppia nelle
dimensioni e triplica il numero dei
propri abitanti, che passano da 15.000
a circa 40.000: e la sua immagine viene
sostanzialmente ridisegnata fino a diveni-
re un’icona di governata continuità, im-
postata su una griglia ortogonale e sulla
uniforme regolarità delle facciate su stra-
da. Le due date marcano altrettante tappe
di grande significato per l’investimento
politico e istituzionale della dinastia sa-
bauda nella
nuova capitale dello Stato
,
trasferita da Chambery a Torino nel 1563.
Cultura militare e disegno urbano sono i
cardini dell’iniziativa del principe per la
capitale: il progetto, definito nelle linee
guida e concretamente messo in opera
dai duchi Emanuele Filiberto (1563-80)
e Carlo Emanuele I (1580-1630), trova la
sua prima fase di attuazione nell’amplia-
mento della “Città nuova” realizzato da
Vittorio Amedeo I (1630-37).
La costruzione della “città nuova”
e l’immagine pubblica della dinastia
Fortificare e controllare la città esistente
sono gli obiettivi della politica urbana
di Emanuele Filiberto, con la scelta stra-
tegica di collocare la
nuova Cittadella
e
l’insediamento della
residenza ducale
ai
due vertici opposti dell’antico
castrum
ro-
mano: l’imponente fortezza disegnata da
Francesco Paciotto e la residenza ducale
che si attesta nell’area del Bastion verde,
mentre rispondono a esigenze di difesa,
contemporaneamente stringono d’assedio
la città. Un’analoga posizione ambivalen-
te è assunta dal duca nei confronti della
Chiesa: con l’espropriazione del Palazzo
del vescovo per farne la propria residen-