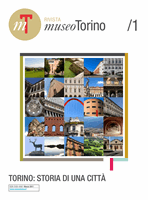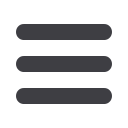

La città medievale
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
36
37
Da Leggere
G.
Casiraghi,
La diocesi di Torino nel medioevo
,
Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1979
G.
Sergi,
Potere e territorio lungo la strada di Fran-
cia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo
, Liguo-
ri, Napoli 1981
R.
Bordone
, S.
Pettenati (a cura di),
Torino nel bas-
so medioevo: castello, uomini, oggetti
, Musei Civici,
Torino 1982
G.
Sergi (a cura di),
Storia di Torino
, I,
Dalla preisto-
ria al comune medievale
, Einaudi, Torino 1997
R.
Comba (a cura di),
Storia di Torino
, II,
Il basso me-
dioevo e la prima età moderna
, Einaudi,Torino 1997
Ne 1472 il Comune acquistò il primo nu-
cleo dell’attuale Palazzo Civico, mentre in
precedenza il consiglio comunale si riuniva
presso case private o nella Torre. L’attrazio-
ne esercitata dalla città dalla seconda metà
del Quattrocento invertì il flusso demogra-
fico negativo: al principio del Cinquecento
la popolazione raggiunse infatti le 5-6.000
unità, e si sviluppò nei sobborghi cresciuti
fuori porta Segusina e porta Doranea e sor-
ti vicino al ponte sul Po. Il Quattrocento
si chiuse con la trasformazione del vecchio
complesso della cattedrale: fu costruito un
nuovo grande campanile (1469), ma un ra-
dicale rinnovamento architettonico si ebbe
con
il vescovo Domenico della Rovere
,
mecenate che fece edificare il
nuovo duomo
secondo i dettami rinascimentali (estranei
fin allora al Piemonte) su progetto di Bar-
tolomeo di Francesco di Settignano, detto
Meo del Caprina: i lavori ebbero inizio nel
1491 e si protrassero fino al 1505, quando la
chiesa fu solennemente consacrata.
La città si prepara a essere
capitale del ducato
Negli anni delle
“guerre d’Italia”
tra Fran-
cesi e imperiali si susseguirono passaggi degli
eserciti dei re di Francia, ospitati nel castello
di Torino (Luigi XII nel 1507, Francesco I
nel 1515); per contrastare le mire dei fran-
cesi (che nel 1511 avevano ottenuto lo scor-
poro di Saluzzo dalla diocesi di Torino), il
duca Carlo II e il vescovo Giovanni Fran-
cesco della Rovere nel 1513 ottennero dal
papa che Torino divenisse sede arcivescovile.
Il duca fece anche costruire
quattro bastio-
ni agli angoli della cinta muraria
e un ba-
luardo davanti al castello. Ciò nonostante i
Francesi nel 1536 occuparono Torino con
facilità, bene accolti dagli abitanti, mentre
il duca e la corte si ritiravano a Vercelli. In
seguito i Francesi fecero radere al suolo i
borghi fuori le mura che impedivano il tiro
delle artiglierie: scomparvero così i borghi di
porta Segusina, di porta Dora e di Po e le
chiese suburbane, fra cui l’antica abbazia di
S. Solutore.
Nel 1538 il Piemonte sabaudo fu annesso
al regno di Francia
e nel 1539 Francesco I
istituì a Torino un Parlamento e la Corte dei
Conti, mentre l’università fu temporanea-
mente soppressa. Nel 1548 il re Enrico II
entrò trionfalmente a Torino, ora governata
da un viceré. Solo nel dicembre 1562 i fran-
cesi lasciarono la città: nel febbraio 1563 vi
sarebbe entrato il duca Emanuele Filiberto
che prese residenza nel palazzo dell’arcive-
scovo. Sotto i francesi la città ebbe
un im-
pulso economico e demografico
, anche se
le 10-12.000 unità furono superate solo con
il ritorno dei Savoia e con l’organizzarsi della
corte. La posizione geografica contribuì allo
sviluppo delle strutture ricettive di Torino:
si contavano, allora, oltre una cinquantina
fra alberghi e taverne e alcuni albergatori
raggiunsero un rango elevato, come i titolari
dell’albergo del
Cappel Rosso
, situato presso
l’incrocio di via Garibaldi con via Porta Pa-
latina e dotato di 14 letti e di una cantina di
cinque botti. Alla prima metà del Cinque-
cento risale anche la sistemazione dell’alber-
go della Corona Grossa (edificio tuttora esi-
stente in via IV Marzo), attestato nel 1523
come
Hospicium Corone
.
Con interruzioni e accelerazioni,
il Me-
dioevo di Torino preparò il definitivo
assestamento della città come capitale
del principato sabaudo
: una funzione
che per molti secoli, sino alla fine del
Duecento, non era stato affatto fra le sue
“vocazioni”, anche se la centralità rispetto
a un ampio territorio fu un suo caratte-
re indubbio già dall’alto Medioevo, con
la sola interruzione della dipendenza da
Ivrea dall’888 al 950.
Renato Bordone è stato professore ordinario pres-
so la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Torino.
Giuseppe Sergi è professore ordinario presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Torino.
14.244
5.000
4.500
3.100
8.000
1000
1325
1415
1500
1571
POPOLAZIONE
ANNO
POPOLAZIONE DI TORINO
Sotto gli Acaia la sede del governo della
città si collocava presso l’attuale piaz-
za Palazzo di Città
, detta
platea Taurini
o
platea civitatis
, allora collegata direttamente
con la piazzetta della chiesa di S. Gregorio
(ora San Rocco) di fronte alla Torre Civica,
all’incrocio fra le attuali vie Garibaldi e S.
Francesco. Nei pressi si teneva il mercato del
pesce, mentre il mercato del grano si svol-
geva davanti alla chiesa di S. Silvestro (ora
del Corpus Domini). Fra i muri della
platea
civitatis
c’erano i laboratori dei calzolai e i
banchi dei macellai, circondati da botteghe
artigiane. In questa fase, fu forte l’oscillazio-
ne demografica per le ricorrenti epidemie
diffusesi dal 1348 alla prima metà del Quat-
trocento: la popolazione si attestava proba-
bilmente allora sulle 3-4.000 unità.
Il Comune di Torino non aveva costruito, a
differenza dei maggiori Comuni piemonte-
si, un vasto distretto territoriale, ma – ere-
ditando in parte le 10 miglia di distretto
accordate da Federico Barbarossa al vescovo
nel 1159 – controllava un’area circostante
di circa 15 chilometri di raggio. Il territorio
extraurbano del Comune era delimitato a
nord dai borghi di Leinì, Caselle, Borgaro
e Settimo, a ovest da Collegno, Grugliasco
e Rivalta, a sud dal torrente Chisola e a est
dal crinale collinare esteso fra Moncalieri e
Gassino. Non esistevano borghi con proprie
comunità organizzate, tranne Grugliasco
(però infeudata nel Duecento ai signori di
Piossasco) e Beinasco, due dipendenze (“ti-
toli”) che Torino tenne per tutto l’antico re-
gime. Sulla destra del Po sorgeva la chiesa di
S. Vito «de Montepharato» con un piccolo
villaggio: a valle si poteva guadare il fiume
per raggiungere la chiesa di San Salvario.
Un vero centro abitato, detto Malavasio,
doveva sorgere in val S. Martino, e insedia-
menti sparsi si trovavano a Sassi. Sulla spon-
da sinistra tutta la zona pianeggiante era de-
finita la “campagna” (
Campanea
) di Torino,
come attesta ancora il nome di Madonna di
Campagna, mentre a occidente, sui diversi
sbocchi della
via Francigena
, si erano già svi-
luppati il borgo di S. Donato e di Colleasca
e le fondazioni ospedaliere di Pozzo Strada.
L’università e il duomo nuovo:
simboli di un prestigio in ascesa
Un primo segnale del rinnovamento urbano
fu nel 1404 la concessione, da parte del papa
avignonese Benedetto XIII, di istituire uno
Studium Generale
a Torino, confermata nel
1412 dall’imperatore Sigismondo. Al prin-
cipio l’università funzionò in modo discon-
tinuo, perché i docenti preferivano risiedere
e insegnare a Chieri e a Savigliano, consi-
derati più salubri durante le epidemie; nel
1436 il consiglio comunale di Torino riuscì
a ottenere patenti ducali che stabilirono in
città la sede definitiva dello
Studium
. L’edi-
ficio, ora non più esistente, sorgeva in via S.
Francesco, davanti alla chiesa di S. Rocco e
accanto alla Torre Civica.
Da quando nel 1418 era passata alle di-
pendenze dirette del duca Amedeo VIII di
Savoia, Torino si avviò a diventare uno dei
centri burocratici più importanti del ter-
ritorio sabaudo. Grazie anche al prestigio
della
sede episcopale, la città fungeva occa-
sionalmente da
sede del principe e della
corte
; in particolare vi si riuniva spesso il
Consilium cum domino residens
, organismo
itinerante al seguito del signore con funzioni
politico-amministrative e giudiziarie su tutti
i domìni. In seguito un nuovo organismo
amministrativo con competenze specifiche
per l’area di qua dalle Alpi, chiamato
“con-
siglio cismontano”
, fissò la propria sede a
Torino, in considerazione della collocazione
stradale della città verso la pianura lombar-
da; dal 1459, infine, vi si stabilì in modo
permanente, riunendosi nel castello di Porta
Fibellona, anche per agevolare la partecipa-
zione di personale burocratico uscito dallo
Studio torinese.
Il Duomo con il campanile quattrocentesco, coronato da Juvarra nel Settecento (fotografia di P. Gonella).
*
I dati demografici sono tratti da G. Melano,
La
popolazione di Torino e del Piemonte nel secolo XIX
,
Torino, 1961; R. Zangheri,
La popolazione italiana in
età napoleonica
, Bologna, 1966; U. Levra,
L’ altro vol-
to di Torino risorgimentale, 1814-1848
, Torino, 1988.
*