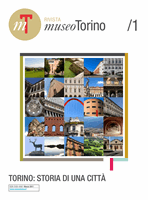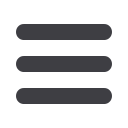
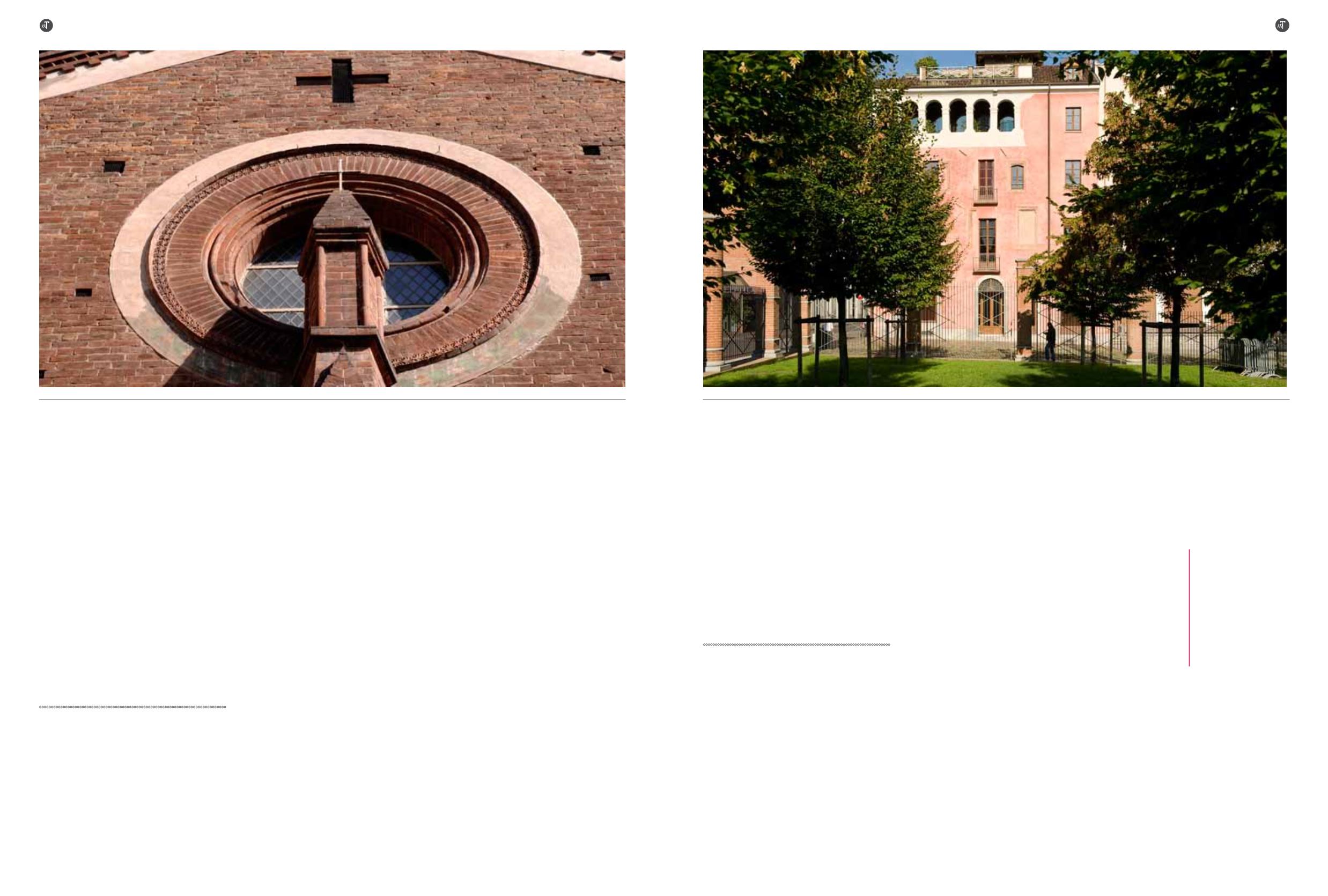
La città medievale
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
34
35
ri signorili locali
(i Baratonia, i Rivalta, i
Piossasco e numerosi altri), mentre tutto il
Piemonte meridionale smise di orbitare su
Torino, divenendo teatro di altre afferma-
zioni (i marchesi di Monferrato e di Saluz-
zo), e si instaurarono anche poteri signorili
di monasteri, come S. Giusto di Susa e S.
Michele della Chiusa. A Torino ebbe gran-
de sviluppo il monastero di S. Solutore: dal
centro torinese (vicino all’attuale corso Pa-
lestro) l’abbazia compì ricche acquisizioni
patrimoniali (in particolare a Sangano e a
Carpice, nel territorio di Moncalieri) dove
esercitava anche poteri signorili.
La nascita del Comune
e l’ascesa dei Savoia-Acaia
Nei primi decenni del secolo XII al potere
ecclesiastico si affiancò quello del Comu-
ne, costituito da famiglie ricche, prevalen-
temente grazie al prestito di denaro, che
si potenziarono in accordo con il vescovo,
al quale prestavano omaggio vassallatico.
L’alleanza fra i due attori si cementò grazie
alla condivisa resistenza all’avanzata dei Sa-
voia, il cui potere era allora solido fino ad
Avigliana. Il Comune torinese innescò an-
che concorrenze e provvisorie alleanze con
comuni limitrofi come Chieri e Testona. Le
sue famiglie dominanti avevano caratteri
sociali ambigui, in parte borghesi in parte
aristocratici, collocavano propri membri
nel collegio dei canonici della cattedrale e
proteggevano quegli enti religiosi che, non
limitandosi a essere comunità di preghie-
ra, fornivano alla società torinese servizi
ospedalieri e di accoglienza dei viandanti.
Un ricco torinese, Pietro Podisio, appunto
per scopi di utilità sociale, fondò nel 1146
l’abbazia-ospedale di San Giacomo di Stura
(oggi Badia di Stura).
Nel Duecento due zone della città contene-
vano i poli di governo del Torinese: quelle in
cui ancora oggi si trovano la
cattedrale
e il
municipio
. Nel
1280
il marchese Gugliel-
mo VII di Monferrato cedette Torino a
To-
maso III di Savoia
, ma la successione passò
al fratello Amedeo V che nel 1294 lasciò al
nipote
Filippo d’Acaia
, figlio di Tomaso, i
domìni del Piemonte e la città. Con il pas-
saggio sotto i Savoia tramontò l’autonomia
politica del Comune di Torino, anche se
l’organismo dirigente comunale soprav-
visse, controllato dal patriziato urbano che
occupava e controllava l’accesso ai seggi del
Consiglio comunale diventati poi ereditari.
Un estremo tentativo di rivolta anti-sabauda
si manifestò ancora nel 1334, soffocato da
dure repressioni da parte del principe che, al
tempo stesso, favorì l’istituzione della «So-
cietà popolare di S. Giovanni» per bilancia-
re il potere magnatizio, allargando ai nuovi
ceti produttivi, che ne erano ancora esclusi,
la partecipazione alla vita amministrativa del
Comune.
Al principio del
Trecento
Filippo – il cui
titolo di principe d’Acaia derivava dal ma-
trimonio con Isabella, figlia del principe
d’Acaia Gugliemo II di Villehardouin – go-
vernava anche l’area meridionale dell’attuale
provincia di Torino e quella intorno a Pine-
rolo, dove di preferenza risiedeva: il princi-
pe mantenne tuttavia interesse per la città,
facendo ristrutturare fra il 1317 e il 1320
il preesistente castello di Porta Fibellona,
attuale Palazzo Madama. La sua funzione
prevalente, come
sede di guarnigio-
ne, era esercitare il
controllo sugli abi-
tanti della città dalla
quale era separato
dal fossato e dal
ponte levatoio. A
metà del XIV secolo
Giacomo d’Acaia,
con velleità indi-
pendentiste, provocò la reazione di Amedeo
VI che lo dichiarò decaduto, avocando a sé
il principato: Torino accolse di buon grado
il
Conte Verde
, perché nel 1360 egli resti-
tuì al Comune la libertà legislativa insieme
all’approvazione della raccolta dei nuovi sta-
tuti (Libro della Catena). Pur sotto i Savoia,
dal 1362 i reinsediati Acaia rimasero al potere
ancora mezzo secolo: il castello di Porta Fibel-
lona al principio del Quattrocento fu restaura-
to e ampliato dal principe Ludovico, che morì
senza discendenza nel 1418 consentendo ad
Amedeo VIII di incorporare nel suo Stato la
grande dominazione del Piemonte.
La casa di Emanuele Filiberto Pingone, inserita nel progetto di valorizzazione dell’area della Porta Palatina (fotografia di M. Saroldi).
il Medioevo di
Torino preparò
il definitivo
assestamen-
to della città
come capitale
del principato
sabaudo
rino
spiega anche perché oltre ad Agilulfo
altri due duchi torinesi (Arioaldo e Ragim-
perto) ottennero la corona del regno dei
Longobardi e si trasferirono nella capitale
Pavia.
I gruppi tribali multietnici a conduzione
longobarda furono tuttavia limitati: le due
necropoli
conosciute più consistenti sono
presso Testona, con 350 sepolture comprese
fra il secolo VI e il VII, e a Collegno, con 73
sepolture collocabili fra il secolo VI e l’VIII.
Tracce dell’insediamento longobardo nei se-
coli VI-VIII sono in città, presso la chiesa
di S. Giovanni, e, nel suburbio, a nord di
Pecetto, presso la chiesa collinare di S. Vito,
nei pressi dell’attuale via Nizza, al Lingotto,
a Sassi, a Fioccardo (sugli odierni confini di
Torino verso Moncalieri) e nell’area di Ma-
donna di Campagna.
LaMarca d’Ivrea e il crescente
potere ecclesiastico
Di Torino subito dopo l’arrivo dei Franchi,
che superarono le Chiuse di Susa nel 773, le
fonti dicono poco. Il personaggio più noto
di quella fase è il vescovo Claudio (816-
827), un intellettuale capace anche di con-
durre imprese militari, in quanto maggiore
figura di comando riconosciuta dagli abi-
tanti. Esisteva, tuttavia, un
comitatus
civile
(provincia governata da un conte) di Torino,
e ne abbiamo la prova quando, nell’880, un
conte di nome Suppone presiede il tribunale
a Torino, prima della deposizione dell’impe-
ratore Carlo il Grosso nell’888.
Dall’888 al 950, senza la presenza dei re
carolingi, il comitato fece parte di una cir-
coscrizione maggiore, la
Marca con capo-
luogo a Ivrea
: su Torino si estese quindi il
governo di marchesi (Anscario I e II, Adal-
berto, Berengario II) che risiedevano nel
capoluogo eporediese. Torino mantenne
tuttavia la funzione di centro del suo
co-
mitatus
sia nel periodo dei diversi re che si
alternarono sul trono d’Italia, sia durante il
governo dei re sassoni (gli Ottoni). Dal 950
al 1091 la città fu capoluogo, oltre che del
comitato, di una Marca vastissima che com-
prendeva anche Asti, Alba, alcuni comitati
senza centri urbani (Auriate e Bredulo) e la
Liguria occidentale (Albenga e Ventimiglia).
In questa fase del Medioevo la “centralità”
di Torino si applicò alla regione più ampia,
e il controllo delle strade (in particolare la
via Francigena
della valle di Susa diretta ver-
so il valico del Moncenisio) fu totalmente
appannaggio dei marchesi torinesi.
In quel periodo
la sede urbana del potere
si spostò
, allontanandosi dalla Porta Palati-
na, cuore dei poteri romano e longobardo,
verso la “porta di Susa”
della città, presso
la quale aveva sede il palazzo da cui i mar-
chesi di Torino amministravano il potere.
Questi influenti governatori (Arduino III,
Manfredo, Olderico Manfredi) appartene-
vano alla dinastia degli Arduinici, ma non
sembra fossero parenti del celebre re Ardui-
no d’Ivrea. Dopo la morte del marchese Ol-
derico Manfredi (1035) la dinastia fu tenuta
insieme da una donna, la contessa Adelaide,
che governò “di fatto” in vece di una serie
di marchesi maschi: in successione, tre suoi
mariti (sempre prematuramente morti), un
figlio e un marito della figlia.
La Marca si
sfaldò nel 1091
, appunto con la morte di
Adelaide. Da quell’anno
il
vuoto di pote-
re consentì ai vescovi di incrementare la
propria influenza
anche in ambito civile
sulla città (pur non corrispondendo all’idea
dei vescovi-conti che ci è stata erroneamente
tramandata), mentre il Torinese diventava
campo di concorrenze tra forze signori-
li diverse e le periferie della grande Marca
svincolavano la propria storia dal loro antico
centro di riferimento.
Il potere “allargato” dei vescovi su Torino e
sul territorio, che durerà sino all’afferma-
zione dei Savoia nel 1280, venne esercitato
dalla
cattedrale
, di nuovo quindi nella zona
della Porta Palatina. L’area governata non
era tuttavia molto estesa: la frontiera rispet-
to ai Savoia si collocò per circa due secoli
a Rivoli, in linea con il castello del vescovo
affidato a una famiglia di funzionari (
advo-
cati
) proveniente dalla collina torinese: i si-
gnori di Moncucco. Altro castello vescovile
importante - usato talora come residenza ve-
scovile - era quello di Testona, insediamento
che si sviluppò in quegli anni nella nuova
fondazione di Moncalieri.
Intorno alla città si radicarono pote-
Particolare della Chiesa di San Domenico (fotografia P. Martelli).