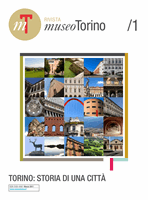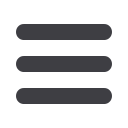

La città antica
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
24
25
magazzino (
horreum
) accoglieva le merci
che giungevano per via fluviale. Le abita-
zioni private, soprattutto con gli inizi del
II secolo, furono ristrutturate e ampliate,
dotate in molti casi di impianti di riscal-
damento e decorate, negli ambienti di
rappresentanza, con affreschi e mosaici
mentre i vani di servizio erano pavimentati
in cementizio e gli esterni spesso lastricati
con laterizi posati a secco.
Torino tardoantica e cristiana
fino al VI sec. d.C.
Torino torna a essere menzionata nelle
fonti letterarie, segno di un’accresciuta im-
portanza strategica, solo in età tardo-anti-
ca, in seguito alla
crisi del III secolo
e alla
ristrutturazione imperiale
del IV. In una
posizione di controllo sulla via delle Gallie
e in direzione del
limes
renano – funzio-
ne che, invero, non aveva mai perso, ma
che assume un nuovo significato, specie
a partire dalla fase centrale del III secolo
in coincidenza con la breve vita dell’Im-
pero secessionista delle Gallie (259-274
d.C.) – Torino vide numerosi e frequenti
passaggi di truppe imperiali, dirette ora
contro usurpatori militari ora a impedire
le scorrerie di gruppi barbarici al di qua del
confine settentrionale. Proprio questo suo
ruolo di “cerniera” tra Italia settentrionale e
territori transalpini, nonché la vivacità del-
la comunità cristiana raccolta attorno alla
figura del vescovo Massimo ridiedero fiato
a una realtà locale che pur nella sua mar-
ginalità recuperava identità e ruolo sociale
e politico. La diffusione del Cristianesimo
nell’area dell’attuale Piemonte settentrio-
nale avvenne a partire dagli anni Quaranta
del IV secolo ed ebbe come primo centro
propulsore Vercelli, sotto la guida del ve-
scovo Eusebio. Negli anni compresi tra la
morte di Eusebio (371) e quella di Am-
brogio di Milano (397), anche
Torino si
costituì in diocesi autonoma
con il suo
primo vescovo Massimo. Si avviò allora
un profondo processo di trasformazione
non solo civile e religiosa, ma anche ur-
banistica, a partire dalla costruzione delle
chiese e della sede episcopale, che segnerà
lo sviluppo della città nei secoli a venire.
Pur subendo la forte influenza della dio-
cesi ambrosiana, l’episcopato di Massimo
fu segnato dalla sua forte personalità e
dalla sua vigorosa e intransigente azione
pastorale. Di notevole importanza fu il
sinodo vescovile, voluto e predisposto da
Ambrogio, che si tenne a Torino nel 398
d.C. Principale scopo del sinodo fu quello
di ricomporre i numerosi conflitti sorti fra
i vescovi e le diocesi delle Gallie. I delibe-
rati di quel consesso, di là dalle questioni
specifiche trattate e solo in parte risolte,
confermano peraltro la testimonianza di
Massimo sulla dimensione non consolida-
ta, disomogenea e difficilmente governabi-
le del cristianesimo torinese tra fine IV e
inizio V secolo, ulteriormente complicata
dall’instabilità politica e dalla conflittuali-
tà sociale.
Dal punto di vista dell’evoluzione urbani-
stica, si è discusso a lungo sulle tre chiese
che formavano nel Medioevo il gruppo
episcopale della diocesi torinese, rispetti-
vamente dedicate a Cristo Salvatore, a San
Giovanni e a Maria, e su quale sia stata la
prima a essere edificata.
Smentite le teorie del passato, è oggi possi-
bile seguire la complessa storia del gruppo
“cattedrale” attraverso i nuovi dati archeo-
logici acquisiti con le indagini iniziate nel
1996 nel sottosuolo di piazza S. Giovanni,
tra il duomo e il teatro romano, e prose-
guite a più riprese nella cripta dello stesso
duomo, sotto l’ingresso secondario meri-
dionale e sotto la scalinata davanti alla fac-
ciata. Negli scavi della primavera del 1909
erano stati portati in luce i resti della basi-
lica del Salvatore, ma i “ruderi” erano stati
reinterrati dopo la rimozione del mosaico
romanico pavimentale. A un secolo di di-
stanza si è scelto invece di riportare alla
luce e conservare in vista le strutture delle
basiliche paleocristiane
, offrendo al pub-
blico la possibilità di ritrovare nelle aree
archeologiche sotterranee non soltanto i
resti della città antica, ma anche le testi-
monianze materiali delle sovrapposizioni e
delle trasformazioni di epoca medievale e
moderna.
L’isolato scelto dalla comunità cristiana
per costruire la cattedrale è quello a sud
del teatro, ormai chiuso agli spettacoli,
sull’altro fronte dell’ampia strada dove
si trovavano edifici pubblici di cui non è
conosciuta la funzione ma che rivelano
imponenti murature, ben diverse da quel-
le delle case private precedenti, probabil-
mente demolite intorno alla metà del II
secolo d.C. Per costruire gli edifici di culto
si utilizzarono le fondazioni più antiche,
mentre laterizi, pietre e legname venne-
ro recuperati e rimessi in opera; i grandi
blocchi allineati lungo la strada a forma-
re un nuovo marciapiede provengono dal
teatro, a riprova che ormai il vescovo po-
teva disporre dell’edilizia pubblica e aveva
assunto la responsabilità civile, oltre che
religiosa, della città, non più sorretta da
Particolare del pannello figurato centrale con un amorino alato che cavalca un delfino, ritrovato nella
domus
romana di via Bonelli (fotografia di P. Martelli).
tensa attività mercantile attraverso tutta la
Pianura Padana, costellata di porti fluviali
ed empori commerciali, è lecito supporre
che un’attività analoga, sia pure assai più
limitata, si svolgesse anche prima della
colonizzazione romana. Anche in ragione
di ciò molti studiosi tendono a risolvere il
problema dell’incerta collocazione della
capitale dei Taurini supponendo che essa
sorgesse in prossimità della
confluenza
del fiume Dora nel fiume Po
, sito par-
ticolarmente favorevole dal punto di vista
commerciale e strategico.
Per quanto indicano le ricerche archeolo-
giche fino a ora condotte, non vi è nessuna
continuità insediativa tra il centro taurino
e quello romano e si è ipotizzato, anzi, che,
dopo la distruzione annibalica, gli indige-
ni superstiti non abbiano ricostruito la cit-
tà né nel medesimo luogo né con le stesse
modalità, ma abbiano preferito strutturar-
si in un insediamento sparso costituito da
più villaggi; anche in questo caso però re-
stiamo nell’ambito delle congetture plau-
sibili ma non comprovabili.
Pure sull’
origine dell’etnonimo Taurini,
o Taurisci
, risulta esistere, già nelle fonti
antiche (Catone, Polibio, Strabone, Pli-
nio) un certo grado di confusione; l’unico
elemento che sembra accomunare tutte le
testimonianze è la loro collocazione geo-
grafica in ambito alpino; è quindi plau-
sibile che il termine stesse a indicare non
tanto un gruppo etnico definito, quanto
appunto un insieme di tribù accomunate
dallo stanziamento nei territori posti in
prossimità dell’arco alpino.
La fondazione di Augusta Taurinorum
e i primi secoli dell’impero
L’attenzione di Roma per il quadrante
nord-occidentale dell’Italia settentrionale,
a nord del Po, fu tardiva. Nel 100 a.C. ven-
ne fondata la colonia di
Eporedia
(Ivrea),
base militare delle campagne contro i
Salassi, stanziati tra alto Canavese e Valle
d’Aosta, nel cui territorio si trovavano le
importanti e redditizie miniere d’oro della
Bessa controllate proprio dai Salassi. In se-
guito – prima con
Cesare
nella prospettiva
della conquista gallica e poi con
Augusto
nel suo disegno di espansione verso il cen-
tro-nord Europa, e in particolare verso la
Germania – il sito alla confluenza di Po e
Dora divenne strategicamente importante
come retrofronte attrezzato per gli eserciti
che si dirigevano a ovest verso il passo del
Monginevro, e a nord verso i colli del Pic-
colo e del Gran San Bernardo.
La
fondazione della colonia
di
Augusta
Taurinorum
si data oggi tra il 25 e il 15
a.C., periodo durante il quale Augusto si
dedicò alla “pacificazione” delle Alpi. Con
il drastico ridimensionamento del suo
progetto di portare i confini centroeuropei
dell’impero fino al corso del fiume Elba,
in seguito alla disfatta romana nella selva
di Teutoburgo (9 d.C.), anche l’importan-
za di
Augusta Taurinorum
nell’ottica della
politica imperiale diminuì notevolmente.
La città non è più menzionata nelle fonti
letterarie, fatta eccezione per alcuni spora-
dici casi legati a episodi che videro il mo-
vimento di truppe transfrontaliere, come
ad esempio la menzione in Tacito del bur-
rascoso passaggio delle coorti di Vitellio
durante la guerra civile del 69 d.C., suc-
cessiva alla morte di Nerone. L’archeologia
e le iscrizioni ci permettono di confermare
l’esistenza di un centro urbano con una
discreta vitalità in ambito locale: nel I e II
secolo d.C. sono attestati, a livello epigra-
fico, artigiani dediti alla
lavorazione di ve-
tri e metalli
e alla
produzione di laterizi
e vino
, nonché numerosi soldati, sparsi in
tutto l’impero, originari di
Augusta Tauri-
norum
. Nel contempo, non pochi abitanti
della colonia testimoniano una condizione
di progressivo miglioramento del proprio
status sociale e si ha notizia di personaggi
che ebbero una carriera politica non sol-
tanto in ambito locale, ma anche – seppur
in casi molto rari – a livello imperiale.
All’
aristocrazia taurinense
appartennero
due famiglie, almeno un paio di membri
delle quali, Caio Rutilio Gallico e Quin-
to Glizio Atilio Agricola, risultano avere
raggiunto i vertici della carriera senatoria
e avere rivestito cariche politiche e militari
di alto livello fra l’età claudia (Gallicus ini-
zia la carriera nel 43-44 e Glizio Barbaro
dedica un monumento a Claudio nel 48) e
l’età traianea (Agricola, riveste il consolato
per la seconda volta nel 103). Sappiamo
per certo, inoltre, che quantitativamente
la popolazione cittadina non dovette mai
superare le poche migliaia di unità.
Per quanto si riferisce all’
impianto ur-
banistico
, la fortunata sopravvivenza di
molti tratti della cerchia delle mura del-
la città romana consentono di definire le
dimensioni di
Augusta Taurinorum
, che
occupava uno spazio rettangolare di circa
700 x 750 m (2400 x 2555 piedi romani,
per un’area corrispondente a circa 50 etta-
ri, equivalenti a una
centuria
romana) con
l’angolo nord-est tagliato in diagonale:
questo tratto obliquo delle mura, situato
in corrispondenza degli odierni Giardini
Reali, può essere stato imposto dalla pros-
simità allo sbalzo di quota del terrazzo flu-
viale. Delle quattro porte principali poste
a capo del cardine massimo, ricalcato dalle
vie San Tommaso e Porta Palatina, e del
decumano massimo, l’attuale via Garibal-
di, si conservano la Porta Palatina e quella
inglobata in Palazzo Madama. La trama
delle strade era regolare e riflessa nella ca-
denza delle torri di cortina, ma i moduli
degli isolati risultano leggermente variabi-
li. Caratteristica è l’
ortogonalità del reti-
colo viario
dell’attuale “Torino quadrata”,
che ancora riflette l’assetto romano, ma
va considerato che in buona parte è frut-
to dei “dirizzamenti” della seconda metà
del Settecento, che riallinearono le facciate
sulle principali arterie stradali modificate
in epoca medievale, e dei “risanamenti”
ottocenteschi del superstite tessuto medie-
vale, che invece aveva alterato nei secoli il
disegno urbano originale.
Fino a ora le ricerche archeologiche non
hanno restituito contesti significativi per
il periodo iniziale della colonia e quasi
nulla sappiamo dell’impianto urbano al
momento della sua fondazione. Risalgo-
no certamente all’epoca augustea le prime
semplici strutture del teatro e nei decenni
seguenti si collocano sia i primi interventi
di costruzione della
cinta muraria
, uno
dei maggiori segni lasciati dall’impianto
romano alla città moderna, sia la ristruttu-
razione del
teatro
, trasformato in un edi-
ficio più complesso e dotato di un portico
dietro la scena (
porticus post scaenam
). Non
sappiamo dove si trovasse il foro, centro
nevralgico della vita pubblica di ogni città
romana, forse po-
sto in corrispon-
denza dell’attuale
piazza Palazzo di
Città.
In questa prima
fase le abitazioni,
di cui conosciamo
solo pochi e fram-
mentari elementi,
erano edifici molto
semplici e di scarsa
qualità e le infra-
strutture urbane erano praticamente assenti.
Negli
ultimi decenni del I secolo d.C
.
(età flavia) viene ultimata la cortina mura-
ria e a ridosso del lato orientale si formano
presto zone di discarica, sia all’interno del-
le mura, sia all’esterno, dove si raccolgo-
no anche i rifiuti delle attività artigianali
urbane, forse impiantate nelle vicinan-
ze. Contemporaneamente viene avviata
un’importante ristrutturazione urbana
che vede la realizzazione di un’articolata
rete fognaria e, probabilmente, dell’acque-
dotto; le strade vengono pavimentate con
grosse pietre e una via pubblica larga tra
i 55 e i 60 piedi romani corre all’interno
lungo tutto il circuito murario. Fuori dalle
mura, a sud ovest, doveva probabilmente
sorgere un anfiteatro di cui però non si
conservano le tracce archeologiche, men-
tre sulle rive del Po, in corrispondenza
dell’odierna piazza Vittorio, un grande
Sulle rive del
Po, nell’odierna
piazza Vitto-
rio, un grande
magazzino (
hor-
reum
) accoglie-
va le merci che
giungevano per
via fluviale