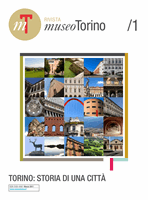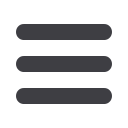
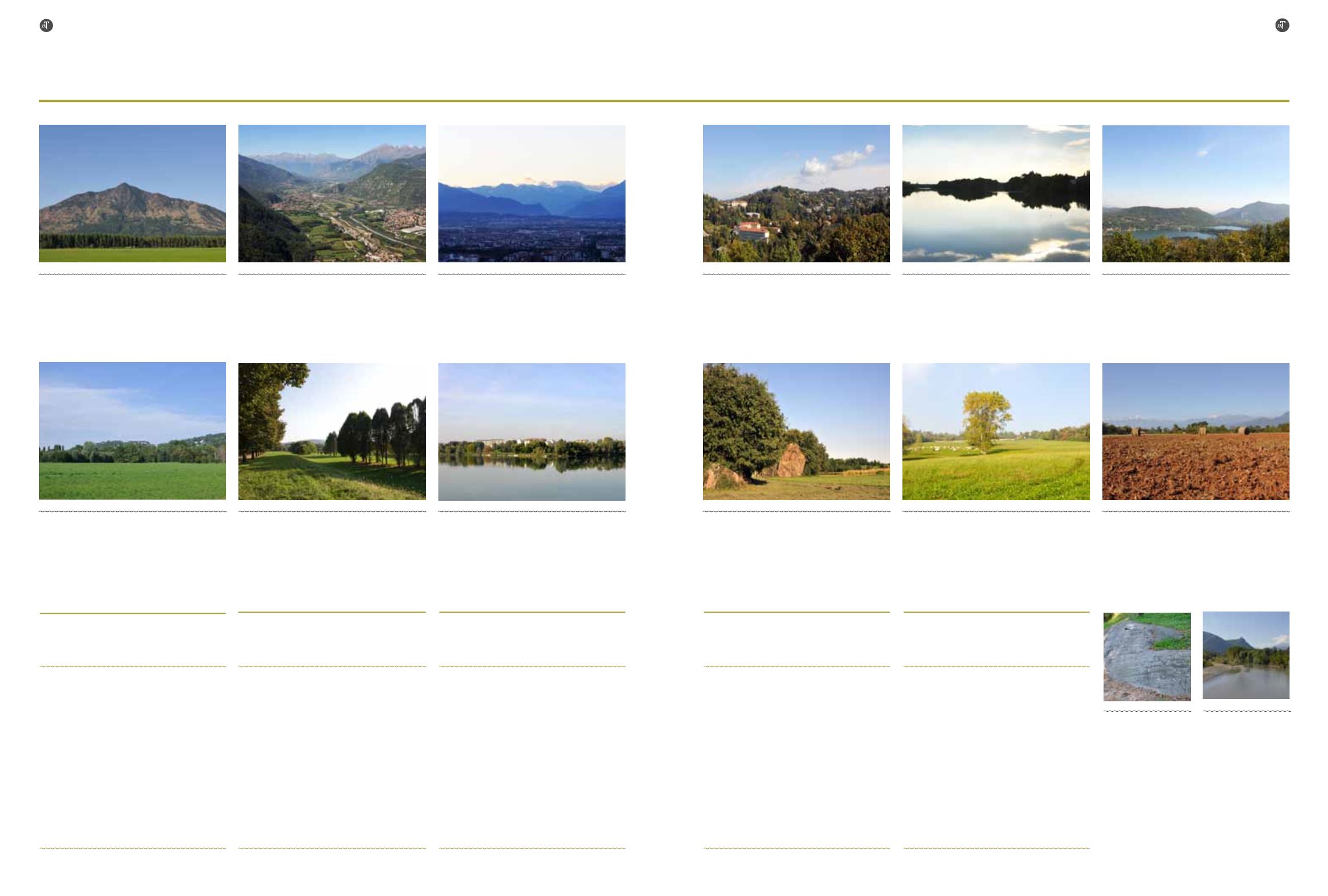
Prima della città
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
18
19
Il ghiacciaio della
Valle di Susa ha la-
sciato traccia del suo
passaggio levigando
e striando le rocce
(“montonate”) del
substrato roccioso.
Un tratto della Dora
Riparia in prossimità
dell’abitato di Aviglia-
na, in “bassa” Valle
di Susa.
Le superfici terrazzate presenti sul versante
occidentale della Collina di Torino sono i lembi
di un’antica pianura sagomata dai corsi d’acqua
che facevano parte del bacino piemontese
settentrionale.
I massi erratici di Pera Majana sono stati prele-
vati e poi depositati diversi chilometri più a valle
dal ghiacciaio della Valle di Susa, dopo il crollo
o l’indebolimento degli ammassi rocciosi erosi
dallo stesso ghiacciaio.
L’andamento del Po nel tempo è stato fortemente
condizionato dalla mano dell’uomo; lungo questo
tratto, presso San Mauro, sono presenti opere
di difesa spondale che per lunghi tratti hanno
risagomato e stabilizzato la configurazione del
corso d’acqua.
La sella nella zona detta l’Eremo è una de-
pressione allungata che articola lo spartiacque
principale della Collina ed è delimitata da due
rilievi.
I due laghi di Avigliana e le cerchie moreniche
che li delimitano rappresentano le tracce di uno
degli ultimi episodi di espansione del ghiacciaio
della Valle di Susa, ascrivibile verosimilmente agli
ultimi 15.000 anni.
L’aratura dei campi nella zona di Piossasco, Vol-
vera e dintorni mette in luce i depositi di glacis
caratterizzati dalla colorazione rossa legata alla
loro età antica.
10.000 anni fa - 2.000 anni
a.
C
.
Neo-Po e attuale reticolato idrografico
• Il margine alpino e la collina di To-
rino sono ormai strutturati. La mag-
gior parte dei fiumi ha assunto un
andamento simile all’attuale e depo-
ne
sedimenti sabbiosi e limosi
sulle
proprie sponde.
• Il
clima
è generalmente più caldo ri-
spetto al precedente periodo glaciale.
• I
cacciatori/raccoglitori
del Neo-
litico (6000-3500 a.C.) diventano
agricoltori/allevatori.
2.000-218
a.
C
.
Dai primi abitanti del Piemonte aiTaurini
• Nell’età del Bronzo (2.200-900 a.C.)
tutto il Piemonte è al centro di una
cre-
scita demografica
, favorita dalla navi-
gazione fluviale.
• Nell’Età del Ferro (900-200 a.C.) il To-
rinese è collegato alle culture del mon-
do “hallstattiano” alpino e transalpino.
• Nel IV secolo a.C. le
invasioni galliche
portano a uno sconvolgimento sociale,
politico e commerciale.
• Assume rilievo la “città dei Taurini”,
fino al 218 a.C., data del passaggio di
Annibale.
i luoghi
Fotografie di Patrizia Mussa
Veduta del monte Musiné da Sant’Antonio di
Ranverso. Il settore interno dell’Anfiteatro Mo-
renico di Rivoli-Avigliana, nel tratto compreso
tra Sant’Antonio di Ranverso e Alpignano è
caratterizzato da un esteso e piatto fondovalle
alluvionale.
La bassa Valle di Susa e il suo sbocco in pia-
nura si possono osservare nella loro completa
estensione dai maggiori rilievi che la delimitano,
ma anche dalla Sacra di San Michele si ha un
ottimo punto panoramico.
Il Parco della Colletta è uno dei settori altime-
tricamente più depressi del comune di Torino. È
situato a 215 metri sul livello del mare, mentre
il centro urbano della città (ad esempio piazza
Castello) è posto a circa 240 metri di quota.
La Valle di Susa, o Valle della Dora Riparia, fa
parte di un sistema vallivo di origine preva-
lentemente glaciale con sviluppo in direzione
est-ovest, trasversale rispetto all’arco alpino ed
allungato fra le Alpi Cozie e le Alpi Graie.
Il punto di confluenza tra il fiume Stura di Lanzo
e il fiume Po: è un’area, a circa 210 m sul
livello del mare, caratterizzata dalla presenza
di un settore pianeggiante che si incunea tra le
incisioni dei due corsi d’acqua.
5 milioni-2,5 Milioni di anni fa
Emersione della collina torinese dal
mare piemontese
• In un clima subtropicale, nel territo-
rio “piemontese” è presente un mare
“antico”, residuo dell’oceano
Tetide
.
• Nel
“golfo padano
”, che accoglie il
Mediterraneo, il fondale subisce un
progressivo sollevamento che porta
al
ritiro delle acque
.
• Inizia a emergere la
collina di Tori-
no
e prendono forma i primi corsi
d’acqua.
2,5 milioni-700.000 anni fa
Il paleo-Po a sud della collina di Torino
• Nelle aree più depresse si formano pa-
ludi con i
depositi “villafranchiani”.
• I corsi d’acqua alpini formano, ai
piedi dei rilievi, conoidi fluviali ric-
chi di detriti.
• Le acque raccolte nel
Bacino pie-
montese meridionale
confluiscono
nel
paleo-Po
; le acque del
Bacino
piemontese settentrionale
corrono
invece a nord.
• Nel settore alpino iniziano a formarsi
i
ghiacciai
.
700.000-10.000 anni fa
Espansioni dell’anfiteatro morenico
di Rivoli-Avigliana
• Le deposizioni di sedimenti del
“ghiacciaio della Valle di Susa” danno
forma, nel loro insieme, all’
anfiteatro
morenico di Rivoli-Avigliana
.
• All’esterno dell’anfiteatro, le acque
di fusione del ghiacciaio sboccano in
pianura formando ampi depositi di
terreni: uno di questi accoglie oggi il
centro urbano di Torino
.
• I due gradi bacini idrici, piemontese
settentrionale e piemontese meridio-
nale, sono tra loro separati dalla “
so-
glia di Moncalieri
”.
Parco delle Vallere, attuale superficie di esonda-
zione del fiume Po con, sullo sfondo, la Collina
di Torino. L’area pianeggiante in cui si colloca
il parco è il risultato della variazione nel tempo
del punto di confluenza tra il Sangone e il Po.