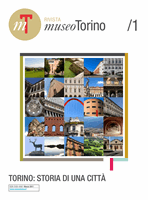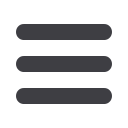
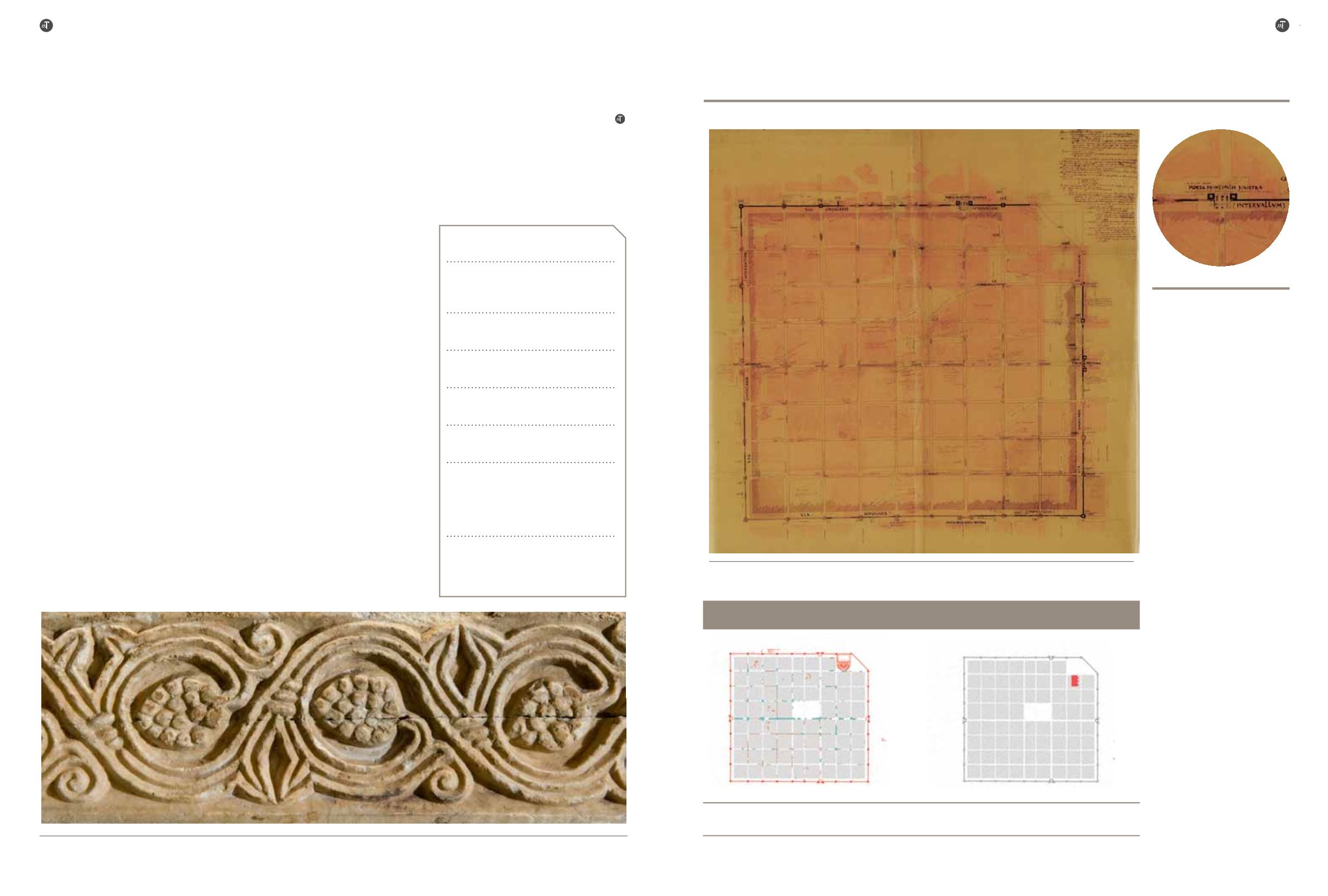
La città antica
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
26
27
le mappe
Alfredo d’Andrade,
Pianta della città romana
, 1900 ca. (Fondazione Torino Musei,Archivio Fotografico,
Fondo d’Andrade
, LT 1889)
Da Leggere
G. Cantino Wataghin,
L’archeologia della città
,
in V. Castronovo (a cura di),
Storia illustrata di
Torino
, I, Sellino, Milano 1992, pp. 61-80
L. Cracco Ruggini,
Torino
romana e cristiana
, in V.
Castronovo (a cura di),
Storia illustrata
cit., pp. 21-40
S. Roda,
Torino colonia romana
, in V. Castronovo
(a cura di),
Storia illustrata
cit., pp. 1-21
G. Sergi (a cura di),
Storia di Torino
, I,
Dalla prei-
storia al comune medievale
, Einaudi, Torino 1997
L. Mercando (a cura di),
Archeologia a Torino
.
Dall’età
preromana all’Alto Medioevo
,Allemandi,Torino 2003
A. Gabucci, L. Pejrani Baricco,
Elementi di edilizia
e urbanistica di
Augusta Taurinorum
.
Trasforma-
zioni della forma urbana e topografia archeologi-
ca
, in
«Intra illa moenia domus ac Penates»
,
atti
del convegno, Quasar, Roma 2009, pp. 225-241
C. Franzoni,
Le mura di Torino: riuso e “potenza
delle tradizioni”
, in E. Castelnuovo (a cura di),
Torino. Prima Capitale d’Italia
, Istituto della Enci-
clopedia Italiana Treccani, Roma 2011.
un’efficiente organizzazione istituzionale e
minacciata dal continuo passaggio di eser-
citi, regolari o meno, da scorrerie di tribù
barbariche, nonché da insediamenti nelle
campagne di gruppi germanico-slavi, sia
giuridicamente legittimati sia invasori.
La
chiesa del Salvatore
è quella oggi me-
glio nota: a tre navate separate in origine
da colonnati, era conclusa da una profon-
da abside semicircolare a oriente, ritrovata
in parte sotto il braccio nord del transet-
to del duomo. Sul lato verso il teatro era
affiancata da una sorta di quarta navata,
mentre dall’altro lato doveva trovarsi il
battistero, forse inizialmente costituito da
un’aula absidata precedente la
basilica di
S. Giovanni
. Questa chiesa, che nel corso
del VI secolo prevalse sulle altre diventan-
do sede della cattedra del vescovo e che ha
trasmesso il titolo e il ruolo di cattedrale al
duomo attuale, non si è purtroppo conser-
vata perché il suo perimetro ricadeva nella
navata centrale della cripta rinascimenta-
le, sbancata fino a notevole profondità. Si
sono ritrovate però le tracce di un grande
cantiere, attivo tra la fine del V secolo e gli
inizi del VI, legato alla sua edificazione e
alla creazione della
chiesa di Santa Maria
,
ora individuata e ricostruibile nella sua plani-
metria, anche se in gran parte celata nel sot-
tosuolo del settore meridionale della piazza.
La prima cattedrale fu dunque la basilica
del Salvatore, con il battistero a sud; tra
la fine del V e gli inizi del VI secolo si ag-
giunsero le chiese di San Giovanni e Santa
Maria, che vennero a formare un eccezio-
nale complesso di tre basiliche gemelle
adiacenti e allineate, che non ha confronti
nell’Occidente cristiano.
Nell’area dell’attuale Cittadella sorgeva
l’importante abbazia benedettina di San
Solutore, fondata nel 1006 fuori dalla Por-
ta Segusina, dove già molto prima dell’ar-
rivo di Massimo a Torino, alla fine del IV
sta longobarda
, che raggiunse Torino
intorno al 570, determinarono il defi-
nitivo collasso dell’organizzazione civica
suggellando la fine della lunga vicenda di
Torino romana.
Sergio Roda è professore ordinario presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Torino.
Luisella Pejrani è funzionario presso la Soprin-
tendenza per i Beni archeologici del Piemonte.
secolo, si veneravano i corpi dei martiri
locali Solutore, Avventore e Ottavio, e che
intorno al 490 il vescovo Vittore aveva tra-
sformato in chiesa. Fu una “passio” del V
secolo, storicamente non attendibile, ad
avanzare l’attribuzione dei martiri torinesi
alla cosiddetta
Legione Tebea
, che secondo
una leggenda totalmente priva di fonda-
mento storico sarebbe stata sterminata,
in quanto formata da militari cristiani,
all’inizio del III secolo d.C. in occasione
della grande persecuzione di Diocleziano
e Massimiano. Questo secondo polo re-
ligioso ci è però noto soltanto dalle fonti
scritte e meno ancora sappiamo delle altre
chiese che via via furono erette in città in
età paleocristiana.
Mentre si compiva la “cristianizzazione”
dello spazio urbano, con l’abbandono e la
sostituzione delle infrastrutture dell’edili-
zia pubblica di età romana, anche quella
privata subì pesanti modificazioni:
la qua-
lità dell’architettura e dello stile di vita
degli abitanti venne indubbiamente a
decadere
, a dimostrazione fra l’altro del
fatto che la ripresa economica di Torino
all’epoca del vescovo Massimo fu in realtà
quanto mai breve ed effimera. Dal IV-V
secolo le antiche
domus
aristocratiche
caddero in rovina, riparate e ristrutturate
con materiali poveri, come il legno e l’ar-
gilla, con pavimenti ridotti a terra battuta
e semplici focolari al posto dei sofisticati
sistemi di riscaldamento presenti in tutte
le unità abitative di età imperiale; le nuo-
ve forme abitative rientrano nei parametri
comuni dell’epoca, ma la destrutturazione
urbanistica e architettonica è anche la ri-
prova materiale del progressivo esaurirsi
della classe dirigente cittadina di estrazio-
ne e formazione romana. La manutenzio-
ne delle strade proseguì fino alla metà
del VI secolo, poi gli avvenimenti della
guerra fra Goti e Bizantini e la
conqui-
Frammento dell’arredo liturgico della basilica del Salvatore della cattedrale, Museo Diocesano di Torino (fotografia di M. Saroldi).
Le mura di Torino, le
quali sono fatte di ciot-
toli di fiume tutti spez-
zati nel mezzo, e sono
detti ciottoli posti con la
parte spezzata in fuori;
onde fanno drittissimo e
pulitissimo lavoro.
Andrea Palladio
25 a.C.
398 d.C.
A cura di A. Gabucci e L. Pejrani