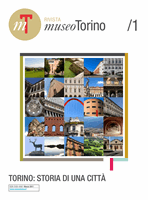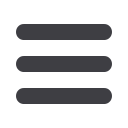
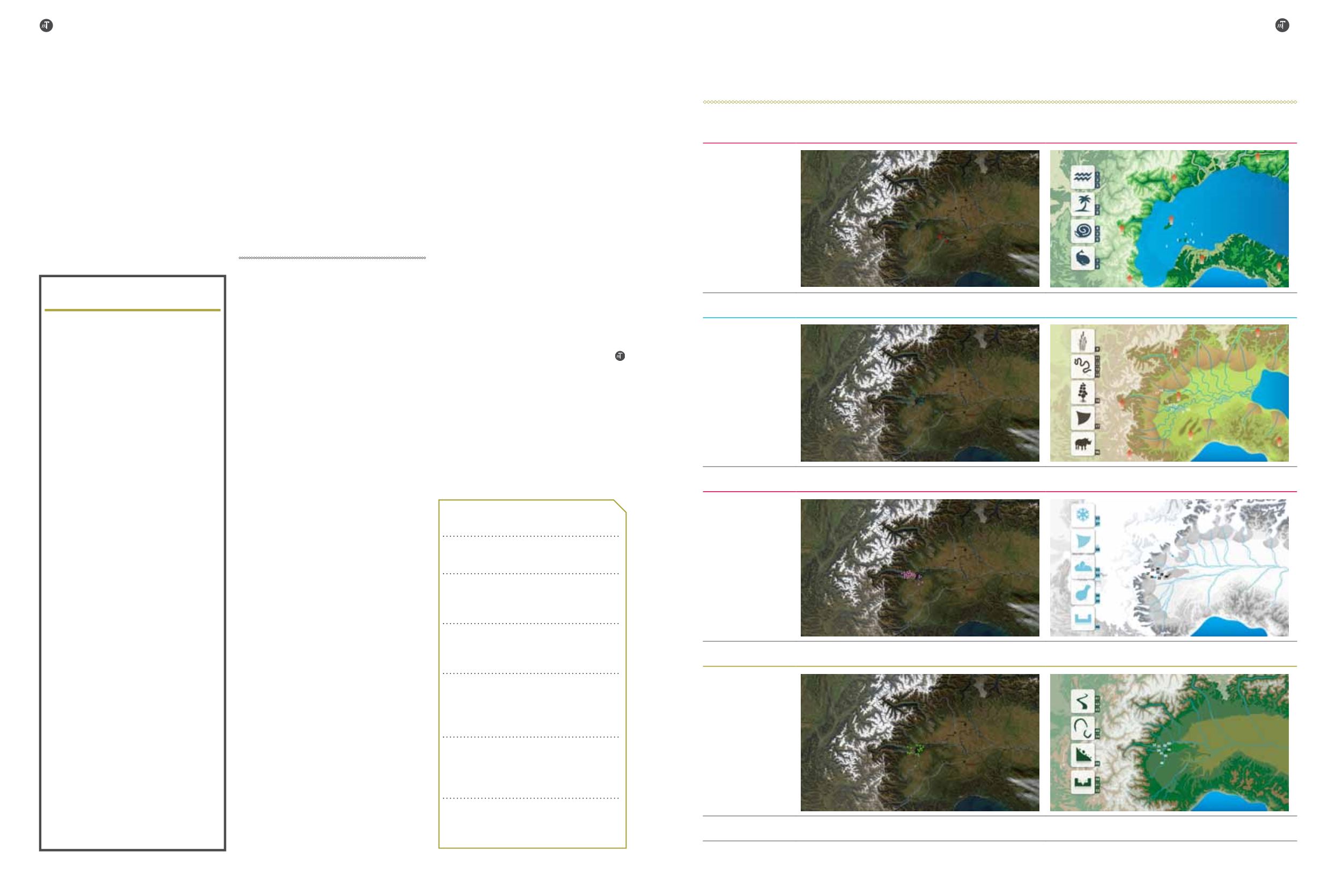
Prima della città
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
16
17
Da 5 a 2,5 milioni di anni fa
Da 2,5 milioni a 700.000 anni fa
Da 700.000 a 10.000 anni fa
Da 10.000 a 4.000 anni fa
a cura di M. Giardino e S. Russo
le mappe
A sud della soglia, il corso d’acqua princi-
pale continua a essere il paleo-Po che de-
fluisce, con il contributo del fiumeTanaro,
verso est. Poi, in un momento non meglio
precisabile del Pleistocene superiore, il
corso del paleo-Po subisce un fenomeno
di diversione: abbandona bruscamente il
suo antico percorso e, superata la “soglia
di Moncalieri”, prosegue a nord-est lungo
il margine della collina di Torino con un
andamento simile all’attuale. Nasce così
il fiume Po come lo conosciamo oggi,
che inizia a spianare la soglia modellan-
dovi una superficie pianeggiante, in cor-
rispondenza della quale sono stati trovati
sedimenti, per lo più sabbie, legate al suo
attuale bacino.
In un momento di poco successivo, intorno
a 40.000 anni fa circa, anche il fiume
Tana-
ro
devia il proprio corso: all’altezza dell’at-
tuale cittadina di Bra le sue acque tracimano
in una valle posta poco a est, attraversano
l’Astigiano e l’Alessandrino, e vanno a con-
fluire nel fiume Po, nei pressi di Valenza Po.
Tali fenomeni si realizzano non solo in
funzione dei cambiamenti climatici, ma
anche per effetto di importanti movimen-
ti della crosta terrestre (sollevamenti diffe-
renziali, dislocazioni lungo faglie) che in
quest’area proseguono anche in tempi più
recenti.
Verso la città dei Taurini
Nelle migliaia di anni più recenti, in una
realtà che si potrebbe definire protosto-
rica e corrispondente alla quarta tappa,
la geomorfologia del territorio torinese
assume una configurazione sempre più
prossima a quella odierna. Il margine
alpino e l’antistante rilievo della collina
di Torino sono ormai strutturati e gran
parte dei corsi d’acqua principali (Po,
Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo)
e secondari ha un andamento pressoché
simile all’attuale, se si eccettuano modi-
ficazioni a carattere locale.
Al passaggio tra il Pleistocene superio-
re e l’
Olocene
(circa 10.000 anni fa)
il torrente
Sangone
, precedentemente
ostacolato nel suo deflusso dalle cerchie
dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avi-
gliana, incide i depositi glaciali presso
Trana, per andare poi a confluire nel
fiume Po, più a valle.
In generale, durante l’intervallo di tem-
po fra 10.000 e 4.000 anni fa, il clima
è molto variabile, ma mediamente più
caldo rispetto alla precedente fase gla-
ciale. In conseguenza dei cambiamenti
globali del clima e in risposta a prece-
denti variazioni del livello del mare e
dell’assetto idrografico, i corsi d’acqua
dell’area torinese approfondiscono il
loro alveo incidendo e terrazzando i de-
positi glaciali e fluviali più antichi. Sol-
tanto localmente, ai loro margini, i corsi
d’acqua depongono coltri di sedimenti
sabbiosi e limosi di esiguo spessore, in
particolare durante gli eventi di piena.
Nei settori di pianura più vicini al luo-
go in cui sorgerà la città di Torino, spe-
cialmente in corrispondenza della con-
fluenza tra il Po e i suoi affluenti (Stura
di Lanzo, Dora Riparia e Sangone), il
continuo migrare dei corsi d’acqua e del
loro punto di confluenza determina la
formazione di ampie
aree pianeggianti
e depresse
, spesso caratterizzate da una
fitta vegetazione spontanea tipica delle
zone umide. Queste regioni sono tutto-
Da leggere
F. Sacco,
Il bacino terziario e quaternario del
Piemonte
, Bernardoni, Milano 1889-90
F. Carraro (a cura di),
Revisione del Villafranchiano
nell’area-tipo di Villafranca d’Ast
i
, in «Il Quaterna-
rio», 1996, 9(1), pp. 5-119
P. Baggio, M. Giardino, L. Mercalli,
Val Sangone:
climi e forme del paesaggio. Da due milioni di anni
fa ad oggi, Sms
, Torino 2003
G. Pavia, G. Bortolami, P. Damarco,
Censimento
dei geositi del settore regionale Collina di Torino e
Monferrato
(Quaderno scientifico n. 5), Ente Parchi
e riserve naturali astigiane, Asti 2004
M.G. Forno, S. Lucchesi,
La successione fluviale
terrazzata pleistocenica dei versanti occidentale e
nordoccidentale della Collina di Torino
, in «Il Quater-
nario», 2005, 15, pp. 175-185
R. Polino (a cura di),
Note illustrative della Carta
Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 156
Torino Ovest
e
Torino Est,
ARPA, Torino 2010
La presenza dell’uomo
La prima documentazione archeologica nel
territorio di Torino è costituita da reperti
databili al
Neolitico
(6000-3500 a.C.). Nel
corso di questo periodo le comunità preisto-
riche cambiano radicalmente il loro sistema
di vita, passando da un’economia basata su
caccia e raccolta di prodotti spontanei a una
di tipo produttivo, caratterizzata dall’agri-
coltura e dall’allevamento, con la creazione
di insediamenti stabili e la produzione di
ceramica e utensili in pietra levigata.
La presenza umana del Torinese prosegue
anche durante l’
Età del Rame
o Eneolitico
(3500-2200 a.C.), ma è con l’
Età del Bronzo
(2200-900 a.C.) che i dati mostrano un pro-
gressivo e continuo aumento demografico,
con l’avvio della formazione dei gruppi etnici
e linguistici che saranno poi menzionati
dalle fonti classiche. In questa fase emerge
un ceto di artigiani e mercanti fortemente
dinamico e mobile all’interno delle comunità
e si crea un sistema economico basato su
piccoli villaggi e una fitta rete di commerci e
collegamenti, soprattutto lungo le vie fluviali.
Nell’
Età del Ferro
(900-200 a.C.) il Torinese
appare strettamente collegato alla culture
del mondo hallstattiano alpino e transalpino
e inserito nelle vie commerciali che colle-
gano i centri etruschi dell’Emilia alle aree
minerarie delle Alpi Occidentali.
Dal IV sec. a.C. in poi
, l’impatto delle
invasioni galliche porta a uno sconvolgimen-
to sociale e politico e in molti casi all’ab-
bandono degli abitati di pianura, con la fine
del sistema commerciale legato al mondo
etrusco.
Le fonti menzionano, in questa fase, la pre-
senza della popolazione dei
Taurini
e della
loro “città”, distrutta da Annibale nel 218 a.C.
Luisa Ferrero
ra facilmente inondabili durante eventi
di piena e pertanto adibite a parchi cit-
tadini, come ad esempio quelli del Mei-
sino, della Colletta, delle Vallere.
Nelle aree collinari, gli eventi piovosi
intensi e/o prolungati sono responsabili
di importanti fenomeni erosivi lungo i
corsi d’acqua e dell’attivazione di vari
tipi di movimenti franosi. I versanti
della collina di Torino sono infatti ca-
ratterizzati da una forte instabilità che
interessa più frequentemente i terreni
di copertura, benché talvolta coinvolga
anche porzioni del substrato. Per tipo-
logia di movimento, si tratta di scivo-
lamenti della coltre superficiale, colate
di fango e colate di detrito che vengono
generalmente incanalate lungo le inci-
sioni torrentizie.
Attraverso l’azione di questi processi natu-
rali, la costituzione del territorio torinese,
nel Neolitico e al tempo dell’insediamento
del popolo dei Taurini, è così realizzata nei
termini conosciuti attualmente.
Giulio Pavia è professore ordinario presso la Facoltà
di Scienze Matematiche Fisiche Naturali dell’Uni-
versità degli Studi di Torino.
Marco Giardino è professore associato presso la
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Natura-
li dell’Università degli Studi di Torino.
Stefania Lucchesi è borsista di ricerca al Dipartimen-
to di Scienze della Terra dell’Università di Torino.