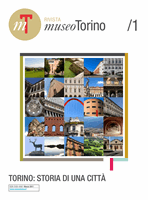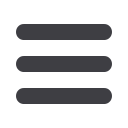
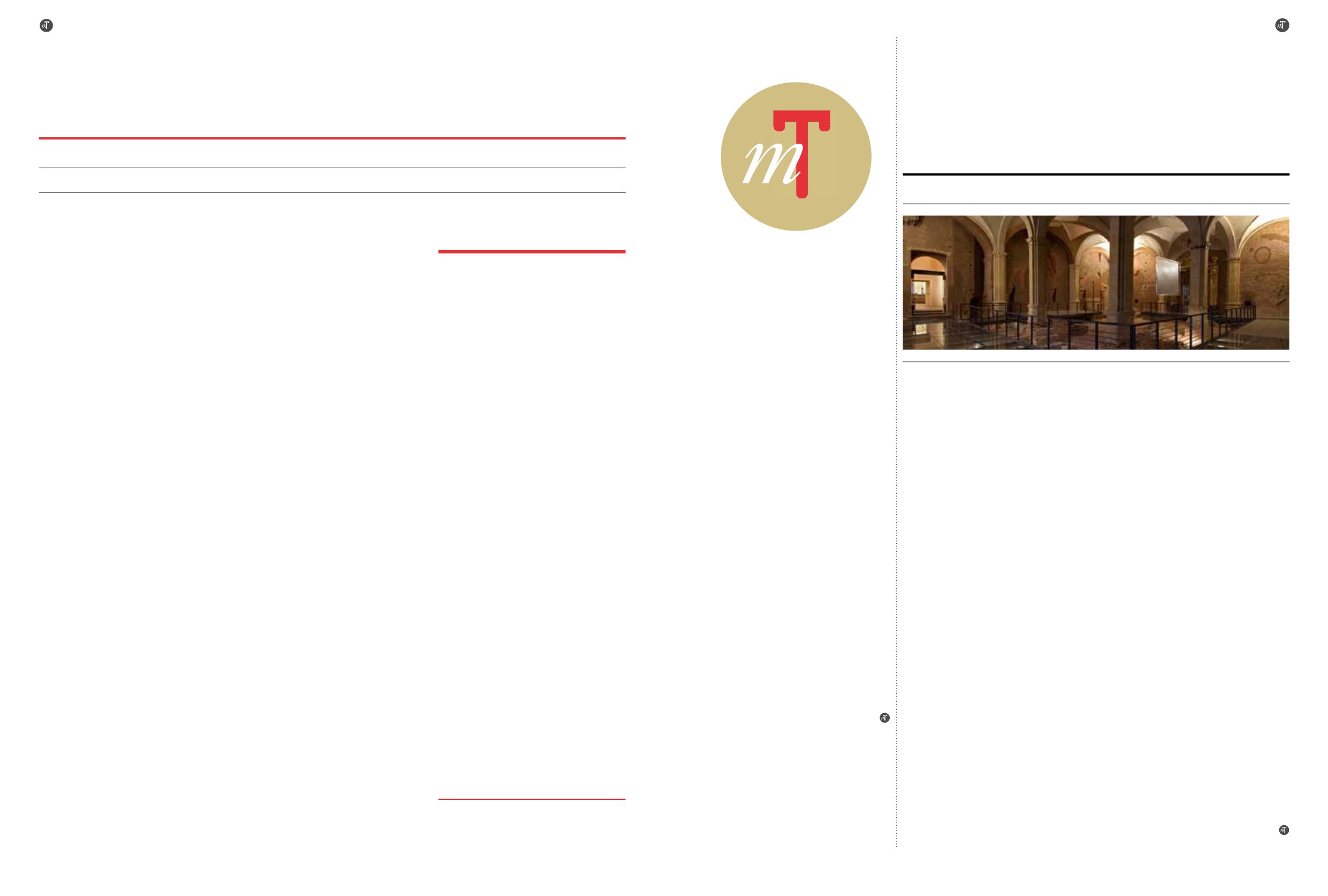
Pesentazioni
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
6
7
la città di cui si parla nella linea ininterrotta
del tempo e che sono intercalate da date e
testi che comunicano gli eventi significativi,
i cambiamenti di ruolo della città o il diver-
so contesto in cui essa viene a trovarsi.
Tempi, quadri, ma anche atti e scene, capi-
toli e paragrafi – a seconda della metafora
che si preferisce – di
una storia della città
inscritta nei luoghi e negli spazi
: un invi-
to a scoprirli o rivederli e conoscerli meglio
attraverso la Mostra storica permanente pre-
sentata con lo stesso titolo di
Torino: storia di
una città
nel sito
www.museotorino.itche
– attraverso
i pannelli di sala e di sezione
e i cartellini e le schede relativi a ciascun
luogo presente nella multivisione
– con-
sente di approfondirne la conoscenza e ot-
tenere informazioni di carattere archivistico,
bibliografico, sitografico e iconografico.
Torino: storia di una città
ha in questo
nu-
mero/1 della “Rivista MuseoTorino”
il
suo catalogo: un numero che, come la mul-
tivisione e la mostra, è un invito a vedere
con altri occhi, capire diversamente, apprez-
zare e amare Torino. È un viaggio che prose-
gue nelle strade e nelle piazze e che consente
di scoprire e ritrovarvi altri segni, altre storie:
le infinite storie che la città contiene e di cui
è testimonianza, grande museo diffuso in
continua evoluzione e cambiamento.
Storie del passato e del presente, perché
la città siamo noi: noi che l’abitiamo o
che la visitiamo, con
le nostre memorie
e le storie di cui siamo protagonisti o
testimoni,
le conoscenze che possediamo
o che possiamo scoprire, costruire, diffon-
dere, tramandare.
Renato Bordone e Dario Lanzardo ci hanno
lasciato prima di poter vedere il frutto del loro
lavoro per MuseoTorino. Li ricordiamo con la
stima e l’affetto per due colleghi e amici che ci
mancheranno.
È spettacolo.
Teatro e cinema. Spettacolo,
quindi, pensato nella sua
scenografia di concezione
teatrale e nella sua struttura
filmica come un’esperienza
immersiva nella rappresenta-
zione. L’assunto dal quale si è
partiti è che l’identificazione di
una città passa attraverso le
testimonianze rimaste, il suo
paesaggio, le sue architetture.
È multivisione.
Una pratica che ci impone una
perenne riconoscenza a Josef
Svoboda e alle sue sperimen-
tazioni con i multi schermi,
un sistema che chiamava
polyécran
. Immagini fisse e
in movimento, gestite da un
circuito che le memorizza e le
mette in sincronia fra loro e
con il suono.
È un luogo.
E se c’è un “luogo” dove si
incontrano nello stesso mo-
mento centinaia di immagini,
quello è l’immagine filmica
– Jean-Luc Godard dice che
«il cinema filma la verità 24
volte al secondo» – ossia la
ri-velazione di uno svelamento
(la storia di una città non può
essere che questo), a dirla con
Jacques Derrida, di «un’altra
figura» dove «il segreto di un
viso [e qui dobbiamo leggere
con identica valenza, invece,
“paesaggio urbano”] non è
nemmeno più un viso, se il
viso-paesaggio racconta la
visione in una storia dell’oc-
chio». È questa la ragione della
scelta di contestualizzare l’an-
tico, di non usare materiale di
repertorio. Qui tutto è riportato
alla scala dell’oggi.
È un viaggio.
Molto indietro nel tempo, dalle
trasformazioni geologiche di
luoghi preistorici alla romana
Augusta Taurinorum
,
per ap-
prodare poi alla città dei nostri
giorni dove siamo andati a
ri-trovare i segni
del passato.
È musica.
Perché la musica non è pensa-
ta come un tappeto sonoro,
non accompagna le immagini,
piuttosto evoca memorie o
svela emozioni, ma in una sua
totale autonomia, direi quasi
visuale.
È una passeggiata.
Se, come pensiamo, “la città
presente contiene tutte le altre
città passate”, come filmarla?
Amo moltissimo Robert Walser,
e penso che il suo
La passeg-
giata
sia un libro che fornisce
sempre in
dicazioni preziose. Il lavoro su
dodici schermi con immagini
dinamiche, più quattro su cui
si avvicendano immagini fisse
e un ultimo posizionato a terra
per offrire una vista dall’alto
della struttura della città e
delle sue trasformazioni nei
secoli, è, per forza di cose, una
scrittura filmica nomade, mol-
to vicina a una “passeggiata”,
pronta agli incontri casuali e
alle sorprese dello scoprire il
fascino nascosto che premia
chi alzi la testa per osservare
qualcosa visto spesso ma non
abbastanza indagato.
Il ritmo è lento, cinematografi-
co, e ci permette di scoprire e
osservare luoghi proprio come
durante una passeggiata,
come in “quella” passeggiata
di Walser, in cui «segretamente
ogni sorta di pensieri e di idee
seguono di soppiatto colui che
passeggia [...] mentre davanti
ai suoi occhi smarriti si spalanca
un abisso».
Esce la passione per il pae-
saggio della città, che imprime
su filmati e fotografie un
ritratto inconsueto.
Che cos’è
torino: storia di una città
?
di
Alex Donadio
La Corte Medievale di Palazzo Madama, sede della multivisione (cortesia Fondazione Torino Musei).
Museotorino è la storia della città
La città presente contiene tutti i suoi passati e
Torino: storia di una città
ricostruisce la storia partendo dai luoghi
più significativi di ciascuna delle epoche precedenti.
di
Daniele Jalla
A
mbientato nella Corte Medievale di
Palazzo Madama
, che interpreta
nella sua complessa e stratificata na-
tura di spazio in cui sono presenti tutte
le fasi di storia della città,
Torino: storia di
una città
è
un racconto per immagini
.
Una multivisione
che integra vedute in
movimento alle pareti, corredate da testi,
dati e date, con immagini fisse al centro
dell’ambiente e planimetrie storiche pro-
iettate a pavimento, in una narrazione che
abbraccia cinque milioni di anni, passan-
do dal tempo che precede Torino a quello
della città antica, medievale, moderna e
contemporanea, sino al presente.
Torino: storia di una città
è
un raccon-
to che inizia e finisce con la Torino di
oggi
, a cui si riferiscono tutte le imma-
gini e i filmati realizzati appositamente
per rappresentarne la storia in un modo
nuovo e diverso, partendo dall’idea che
la città presente contiene tutte quelle
che l’hanno preceduta
. Che ognuna di
esse ha lasciato un suo segno, a volte evi-
dente, a volte più difficile da percepire, a
volte nascosto o cancellato, ma in grado
di tornare visibile quando si sa ritrovarlo
in un dettaglio o riemerge dal sottosuolo.
E dall’idea che se nello spazio della città
presente è inscritto l’intero tempo della
sua storia, mentre la percorriamo com-
piamo, senza volerlo, un viaggio nei suoi
molti e diversi passati di cui le case e le
strade, i palazzi e le chiese, le fabbriche
e le piazze sono i testimoni: muti, sino a
quando non diamo loro voce, perché ci
raccontino ciò che hanno visto, ciò che
hanno vissuto.
Attraverso le immagini dei suoi luoghi più
significativi, selezionati da un comitato
scientifico e oggetto di un’ampia ricerca
e documentazione – presente nella
Mo-
stra storica permanente del museo sito
www.museotorino.ite nel
numero /1
della “Rivista MuseoTorino”
–, ognuno
di essi è posto ricollocato virtualmente
nel tempo di cui è prodotto ed espressio-
ne, fornendo così le chiavi per coglierne
l’identità e il valore. Per capire la città,
l’evoluzione della sua forma, della sua
struttura, della sua fisionomia, restituen-
do ai luoghi la pienezza della loro identità
e offrendo a chi vi abita e a chi la visita la
capacità di riconoscere e di apprezzare il
senso stesso dei luoghi.
In un tempo brevissimo
Torino: storia di
una città
condensa cinque milioni di
anni
partendo dal momento in cui ini-
zia a formarsi e definirsi il territorio che
12.000 anni fa, agli inizi dell’Olocene,
assume una morfologia simile a quella at-
tuale a quando, circa 2.000 anni orsono,
nasce la città che oggi chiamiamo Torino,
ripercorrendo in seguito i venti e più se-
coli di storia della città.
Il racconto è scandito in cinque tempi
:
quello che corrisponde a quando non solo
non esisteva la città, ma l’intera Pianu-
ra Padana era sommersa dal mare, sino
al momento della fondazione di Torino,
proseguendo con i tempi della città anti-
ca, medievale, moderna, contemporanea,
riportandoci all’oggi con i progetti e le
anticipazioni della città futura.
I cinque tempi hanno una durata molto
diversa tra loro: ai milioni di anni del pri-
mo seguono epoche che corrispondono a
quattro, dieci e due secoli. Una voluta in-
determinatezza caratterizza i limiti crono-
logici di questi cinque tempi della storia,
la cui alternanza nel racconto si realizza
quasi “per dissolvenza”, cercando di co-
municare un’idea di
flusso continuo del
tempo
. La periodizzazione rinvia a cate-
gorie note, legando la storia della città alla
grande Storia, pur evitando di stabilire
netti spartiacque tra un tempo e l’altro.
A ognuno dei tempi corrispondono più
quadri
: cinque per la lunga fase di “prima
della città”, tre per la città antica, sei per la
città medievale, quattro per la città moder-
na e di nuovo sei per quella contemporanea.
Ogni quadro corrisponde a un data signifi-
cativa, a un evento importante nella storia
della città:
ventiquattro “fermi immagi-
ne”, a cui si aggiunge “La città futura”,
in un tempo continuo
, scandito in grandi
partiture, che danno la possibilità di situare
Cosi, senza andare troppo indietro
oltre la città ottocentesca, senza
risalire all’isola misteriosa, senza
neppur troppo concedere al paese
delle meraviglie o dei balocchi,
al land design o al Disneyland, va
sempre più concretamente pren-
dendo corpo, materializzandosi,
l’immagine di una organizzazione
diffusa, a rete, ramificata del museo
come sistema complesso di servizi
preposti prioritariamente alla con-
servazione, ma radicato alle origini,
alle fonti dei beni culturali […] e
al sistema dell’istruzione […] che
consenta di partecipare a una crea-
zione collettiva, come qualche cosa
cominciata prima e che presumibil-
mente continuerà dopo, dando così
la consapevolezza di una forza che
passa attraverso.
Fredi Drugman,
Il Museo diffuso