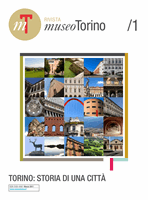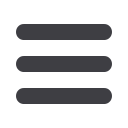
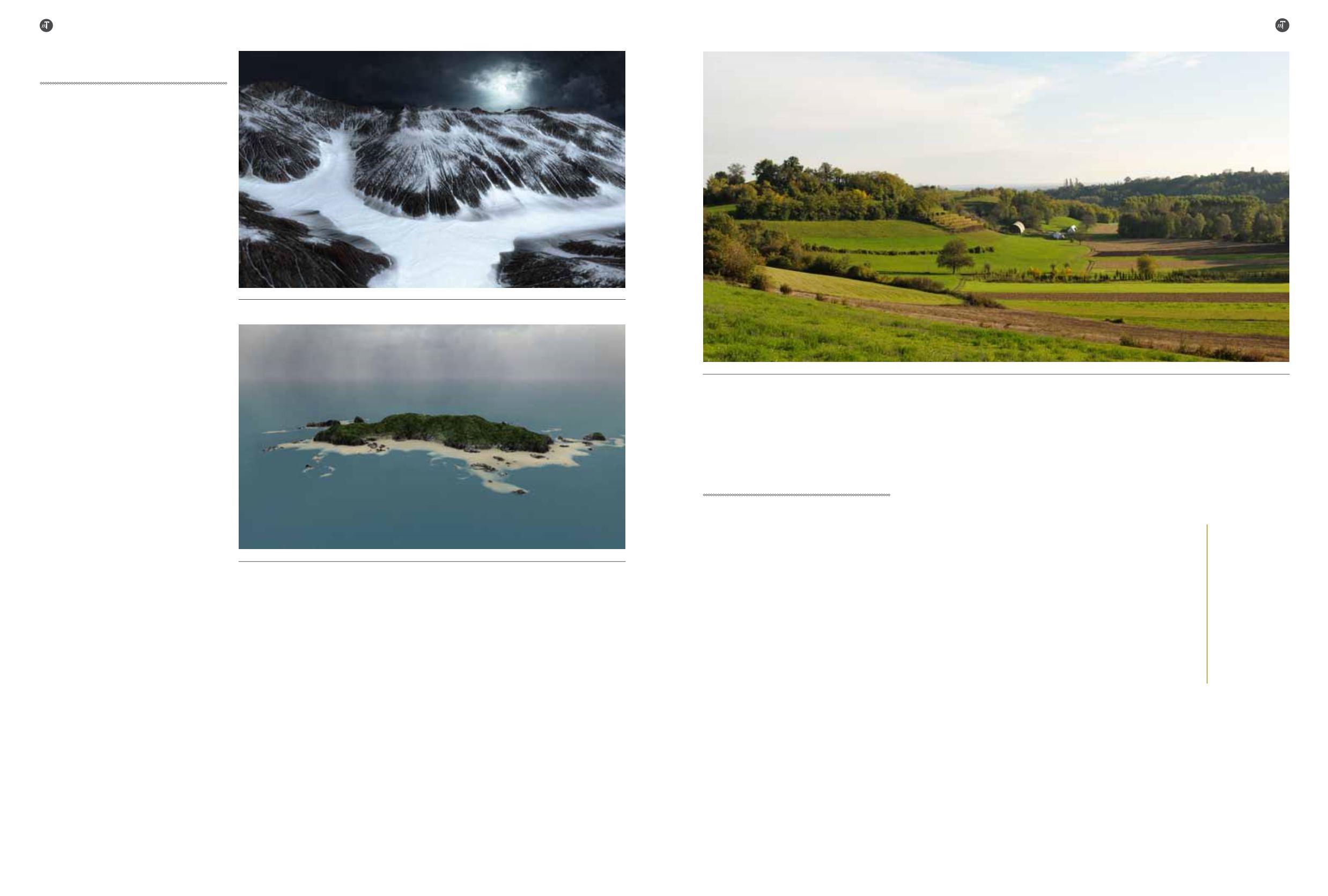
Prima della città
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
14
15
La prima fase
dell’evolu-
zione geologica
del territorio
“piemontese”
fotografa
la presenza
di un mare
antico,
durante il
Pliocene
merosi
massi erratici
. Una delle dorsali
più antiche e meglio conservate, ad esem-
pio, è quella nota come Truc di Monsa-
gnasco, nei pressi dell’attuale Rivoli.
Nasce il Po (come lo conosciamo oggi)
Nella terza fase, l’intervallo di tempo com-
preso fra i 700.000 e i 10.000 anni dal
presente (
Pleistocene medio-superiore
)
è un periodo in cui il modellamento del
paesaggio alpino è dominato da
processi
glaciali
.
Il clima, seppure interessato da fasi in-
terglaciali temperato-calde, è per lo più
caratterizzato da temperature più rigide
delle attuali e da intense precipitazioni
nevose: accumuli di neve accresciuti in
montagna si trasformano in ghiacciai, per
poi espandersi verso valle.
Al succedersi di diverse espansioni del
ghiacciaio della valle di Susa corrispondo-
no la deposizione di sedimenti glaciali e la
formazione di argini e cerchie moreniche
che, nel loro insieme, allo sbocco vallivo
in pianura danno luogo all’
anfiteatro
morenico di Rivoli-Avigliana
, uno dei
meglio conservati ed estesi dell’arco alpi-
no. Dal punto di vista geologico, l’anfite-
atro è formato da un complesso affiorante
di depositi glaciali e fluvio-glaciali che si
estende per circa 52 chilometri quadrati
e testimonia la grandiosità del fenomeno
glaciale nelle Alpi. Dal punto di vista ge-
omorfologico, l’anfiteatro morenico è co-
Il relitto del meandro di San Felice (Pecetto
T.se) consente di analizzare nel dettaglio le tracce del modellamento operato dall’antico corso fluviale del paleo-Po quando questo
fluiva a sud della collina di Torino dirigendosi verso est attraverso i rilievi dell’Astigiano (fotografia di P. Mussa).
stituito da un insieme di modesti rilievi
collinari per lo più con forma rettilinea
(dorsali) o debolmente arcuata (cerchie),
tra loro paralleli e disposti a formare,
appunto, una sorta di anfiteatro. Tra le
cerchie principali spicca per lunghezza e
altezza la Cresta Grande (su cui sorge il
Castello di Rivoli), e che si eleva di circa
200 metri sulla pianura circostante, nella
quale scorre la Dora Riparia. Man mano
che ci sposta verso l’interno dell’anfitea-
tro, le cerchie moreniche sono invece di
minori dimensioni lineari, ma meglio
conservate, e i rispettivi depositi sono via
via meno alterati. Tra le principali cerchie
moreniche spesso si formano dei piccoli
bacini lacustri intramorenici
, estre-
mamente effimeri in quanto facilmente
colmabili dall’apporto di sedimenti. Le
ultime tracce di tali bacini lacustri sono
rappresentate dai laghi di Avigliana.
All’esterno dell’anfiteatro, gli scaricatori
glaciali che raccolgono le acque di fu-
sione del ghiacciaio sboccano in pianura
formando degli ampi conoidi fluviogla-
ciali, tra loro parzialmente interdigitati
e sovrapposti, costituiti prevalentemente
da ghiaie grossolane con una copertura
di alcuni metri di sabbie limose. In par-
ticolare, sulla superficie di uno di questi
grandi conoidi, quello della Dora Riparia,
sorge
oggi
il
centro urbano di Torino:
il
tracciato rettilineo che collega la città di
Rivoli a Torino (oggi corso Francia) lo
percorre in senso assiale (est-ovest).
Il territorio modellato dall’acqua
e dal ghiaccio
Durante la seconda fase “prima della cit-
tà”,
fra 2,5 milioni e i 700.000 anni fa
,
si assiste a un continuo e graduale solleva-
mento della collina di Torino e dei rilievi
alpini. Nelle aree emerse dal mare padano
si impostano i primi corsi d’acqua: non
sono ancora ben organizzati e spesso, nelle
aree più depresse, le acque ristagnano for-
mando paludi. In questi ambienti si for-
mano i tipici
depositi “villafranchiani”,
così definiti perché storicamente studiati
per la prima volta nel corso dell’Ottocen-
to nella zona di Villafranca d’Asti. I ter-
mini più caratteristici di questi sedimenti
sono rappresentati da limi, sabbie e ghiaie
contenenti numerosi resti fossili di vege-
tali e vertebrati continentali.
Nel frattempo, i corsi d’acqua alpini
formano ai piedi della catena montuosa
estesi ventagli di depositi (conoidi fluvia-
li) che occupano gran parte del corridoio
tra le Alpi e la collina. I principali corsi
d’acqua si sviluppano con un assetto e un
decorso diversi dall’attuale: in particolare
si riscontra una netta separazione tra quel-
li del
bacino piemontese meridionale
e
quelli del
bacino piemontese settentrio-
nale
.
Le acque raccolte nel bacino piemontese
meridionale confluiscono in un impor-
tante fiume (
paleo-Po
) che defluisce a
sud della collina di Torino attraverso l’at-
tuale area dell’altopiano di Poirino e del-
le Langhe. Proprio l’altopiano di Poirino
rappresenta il relitto di un’antica pianura
legata al paleo-Po e al paleo-Tanaro; oggi
vi sono ancora riconoscibili diversi relit-
ti di meandro e lembi di antichi depositi
fluviali, ovvero le tracce del modellamen-
to operato dagli antichi corsi d’acqua che
defluivano verso il mare Adriatico passan-
do a sud della collina di Torino.
Le acque del bacino piemontese setten-
trionale defluiscono invece attraverso i
fiumi di provenienza alpina che scorrono
a nord della stessa collina. L’andamento di
questi antichi corsi d’acqua è testimoniato
ai giorni nostri dalle superfici pianeggianti
(
terrazzi
) conservate a quote diverse sul
versante nord-occidentale e occidentale
della collina di Torino, separate tra loro
da scarpate di alcune decine di metri. I
terrazzi rappresentano i lembi di un’an-
tica pianura, le sottostanti scarpate cor-
rispondono, invece, a forme sviluppatesi
nelle successive fasi di approfondimento
erosivo. Oggi le antiche forme fluviali si
trovano sospese a quote differenti sull’at-
tuale pianura del fiume Po: questo avvie-
ne per l’effetto del sollevamento tettonico
dell’area collinare che, nei tempi geologi-
ci, ha determinato il progressivo coinvol-
gimento dell’originaria pianura nel rilievo
collinare.
Questa seconda fase corrisponde anche
all’inizio di un’importante fase di
dete-
rioramento climatico
. Essa si instaura
nel Quaternario, periodo caratterizzato da
fasi “glaciali” fredde e secche alternate a
fasi climatiche umido-temperate (“inter-
glaciali”) simili a quella attuale. Nel set-
tore alpino iniziano a formarsi i
ghiacciai
che riempiranno poi quasi completamen-
te le valli, in particolare la valle di Susa,
giungendo con il loro fronte fino nell’area
di pianura. Oggi sono conservate quasi
esclusivamente le tracce delle espansioni
glaciali successive al Pleistocene medio
(più giovani di 750.000 anni fa, descritte
nella prossima tappa). Nella bassa valle di
Susa e nella pianura torinese sono comun-
que riconoscibili alcuni lembi relitti degli
antichi conoidi fluvioglaciali e delle mo-
rene più esterne deposte dal ghiacciaio. I
più antichi depositi fluvioglaciali tuttora
conservati sono costituiti da ghiaie gros-
solane immerse in sabbie e limi, carat-
terizzate da un suolo molto evoluto che
ne suggerisce l’età molto antica. Per uno
spessore di una decina di metri i ciottoli
sono fortemente alterati e i composti di
ferro presenti nelle rocce che li costitui-
scono sono intensamente ossidati, così da
conferire ai sedimenti una tipica colora-
zione rosso scura (caratteristica ben rico-
noscibile, ad esempio, presso San Gillio,
Druento, Piossasco). Le forme glaciali più
antiche sono rappresentate dalle cerchie
più esterne dell’anfiteatro morenico di Ri-
voli-Avigliana: si tratta di dorsali collinari
allungate, molto rimodellate, costituite da
depositi glaciali intensamente pedogeniz-
zati, sulla cui sommità sono presenti nu-
Ricostruzione del paesaggio subtropicale pliocenico nel settore della Collina di Torino in emersione.
Ricostruzione del paesaggio glaciale pleistocenico nel settore alpino occidentale (elaborazioni V. Russo).
Fino a questo momento nel settore pie-
montese non esiste ancora un’unica Pia-
nura Padana, come la conosciamo oggi,
ma rimangono i due antichi bacini di-
stinti: il bacino piemontese settentrionale
e quello piemontese meridionale, tra loro
separati dalla
“soglia di Moncalieri”
, su
cui oggi sorge l’omonimo centro abita-
to. Essa è costituita
dalla propaggine
sud- oc c i dent a l e
della struttura del-
la collina di Tori-
no, ora sepolta dai
sedimenti fluviali
recenti, che ha
rappresentato, fino
ad almeno 60.000
anni fa, uno spar-
tiacque delle acque
superficiali dei due
bacini, e lo costi-
tuisce tuttora per
quelle del sottosuolo.
A nord della soglia, i corsi d’acqua pro-
seguono verso nord-est aggirando l’osta-
colo della collina, dove formano delle
superfici pianeggianti. Continuando
il sollevamento del rilievo collinare per
effetto della
geodinamica crostale
, que-
ste superfici vengono progressivamente
coinvolte nel rilievo e oggi sono parzial-
mente conservate come
terrazzi relitti
,
sospesi a centinaia di metri sull’attuale
pianura.