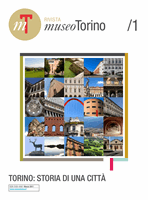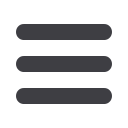
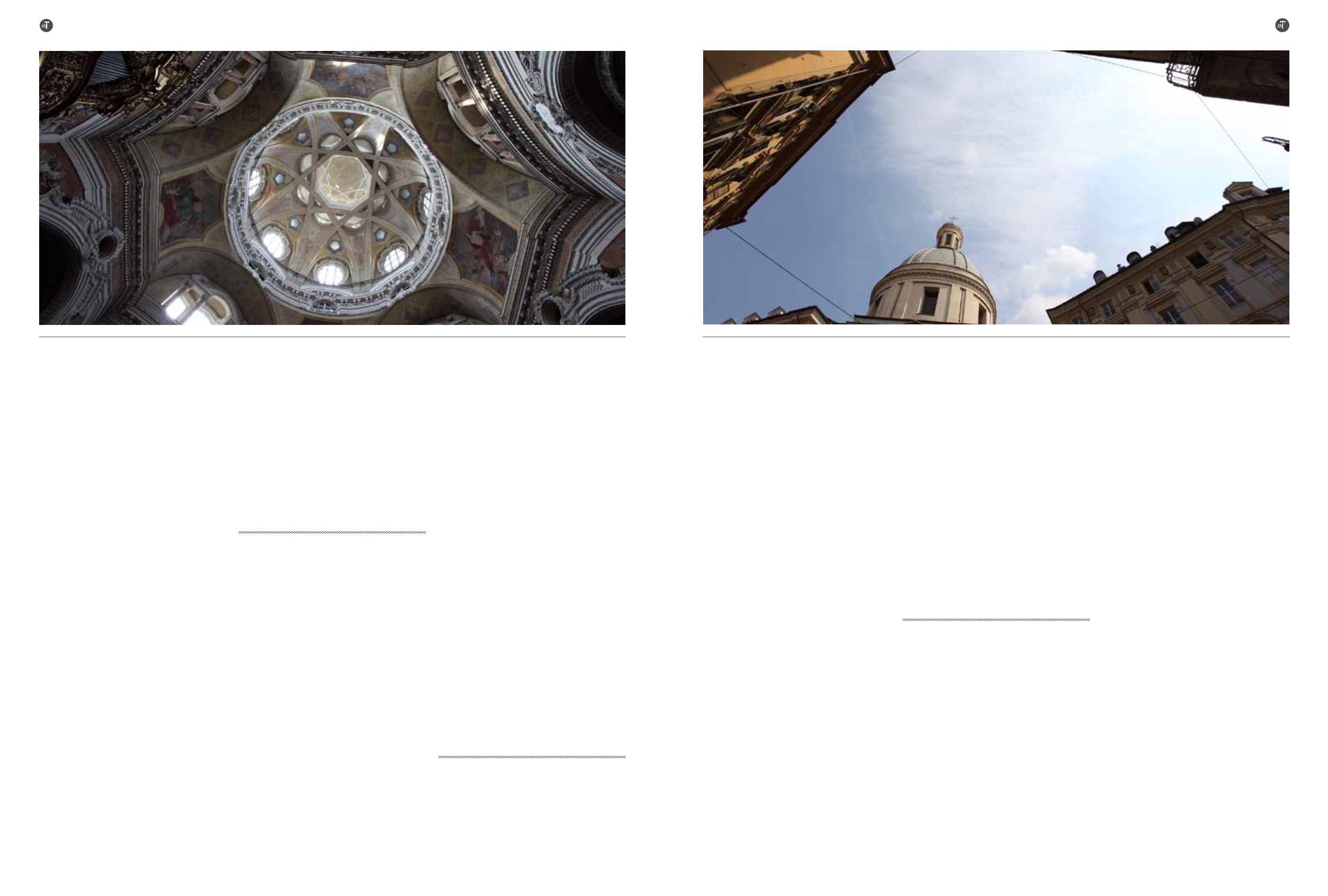
La città moderna
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
46
47
di apparenza grandiosa, volutamente pen-
sate per sovrastare le palazzate uniformi e
segnalare le sedi degli aspiranti al gover-
no del Paese: il progetto per il
Collegio
dei Nobili
immaginato dal gesuita Car-
lo Maurizio Vota per celebrare Madama
Reale (dal 1678); il
palazzo del principe
di Carignano
, disegnato da Guarini (dal
1679) guardando al modello di Berni-
ni per il Louvre di Luigi XIV, come un
prototipo di palazzo reale per un monarca
dello stato assoluto.
L’immagine della dinastia trova peròmodo
di rafforzarsi attraverso un altro proficuo
versante di affermazione pubblica quando
è associata alla
rappresentazione del di-
vino
, dove la regola dell’uniformità cede
il passo all’eccezione dello straordinario e
della bizzarria. Con le cupole delle
cap-
pelle palatine
della
Sindone
e di
San
Lorenzo
, che come meravigliosi reliquiari
sbucano al di sopra della cortina conti-
nua della città, Guarino Guarini disegna
il volto “meraviglioso” della presenza dei
Savoia a Torino. Le diverse scelte che si
calano nella città in questi anni trovano
una traduzione estetica nella variata sen-
sibilità per il colore, portata a segnalare
continuità e fratture:
il bianco e il gri-
gio
per le residenze ducali; il cotto a vista
per gli edifici dell’amministrazione dello
Stato;
il nero e il bigio
per la continuità
dinastica nella Cappella della Sindone;
i
marmi colorati
di Guarini per l’interno
del San Lorenzo.
Chiusa la congiuntura di incertezza del-
la reggenza, Vittorio Amedeo II (1684-
1730) riprende in mano le redini del
progetto dinastico concentrandosi nella
ricerca di un pittore di grido per affrescare
la nuova galleria del Palazzo Ducale, risol-
ta con l’arrivo di Daniel Seyter, dopo il
fermo rifiuto di Andrea Pozzo di venire
a Torino. La ricerca di un’immagine di
status
aderente alle crescenti ambizioni
sabaude sulla scena europea trova riflesso
nell’allestimento degli interni: in assenza
di un leader di gusto (quale sarà più tardi
Juvarra), pittori genovesi, milanesi, roma-
ni si confrontano con l’esperienza degli
stuccatori luganesi in cantieri decorativi
sperimentali, che fanno di Torino un luo-
go privilegiato di incubazione per la sen-
sibilità
rococò
.
La scenografia urbana,
nuova cifra della città del Settecento
A seguito del trattato di Utrecht (1713),
Torino diviene capitale anche del regno di
Sicilia (commutata nel 1718 con quello
della Sardegna) e ai duchi di Savoia è rico-
nosciuto il
titolo regio
, che li pone accan-
to ai sovrani delle più importanti potenze
europee. Il periodo è contrassegnato dal
governo di
Vittorio Amedeo II
, che subi-
to avvia un processo di profonde riforme
istituzionali entro lo Stato. Ferma inten-
zione del sovrano è rinnovare l’immagine
della capitale affidando all’architettura il
compito di esprimere il nuovo ruolo po-
litico e territoriale di Torino, in forme
adeguate ai grandi modelli internazionali.
Recatosi in Sicilia nel 1714 per prendere
possesso dell’isola, il re incontra e chiama
presso di sé l’architetto messinese Filippo
Juvarra, già celebre e attivo a Roma, e gli
affida il compito di progettare la nuova
grande
scenografia urbana
di Torino,
configurando l’immagine moderna e ade-
guata al rango di capitale settecentesca
dell’ormai “regno” sabaudo. In un pano-
rama aperto all’Europa Filippo Juvarra,
nominato primo architetto regio il 15 di-
cembre 1714, traccia per il sovrano il pro-
filo teorico del rinnovamento urbanistico
della città-capitale secondo quel principio
di “centralità diffusa” fondato sull’inscin-
dibile relazione che intende stabilire tra
la sede istituzionale del governo e l’intero
territorio.
Attraverso il puro linguaggio dell’archi-
tettura, intesa come segno ed espressione
di monumentalità e con attenzione ai ca-
noni di una trattatistica di cui riconosce
l’autorevolezza, Filippo Juvarra impone la
propria inedita interpretazione della ge-
rarchia dello spazio urbano e foraneo, su-
perando – senza mai smentire – i caratteri
della città secentesca.
All’indomani del suo arrivo a Torino subi-
to lavora al progetto urbanistico di costru-
zione del
terzo ampliamento a occidente
detto di Porta Susina, da realizzarsi sui ter-
reni inedificati compresi entro il perimetro
della struttura difensiva già innalzata (dal
1702) dall’ingegnere Michelangelo Garo-
ve che conferisce definitivamente alla città
barocca quella forma “a mandorla” discus-
sa nel corso di tutto il Seicento. La rifles-
sione progettuale juvarriana si concentra
innanzitutto sull’idea di porta urbana,
punto nodale di passaggio tra interno ed
esterno della città, elemento di saldatura
Lo slargo romboidale della Contrada di Porta Palazzo, attuale via Milano, plasmato da Filippo Juvarra nel 1735 come inedito sagrato per la Basilica Magistrale dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).
za va contro i “poteri forti” radicati nella
città, ma insieme favorisce gli ordini re-
ligiosi promuovendo l’alleanza con i Ge-
suiti attraverso la costruzione della chiesa
dei Santi Martiri, progettata da Pellegrino
Tibaldi.
Carlo Emanuele I potrà così dedicarsi al
progetto della
“città nuova”
, che inglo-
ba e avvolge entro un circuito murario
a
forma di mandorla
la vecchia città roma-
na e medievale, quasi triplicandone le di-
mensioni. Il suo governo si identifica nella
qualità progettuale del
disegno urbano,
pensato quale immagine del sovrano e
della dinastia
. Il progetto per il Palazzo
ducale affacciato su una grande piazza è
discusso inizialmente con Pellegrino Ti-
baldi, che individua nel Castello la sede
simbolicamente più appropriata, poi for-
mulato da Ascanio Vitozzi, che disegna
invece un edificio ex novo in sostituzione
dell’invecchiato complesso del Palazzo del
vescovo.
Alla prefigurazione della “città nuova”
quale specchio del buon governo del so-
vrano, Carlo Emanuele I affianca altre
operazioni di immagine per legittimare
la dinastia e a rafforzarne il ruolo di di-
fensore dell’ortodossia cattolica: la cele-
brazione dei martiri della Legione Tebea
e la costruzione del
santuario per l’o-
stensione della Sindone
. Quest’ultimo
progetto, sostenuto da Carlo Borromeo,
prende forma nei disegni di Vitozzi e Car-
lo di Castellamonte qualificandosi per la
preziosità dei materiali, il marmo nero e il
bronzo:
«oro et negro»
, secondo la volon-
tà manifestata da Carlo Emanuele I. L’in-
tervento più importante per le residenze
della corte è la decorazione della
Grande
Galleria
(1608), che vede un significativo
slittamento del progetto: dalla celebrazio-
ne genealogica della dinastia sabauda a bi-
blioteca, museo, camera delle meraviglie
e raccolta antiquaria, nel segno della cul-
tura degli emblemi sintetizzata nel motto
«vorrei senza parlar essere inteso».
Una città di ingegneri militari
e una corona per le “delitie”
Su questi presupposti si innesta il
primo
ampliamento della città
, orientato a le-
vante sull’asse della Contrada nuova e di
piazza San Carlo, messo in cantiere da
Vittorio Amedeo I avvalendosi del dise-
gno ancora del Vitozzi e poi di Carlo di
Castellamonte. Il volto urbano è nelle
mani degli
ingegneri militari
che si oc-
cupano di definire modelli vincolanti per
il disegno delle facciate, mentre la crescita
della “città nuova” è pianificata fin dagli
inizi sulla solida alleanza intrecciata con
il gruppo imprenditoriale dei luganesi,
garanzia e motore di un investimento edi-
lizio alternativamente orientato sulla città
civile e sulle fortificazioni militari.
Il processo avviato all’inizio del secolo se-
gna una battuta d’arresto con l’assedio di
Torino, che vede contrapporsi il partito
filofrancese, guidato dalla vedova di Vit-
torio Amedeo I, Cristina di Francia, e i
principi cognati Maurizio e Tommaso di
Savoia, appoggiati dalla Spagna. Dopo la
pace siglata nello stesso 1640, il progetto
dinastico ritrova nuovo slancio, dapprima
con il rafforzamento della presenza fisica
dei duchi nella città, finalmente segnalata
dalla facciata del
Palazzo Ducale
(su di-
segno di Maurizio Valperga, dal 1642), e
dal riadattamento a
Palazzo Madama
del
Castello, l’antica fortezza degli Acaia. Alla
valorizzazione delle sedi urbane fa seguito
l’investimento nelle dimore extracittadine
per la realizzazione della «
corona di de-
litie
»,
un anello simbolicamente traccia-
to attorno alla città dalle residenze della
corte destinate alla celebrazione del rituale
della caccia. Nel complesso della
Venaria
Reale
, progettata da Amedeo di Castel-
lamonte e pubblicizzata con l’edizione
di un libro (1674), il gusto della corte di
Carlo Emanuele II è celebrato dalle me-
tafore figurate nel programma iconografi-
co di Emanuele Tesauro. Con il 1673, la
fedeltà al progetto dinastico e l’immagi-
ne del buon governo della città vengono
compiutamente confermati nella perfetta
adesione tra programma e realizzazione
del
secondo ampliamento
di Torino, av-
viato in quell’anno sull’asse dello stradone
militare di Po.
La seconda Madama reale
e Vittorio Amedeo II:
“meravigliosa” presenza sulla città
Con la morte di Carlo Emanuele II
(1675) e la reggenza di Maria Giovanna
Battista di Savoia Nemours (1675-1684)
si apre una stagione di debolezza dinastica
e la lotta per il potere rischia di incrinare
la continuità del progetto per la città re-
golare, messo in pericolo da architetture
Gli archi intrecciati della stupefacente cupola nella cappella ducale di San Lorenzo progettata dal padre teatino Guarino Guarini nel 1670-79. L’interno a pianta centrale è preziosa-
mente decorato con marmi policromi (fotografia di P. Mussat Sartor e P. Pellion di Persano).