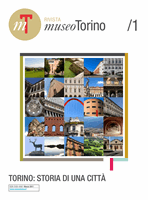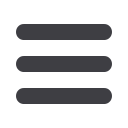
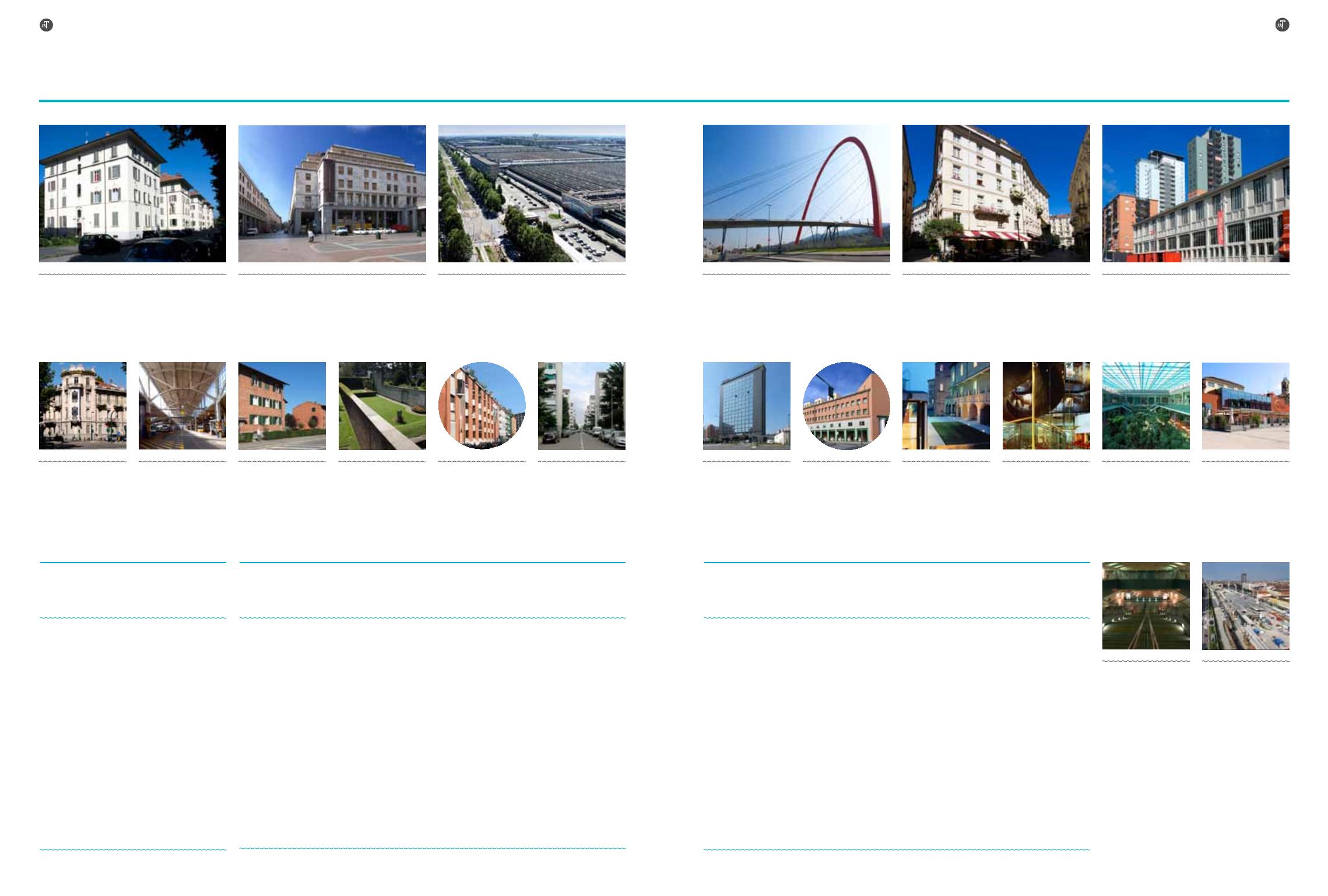
La città contemporanea. Il Novecento
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
72
73
Casa Aurora (A. Rossi,
G. Braghieri, 1984-
87), sede del Gruppo
Finanziario Tessile,
cita elementi tradi-
zionali torinesi, come
porticato e abbaini.
Il Castello di Rivoli
diventa nel 1984 sede
del Museo di arte
contemporanea (A.
Bruno), prima grande
istituzione italiana del
settore.
Il Museo nazionale
del Cinema apre nel
2000 il suggestivo
allestimento nella
Mole Antonelliana su
progetto di François
Confino.
Grande successo per
la trasformazione del
complesso industriale
Carpano nel centro
enogastronomico Eataly
(Negozio Blu, 2007).
La nuova Porta Susa
(Arep con S. D’Ascia
e A. Magnaghi, 2004-
12) è il nuovo princi-
pale scalo ferroviario
cittadino.
La Scuola interfacoltà
per le Biotecnologie
(L. Pia, 2000-06)
sorge sull’area già
occupata dalla Facoltà
di Veterinaria.
La Linea 1 della
Metropolitana viene
inaugurata il 4 febbra-
io 2006 e completata
a marzo 2011. È in
progetto la Linea 2.
Simbolo dei Giochi olimpici invernali del 2006,
l’arco olimpico di Hugh Dutton dà accesso al
villaggio olimpico (coordianato B. Camerana)
negli ex Mercati generali (U. Cuzzi, 1932).
Le vie del “Quadrilatero”, il centro più antico
della città e un tempo area degradata a ridosso
del mercato di Porta Palazzo, sono ora il luogo
della “movida” e degli svaghi serali.
Il nuovo complesso per uffici, residenze e
commercio (Snos, 2002-09) nella Spina 3 è un
progetto significativo di riconversione di un edi-
ficio industriale di pregio, quello delle Officine
Savigliano (E. Bonicelli, 1917).
I luoghi
2011
Tra presente e futuro.
1980-2011
• La crisi (nel 1982 chiude il Lingotto) è l’occasione per
ripensare la struttura
produttiva e morfologica
di Torino e dell’area metropolitana.
• Il
Piano regolatore generale
è approvato nel 1995: al centro, il trasporto pub-
blico con il Passante ferroviario e la metropolitana), il recupero delle aree ex
industriali (Lingotto, Spine) e della trama storico-ambientale (centro storico,
Residenze sabaude, Corona verde), il sostegno all’offerta culturale (nuovi mu-
sei, arte contemporanea e cinema).
• I “
grandi eventi
”, dai Giochi olimpici invernali al 150° dell’Unità d’Italia,
sostengono il disegno di cambiamento e di superamento della monocultura
manifatturiera.
• La società torinese muta, così come il suo tessuto urbano, anche grazie
all’incremento della
popolazione straniera
.
• Torino non si ferma
: nuovi progetti e nuovi cantieri disegnano la città futura.
Le strategie progettuali si allargano oltre la
dimensione metropolitana
, coinvol-
gendo Pianura Padana (almeno fino a Milano) e territori alpini e transfrontalieri.
Fotografie di Bruna Biamino, Fabrizia di Rovasenda, Michele D’Ottavio e Dario Lanzardo
Il grattacielo Lancia (N.
Rosani con G. Ponti,
1953-64), emblema
della casa automobili-
stica nata in Borgo San
Paolo, è uno dei simboli
del boom economico.
Il villaggio operaio della Snia-Viscosa voluto nel
1925 dall’imprenditore e collezionista Riccardo
Gualino (a cui si devono anche il Palazzo per
Uffici e la villa omonima sulla collina) coniuga
modelli ottocenteschi e nuova edilizia popolare
della Torino industriale.
Villa Fenoglio (P. Feno-
glio, 1902) è una delle
maggiori testimonianze
del Liberty, coeva della
torinese Esposizione
internazionale di Arte
decorativa moderna.
La ricostruzione di via Roma (1931-37),
coordinata da Marcello Piacentini, è episodio
celeberrimo nella cultura urbanistica italiana tra
le due guerre, oggetto di scontro tra innovatori
e tradizionalisti.
La Fiat Mirafiori (V. Bonadè Bottino, 1939,
ampliato nel 1959) è l’emblema della città indu-
striale, imponente scenario dell’affermazione del
fordismo e delle sue ricadute nella storia politica,
economica, sociale e sindacale del ’900.
Il deposito dei tram
ora GTT in zona San
Paolo (M. Dezzuti, C.
Gariglio, 1926-28).
Il Sacrario del
Martinetto (1967)
ricorda gli oltre 60 tra
partigiani e resistenti
condannati a morte
dal Tribunale speciale
fascista nel 1943.
Nell’ambito del Piano
Ina-Casa (coordinatore
G.Astengo, 1951), il
quartiere autosufficiente
di Falchera si scontra
con la realtà dell’emar-
ginazione dalla città.
La Bottega d’Erasmo
(R. Gabetti e A. Isola,
1956) è uno dei casi
più dibattuti dell’archi-
tettura italiana del ’900
per la rottura rispetto al
Movimento moderno.
Il complesso di Mira-
fiori Sud, realizzato
dall’Ina-Casa negli
anni ’60, prevede
edifici prefabbricati a
pettine e 798 vani per
12.000 abitanti.
1922
Tra le due guerre.
1911-1945
• Dopo la prima guerra mondiale
l’industria si riorganizza in senso
“fordista” e “taylorista”; sorgono gli
stabilimenti Fiat
Lingotto
(1922) e
Mirafiori
.
• La città cresce per grandi “tasselli”:
l’industria, i quartieri di edilizia po-
polare pianificata, i servizi collettivi.
• Nel 1928 Riccardo
Gualino
commissiona a Pagano e Levi-Mon-
talcini la sede del gruppo, icona del
Razionalismo italiano.
• Via Roma Nuova
(1931-36) rior-
ganizza la città storica, tra retoriche
della dittatura e grandi investimenti
finanziari.
1961
Da città a metropoli.
1946-1980
• La città del
boom
economico e dell’immigrazione cresce a
macchia d’olio
. Nel
1971 supera 1.100.000 abitanti.
• Trionfa l’idea della
città-fabbrica
, con l’assoluta sovrapposizione tra spazi del
lavoro e dell’abitare.
• Nel 1959 viene approvato il
nuovo Piano regolatore
.
• Le celebrazioni di Italia ’61 sono un momento importante di crescita pianificata,
con episodi architettonici di grande visibilità anche internzionale.
• Negli
anni Settanta
si manifesta la
crisi del modello industriale
consolidato, che
porterà a una riconversione dei paradigmi di sviluppo, sia a livello industriale e
produttivo, sia a livello urbanistico e architettonico, così come in ambito sociale e
culturale.
• Le classi sociali più ricche non sono più nel centro città, ma occupano ora la
collina, interrompendo una “prassi” residenziale di origini secolari.