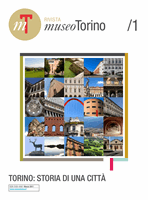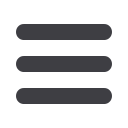
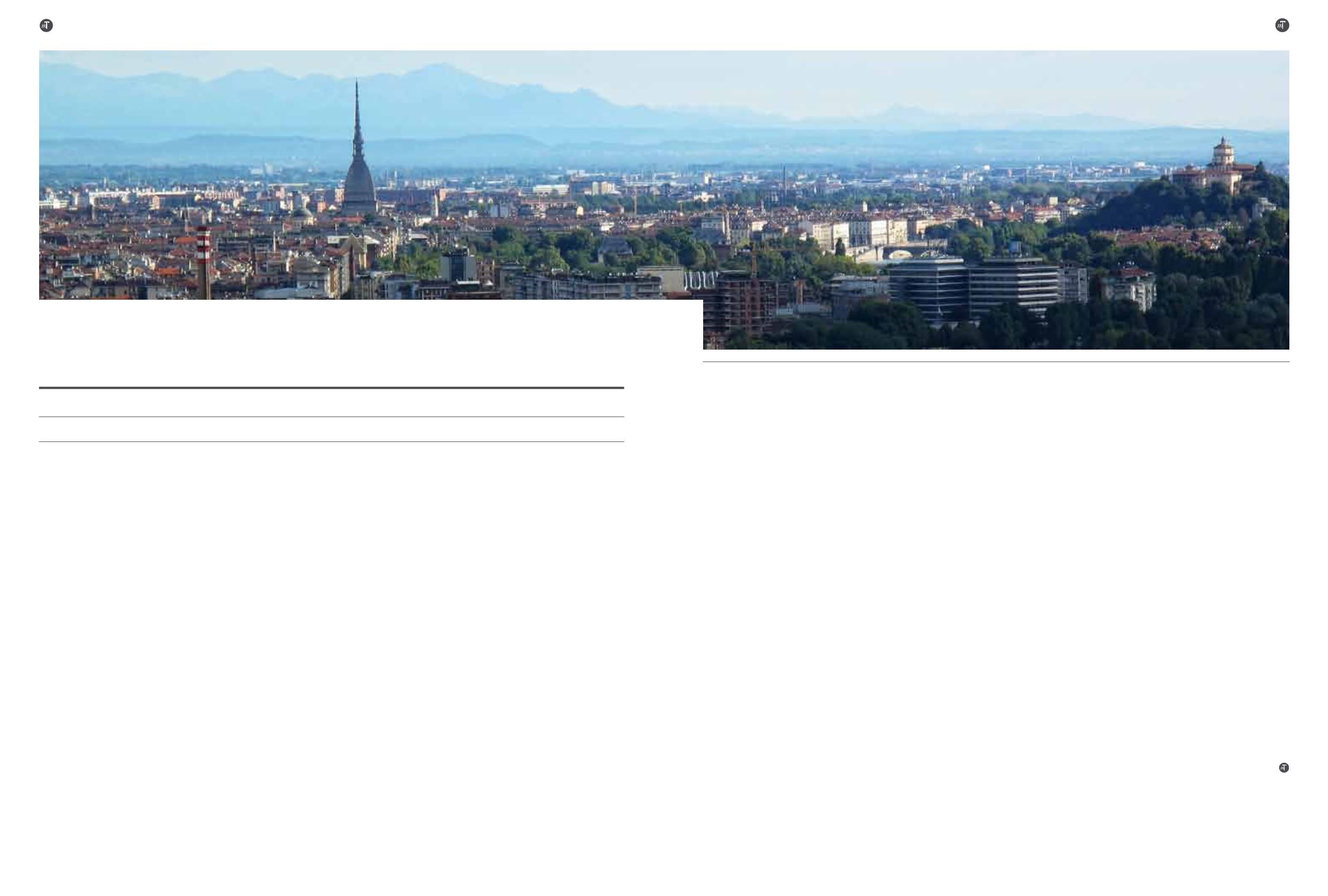
Quale città futura?
|
marzo 2011
marzo 2011
|
Torino: storia di una città
76
77
delle scienze dell’uomo, sono ambiti nei
quali Torino può fornire un contributo di
primo piano.
La
Torino futura deve quindi orientarsi
in misura maggiore verso tutto ciò che
è
invenzione
(ricerca, progettazione), e
sempre meno in direzione di tutto ciò che
è riproduzione, sempre necessario, ma in
quantità via via minore. In questo senso
molte aziende coordinate con gli istituti
di ricerca pubblici o privati possono com-
piere grandi passi: l’elettromeccanica, per
esempio, costituisce a Torino un serbatoio
di competenze di grado elevatissimo.
La seconda condizione è lo sviluppo della
conoscenza relazionale
, cioè della capa-
cità di mettere in relazione fra loro più
saperi per affrontare problemi comples-
si. Questa è necessaria, ad esempio, nei
settori dell’educazione, della sanità, della
gestione urbana, dall’energia all’acqua,
dal verde alla sicurezza, fino a compren-
dere tutte le politiche e le strategie legate
alla progettazione, sistemazione e gestione
della città. Esistono dei metodi di analisi
relazionale che consistono nello stabilire
legami funzionali e semantici tra docu-
menti, attori, terminologie, concetti e
classificazione. La conoscenza relazionale
è l’interdisciplinarietà in azione. Non ab-
biamo ancora capito che questo tipo di
analisi, sempre più di tipo matematico,
può permettere alla nostra società di com-
piere un passo decisivo, rendendo l’inno-
vazione più veloce e più sicura. L’analisi
relazionale è stata già indagata e praticata,
Occorre assolutamente distinguere la pro-
spettiva dall’
utopia
. Karl Mannheim ha
affermato che un’idea è utopica quando
non è in accordo con lo stato reale del-
le cose all’interno del quale si produce.
La
prospettiva
, viceversa, è un modo di
pensare futuri possibili, cioè ragionevoli,
partendo da una realtà conosciuta per im-
maginarne un’evoluzione relativamente in
accordo con il contesto generale nel quale
si elabora.
Se la città passata e presente può essere
rappresentata secondo un criterio mor-
fologico, non altrettanto si può fare con
quella del futuro, non soltanto perché la
forma dipende delle azioni degli attori in
rete, ma anche perché le forme possibili
della città sono innumerevoli. Al contra-
rio è possibile avanzare ipotesi sull’evolu-
zione delle azioni degli attori: dobbiamo
quindi impedirci di descrivere la città fu-
tura dal punto di vista morfologico, per-
ché sarebbe, appunto, pura utopia.
Quando ci chiediamo come sarà la “To-
rino futura”, ci interroghiamo sulle fun-
zioni che faranno vivere un milione o
più di persone. Naturalmente, la risposta
appartiene ai futuri abitanti ma è condi-
zionata da quelli attuali e dall’evoluzione
dei contesti italiano, europeo e mondiale
nella quale dovranno inserirsi.
Tenendo conto della situazione attuale,
tre fenomeni devono dunque essere pre-
si in considerazione
: il trionfo generale
della regolazione in tutti i settori di attivi-
tà, lo sviluppo enorme dell’informazione
relazionale e l’aumento della domanda
per la risorsa territorio.
Ogni città è un luogo di potere, poco o
molto importante, che per conservarsi
deve adattare e integrare i cambiamen-
ti significativi che avvengono. Alla fine
dell’Ottocento la trasformazione più de-
terminante giunse dalla grande industria,
che, tuttavia, oggi non è più in grado di
promuovere la Torino del futuro: è neces-
sario guardare in altre direzioni. In che
modo la città può affrontare questi feno-
meni per mantenere la propria posizione?
Consideriamo, prima di tutto, il proble-
ma della
regolazione
e dell’informazione
regolatrice, e della conseguente
conoscen-
za regolatrice
, che permette di agire sen-
za distruggere l’ambiente fisico e umano.
Nella meccanica, il primo grande regola-
tore fu quello inventato da James Watt,
una valvola che permetteva di controllare
il flusso del vapore. Come il dispositivo
messo a punto da Watt, molti di quelli
creati nell’Ottocento ebbero la medesima
funzione di controllo dei flussi.
Nel mondo attuale i rischi naturali e uma-
ni sono aumentati in maniera cospicua e,
per affrontarli, l’informazione regolatrice
è divenuta indispensabile.
Tutti i settori dell’industria conoscono
e producono regolatori di alto livello (si
pensi ad esempio alla domotica) e, in
questo ambito, l’invenzione è continua.
Abbiamo un bisogno crescente di mecca-
nismi di regolazione, nell’ambiente come
nella società: questi possono essere mate-
riali o immateriali, come ad esempio gli
algoritmi. In ogni campo del sapere si de-
vono accumulare delle pratiche e delle co-
noscenze regolatrici, per affrontare i rischi
nella nostra società complessa e quindi
fragile. Torino non può investire in tutti
questi campi d’azione, ma a seconda delle
sue tradizioni può scegliere in quali è più
competente. Ha i mezzi per competere:
l’Università, il Politecnico, gli istituti di
ricerca, le aziende. La creazione e l’inven-
zione legate alla regolazione, in cui è ne-
cessario integrare tutti i tipi di conoscen-
ze, quelle delle scienze naturali e quelle
Quale città futura?
Meccanismi di regolazione, reti di relazioni e gestione del territorio sono le chiavi in grado di garantire
a Torino un ruolo di primo piano nei decenni a venire.
di
Claude Raffestin
secondo un modo non sempre scientifi-
co, da diversi attori (per esempio il pre-
mio Nobel Erwin Schroedinger in
What
is life?
, incentrato sull’analisi relazionale
tra fisica e biologia). Oggi però può essere
razionalizzata e integrata e Torino ha tutte
le strutture per sviluppare aziende pro-
duttrici di analisi relazionale, creatrice di
valore non soltanto economico ma anche
sociale e strumento con cui dare corpo alla
ormai celebre
“integrazione della cono-
scenza”
, processo con cui si intrecciano le
diverse conoscenze specialistiche. Se è in-
fatti vero che la specializzazione è la chia-
ve dell’efficienza, quella dell’innovazione
risiede nell’informazione relazionale. An-
che in questo contesto la collaborazione
stretta tra Università, Politecnico, istituti
di ricerca e aziende può e deve essere il
volano per innovazioni in ambito econo-
mico, politico, sociale e culturale.
In questi tempi di crisi, i politici parlano
molto dell’esigenza di non sprecare de-
naro e risorse: le loro parole, tuttavia, in
assenza della necessaria informazione re-
golatrice e relazionale, rischiano di restare
lettera morta e di non essere utili nell’o-
rientamento della futura Torino.
L’ultimo fenomeno da considerare è la
risorsa territorio
. Nel mondo attuale,
intorno a questo tema c’è molta preoccu-
pazione in tutti i grandi paesi e le mul-
tinazionali, costantemente impegnati ad
acquisire nuove aree territoriali nel timo-
re, tra gli altri, di possibili future crisi ali-
mentari. Torino, alla fine dell’Ottocento
si dedicò allo sfruttamento delle risorse
idroelettriche nel territorio alpino. La fu-
tura Torino dovrà essere, perché non lo
è ancora,
il motore della protezione di
quello stesso territorio
e
dello sviluppo
delle Alpi occidentali
, magnifico labora-
torio di sperimentazione per numerose at-
tività, dall’agricoltura al turismo passando
attraverso l’industria leggera e innovativa
e i nuovi modi di abitare. Questo non si-
gnifica che la Torino del futuro imporrà,
come in passato, il suo potere alle Alpi,
ma che dovrà saper proporre nuovi siste-
mi per un “vissuto” migliore. Disporre
di riserve di territorio è un vantaggio per
affrontare qualsiasi mutazione nel futuro.
È vero, non abbiamo descritto la mor-
fologia della futura Torino, ma abbiamo
indicato alcune direzioni per valorizzare il
tempo a venire e non trovarci in uno stato
d’incertezza.
Attraverso la sua storia, Torino ha cono-
sciuto molte crisi, superate perché, sem-
pre, qualcuno è stato in grado di reagire,
sulla base delle proprie competenze e ri-
flessioni.
I Torinesi non devono dimenticare che
ogni crisi è anche un’opportunità. La To-
rino futura è nelle teste e nelle mani di
ciascuno di loro.
Claude Raffestin, geografo, è stato professore
ordinario presso l’Università di Ginevra.
Le Alpi che circondano la città costituiscono una delle risorse su cui si può fondare il futuro di Torino (fotografia di M. d’Ottavio).