
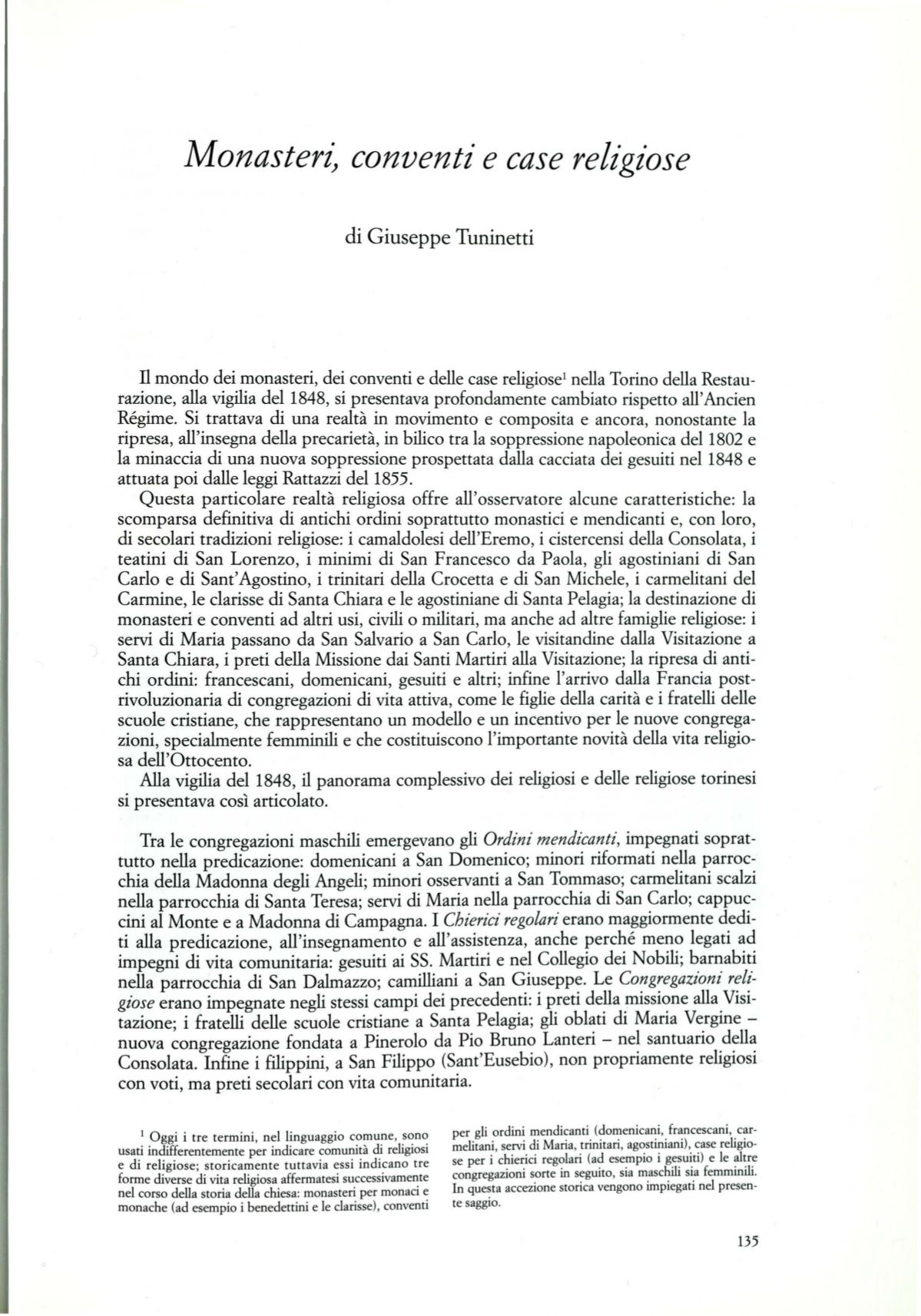
Monasterl~
conventi e case religiose
di Giuseppe Tuninetti
il
mondo dei monasteri, dei conventi e delle case religiose
l
nella Torino della Restau–
razione, alla vigilia del 1848, si presentava profondamente cambiato rispetto all'Ancien
Régime. Si trattava di una realtà in movimento e composita e ancora, nonostante la
ripresa, all'insegna della precarietà, in bilico tra la soppressione napoleonica del 1802 e
la minaccia di una nuova soppressione prospettata dalla cacciata dei gesuiti nel 1848 e
attuata poi dalle leggi Rattazzi del 1855.
Questa particolare realtà religiosa offre all' osservatore alcune caratteristiche: la
scomparsa definitiva di antichi ordini soprattutto monastici e mendicanti e, con loro,
di secolari tradizioni religiose: i camaldolesi dell'Eremo, i cistercensi della Consolata, i
teatini di San Lorenzo, i minimi di San Francesco da Paola, gli agostiniani di San
Carlo e di Sant'Agostino, i trinitari della Crocetta e di San Michele, i carmelitani del
Carmine, le clarisse di Santa Chiara e le agostiniane di Santa Pelagia; la destinazione di
monasteri e conventi ad altri usi, civili o militari, ma anche ad altre famiglie religiose: i
servi di Maria passano da San Salvario a San Carlo, le visitandine dalla Visitazione a
Santa Chiara, i preti della Missione dai Santi Martiri alla Visitazione; la ripresa di anti–
chi ordini: francescani, domenicani, gesuiti e altri; infine l'arrivo dalla Francia post–
rivoluzionaria di congregazioni di vita attiva, come le figlie della carità e i fratelli delle
scuole cristiane, che rappresentano un modello e un incentivo per le nuove congrega–
zioni, specialmente femminili e che costituiscono l'importante novità della vita religio–
sa dell'Ottocento.
Alla vigilia del 1848, il panorama complessivo dei religiosi e delle religiose torinesi
si presentava così articolato.
Tra le congregazioni maschili emergevano gli
Ordini mendicanti,
impegnati soprat–
tutto nella predicazione: domenicani a San Domenico; minori riformati nella parroc–
chia della Madonna degli Angeli; minori osservanti a San Tommaso; carmelitani scalzi
nella parrocchia di Santa Teresa; servi di Maria nella parrocchia di San Carlo; cappuc–
cini al Monte e a Madonna di Campagna. I
Chierici regolari
erano maggiormente dedi–
ti alla predicazione, all'insegnamento e all'assistenza, anche perché meno legati ad
impegni di vita comunitaria: gesuiti ai SS. Martiri e nel Collegio dei Nobili; barnabiti
nella parrocchia di San Dalmazzo; camilliani a San Giuseppe. Le
Congregazioni reli–
giose
erano impegnate negli stessi campi dei precedenti: i preti della missione alla Visi–
tazione; i fratelli delle scuole cristiane a Santa Pelagia; gli oblati di Maria Vergine -
nuova congregazione fondata a Pinerolo da Pio Bruno Lanteri - nel santuario della
Consolata. Infine i filippini, a San Filippo (Sant'Eusebio), non propriamente religiosi
con voti, ma preti secolari con vita comunitaria.
l
Oggi i tre termini, nel linguaggio comune, sono
usati indifferentemente per indicare comunità di religiosi
e di religiose; storicamente tuttavia essi indicano tre
forme diverse di vita religiosa affermatesi successivamente
nel corso della storia della chiesa: monasteri per monaci e
monache (ad esempio i benedettini e le clarisse), conventi
per gli ordini mendicanti (domenicani, francescani , car–
melitani, servi di Maria, trinitari, agostiniani), case religio–
se per i chierici regolari (ad esempio i gesuiti) e le altre
congregazioni sorte in seguito, sia maschili sia femminili.
In questa accezione storica vengono impiegati nel presen–
te saggio.
135


















