
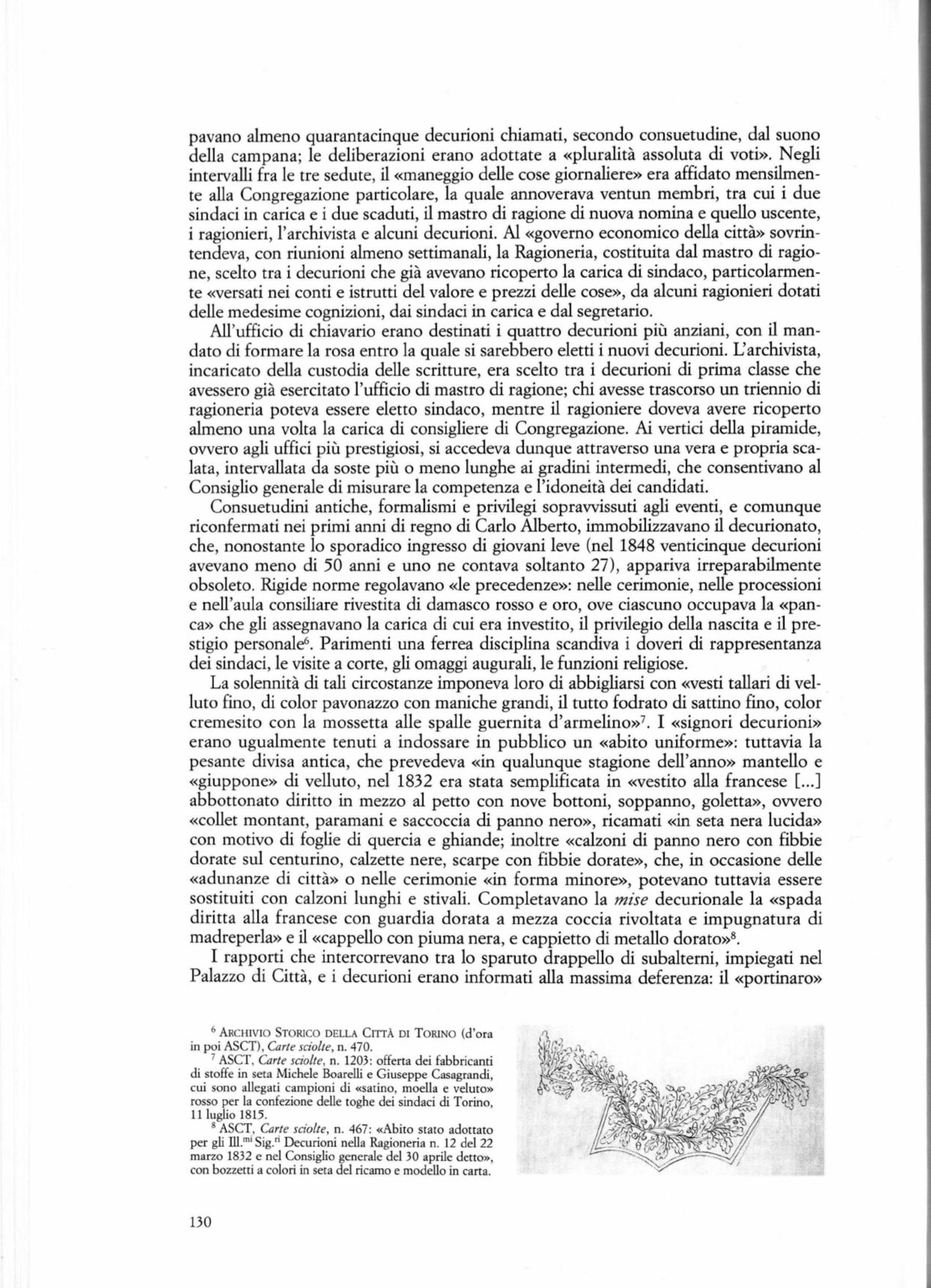
pavano almeno quarantacinque decurioni chiamati, secondo consuetudine, dal suono
della campana; le deliberazioni erano adottate a «pluralità assoluta di voti». Negli
intervalli fra le tre sedute, il «maneggio delle cose giornaliere» era affidato mensilmen–
te alla Congregazione particolare, la quale annoverava ventun membri, tra cui i due
sindaci in carica e i due scaduti, il mastro di ragione di nuova nomina e quello uscente,
i ragionieri, l'archivista e alcuni decurioni. Al «governo economico della città» sovrin–
tendeva, con riunioni almeno settimanali, la Ragioneria, costituita dal mastro di ragio–
ne, scelto tra i decurioni che già avevano ricoperto la carica di sindaco, particolarmen–
te «versati nei conti e istrutti del valore e prezzi delle cose», da alcuni ragionieri dotati
delle medesime cognizioni, dai sindaci in carica e dal segretario.
All'ufficio di chiavario erano destinati i quattro decurioni più anziani, con il man–
dato di formare la rosa entro la quale si sarebbero eletti i nuovi decurioni. L'archivista,
incaricato della custodia delle scritture, era scelto tra i decurioni di prima classe che
avessero già esercitato l'ufficio di mastro di ragione; chi avesse trascorso un triennio di
ragioneria poteva essere eletto sindaco, mentre il ragioniere doveva avere ricoperto
almeno una volta la carica di consigliere di Congregazione.
Ai
vertici della piramide,
ovvero agli uffici più prestigiosi, si accedeva dunque attraverso una vera e propria sca–
lata, intervallata da soste più o meno lunghe ai gradini intermedi, che consentivano al
Consiglio generale di misurare la competenza e l'idoneità dei candidati.
Consuetudini antiche, formalismi e privilegi sopravvissuti agli eventi, e comunque
riconfermati nei primi anni di regno di Carlo Alberto, immobilizzavano il decurionato,
che, nonostante lo sporadico ingresso di giovani leve (nel 1848 venticinque decurioni
avevano meno di 50 anni e uno ne contava soltanto
27),
appariva irreparabilmente
obsoleto. Rigide norme regolavano «le precedenze»: nelle cerimonie, nelle processioni
e nell'aula consiliare rivestita di damasco rosso e oro, ove ciascuno occupava la «pan–
ca» che gli assegnavano la carica di cui era investito, il privilegio della nascita e il pre–
stigio personalé. Parimenti una ferrea disciplina scandiva i doveri di rappresentanza
dei sindaci, le visite a corte, gli omaggi augurali, le funzioni religiose.
La solennità di tali circostanze imponeva loro di abbigliarsi con «vesti tallari di vel–
luto fino, di color pavonazzo con maniche grandi, il tutto fodrato di sattino fino, color
cremesito con la mossetta alle spalle guernita d' armelino»7. I «signori decurioni»
erano ugualmente tenuti a indossare in pubblico un «abito uniforme»: tuttavia la
pesante divisa antica, che prevedeva «in qualunque stagione dell' anno» mantello e
«giuppone» di velluto, nel 1832 era stata semplificata in «vestito alla francese [... ]
abbottonato diritto in mezzo al petto con nove bottoni, soppanno, goletta», ovvero
«collet montant, paramani e saccoccia di panno nero», ricamati «in seta nera lucida»
con motivo di foglie di quercia e ghiande; inoltre «calzoni di panno nero con fibbie
dorate sul centurino, calzette nere, scarpe con fibbie dorate», che, in occasione delle
«adunanze di città» o nelle cerimonie «in forma minore», potevano tuttavia essere
sostituiti con calzoni lunghi e stivali. Completavano la
mise
decurionale la «spada
diritta alla francese con guardia dorata a mezza coccia rivoltata e impugnatura di
madreperla» e il «cappello con piuma nera, e cappietto di metallo dorato»8.
I rapporti che intercorrevano tra lo sparuto drappello di subalterni, impiegati nel
Palazzo di Città, e i decurioni erano informati alla massima deferenza: il «portinaro»
6
ARCHIVIO STORICO
DELLA
CITTA
DI
TORINO (d'ora
in poi ASCT),
Carte sciolte,
n. 470.
7
ASCT,
Carte sciolte,
n. 1203: offerta dei fabbricanti
di stoffe in seta Michele Boarelli e Giuseppe Casagrandi,
cui sono allegati campioni di «satino, moella e veluto»
rosso per la confezione delle toghe dei sindaci di Torino,
Il luglio 1815.
8
ASCT,
Carte sciolte,
n. 467: «Abito stato adottato
per gli
Ill.miSig.
ri
Decurioni nella Ragioneria n. 12 del 22
marzo 1832 e nel Consiglio generale del 30 aprile detto»,
con bozzetti a colori in seta del ricamo e modello in carta.
130


















