
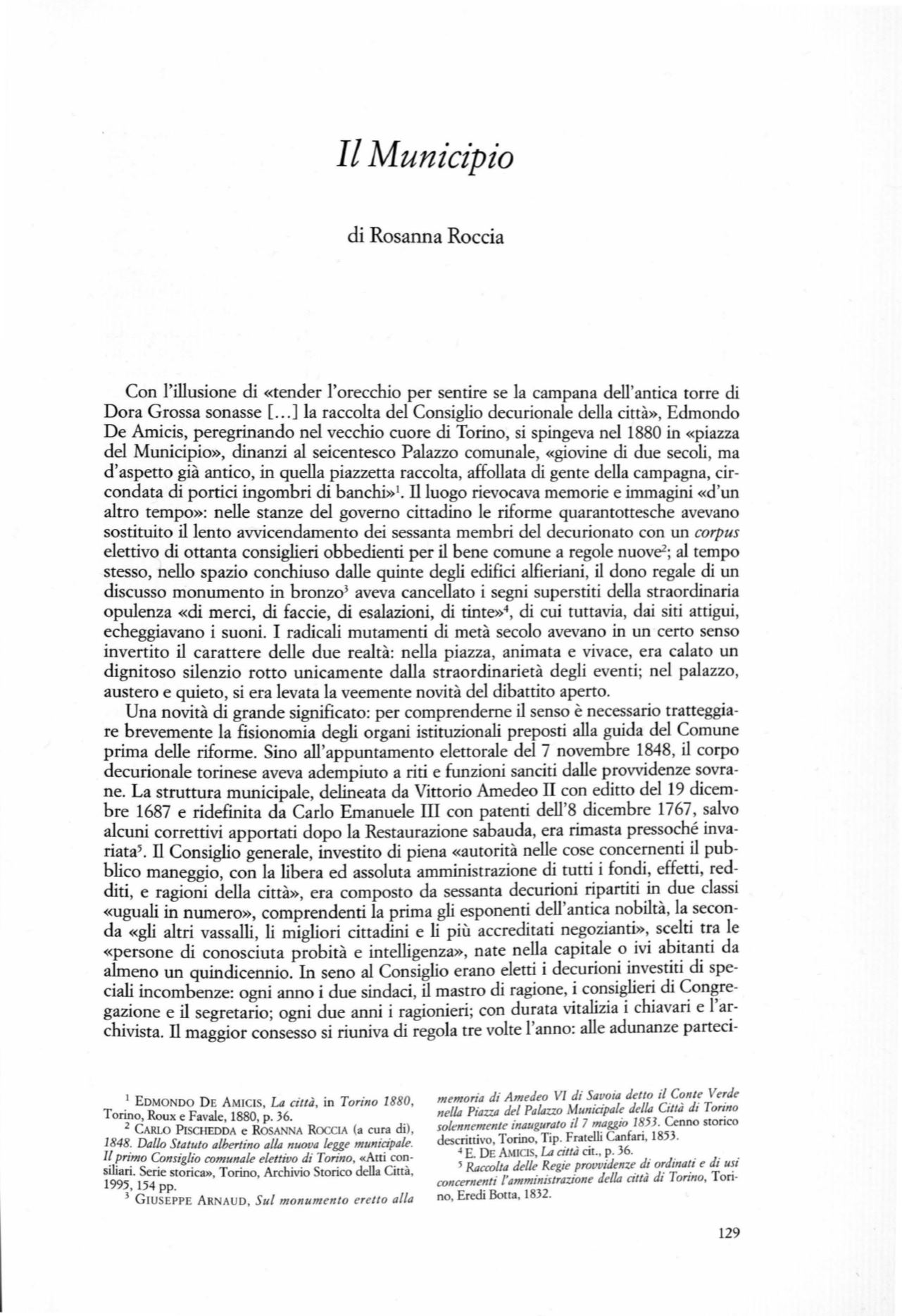
Il
Municipio
di Rosanna Roccia
Con l'illusione di «tender l'orecchio per sentire se la campana dell'antica torre di
Dora Grossa sonasse [... ] la raccolta del Consiglio decurionale della città», Edmondo
De Amicis, peregrinando nel vecchio cuore di Torino, si spingeva nel 1880 in «piazza
del Municipio», dinanzi al seicentesco Palazzo comunale, «giovine di due secoli, ma
d'aspetto già antico, in quella piazzetta raccolta, affollata di gente della campagna, cir–
condata di portici ingombri di banchi»!. Il luogo rievocava memorie e immagini «d'un
altro tempo»: nelle stanze del governo cittadino le riforme quarantottesche avevano
sostituito il lento avvicendamento dei sessanta membri del decurionato con un
corpus
elettivo di ottanta consiglieri obbedienti per il bene comune a regole nuove2; al tempo
stesso, nello spazio conchiuso dalle quinte degli edifici alfieriani, il dono regale di un
discusso monumento in bronzo
3
aveva cancellato i segni superstiti della straordinaria
opulenza «di merci, di faccie, di esalazioni, di tinte»4, di cui tuttavia, dai siti attigui,
echeggiavano i suoni. I radicali mutamenti di metà secolo avevano in un certo senso
invertito il carattere delle due realtà: nella piazza, animata e vivace, era calato un
dignitoso silenzio rotto unicamente dalla straordinarietà degli eventi; nel palazzo,
austero e quieto, si era levata la veemente novità del dibattito aperto.
Una novità di grande significato: per comprenderne il senso
è
necessario tratteggia–
re brevemente la fisionomia degli organi istituzionali preposti alla guida del Comune
prima delle riforme. Sino all'appuntamento elettorale del 7 novembre 1848, il corpo
decurionale torinese aveva adempiuto a riti e funzioni sanciti dalle provvidenze sovra–
ne. La struttura municipale, delineata da Vittorio Amedeo II con editto del 19 dicem–
bre 1687 e ridefinita da Carlo Emanuele III con patenti dell'8 dicembre 1767 , salvo
alcuni correttivi apportati dopo la Restaurazione sabauda, era rimasta pressoché inva–
riata
5 .
il
Consiglio generale, investito di piena «autorità nelle cose concernenti il pub–
blico maneggio, con la libera ed assoluta amministrazione di tutti i fondi, effetti, red–
diti, e ragioni della città», era composto da sessanta decurioni ripartiti in due classi
«uguali in numero», comprendenti la prima gli esponenti dell'antica nobiltà, la secon–
da «gli altri vassalli, li migliori cittadini e li più accreditati negozianti», scelti tra le
«persone di conosciuta probità e intelligenza», nate nella capitale o ivi abitanti da
almeno un quindicennio. In seno al Consiglio erano eletti i decurioni investiti di spe–
ciali incombenze: ogni anno i due sindaci, il mastro di ragione, i consiglieri di Congre–
gazione e il segretario; ogni due anni i ragionieri; con durata vitalizia i chiavari e
l'a~chivista.
il
maggior consesso si riuniva di regola tre volte l'anno: alle adunanze partecl-
l
EDMONDO D E AMICIS,
La città,
in
Torino 1880,
Torino, Roux e Favale, 1880, p. 36.
2
CARLO PISCHEDDA e ROSANNA ROCC!A (a cura di) ,
1848. Dallo Statuto albertino alla nuova legge municipale.
Il primo Consiglio comunale elettivo di Torino,
«Atti con–
siliari. Serie storica», Torino, Archivio Storico della Città,
1995, 154
pp.
3
GIUS EPPE ARNAUD,
Sul monumento eretto alla
memoria di Amedeo VI di Savoia detto
il
Conte Verde
nella Piazza del Palazzo Municipale della Città di Torino
solennemente inaugurato il
7
maggio
1853.
Cenno storico
descrittivo, Torino, Tip. Fratelli Canfari, 1853.
4
E. DE AMICIS,
La
città
cit.,
p.
36.
5
Raccolta delle Regie provvidenze di ordinati e di usi
concernenti l'amministrazione della città di Torino,
Tori–
no, Eredi Botta, 1832.
129


















