
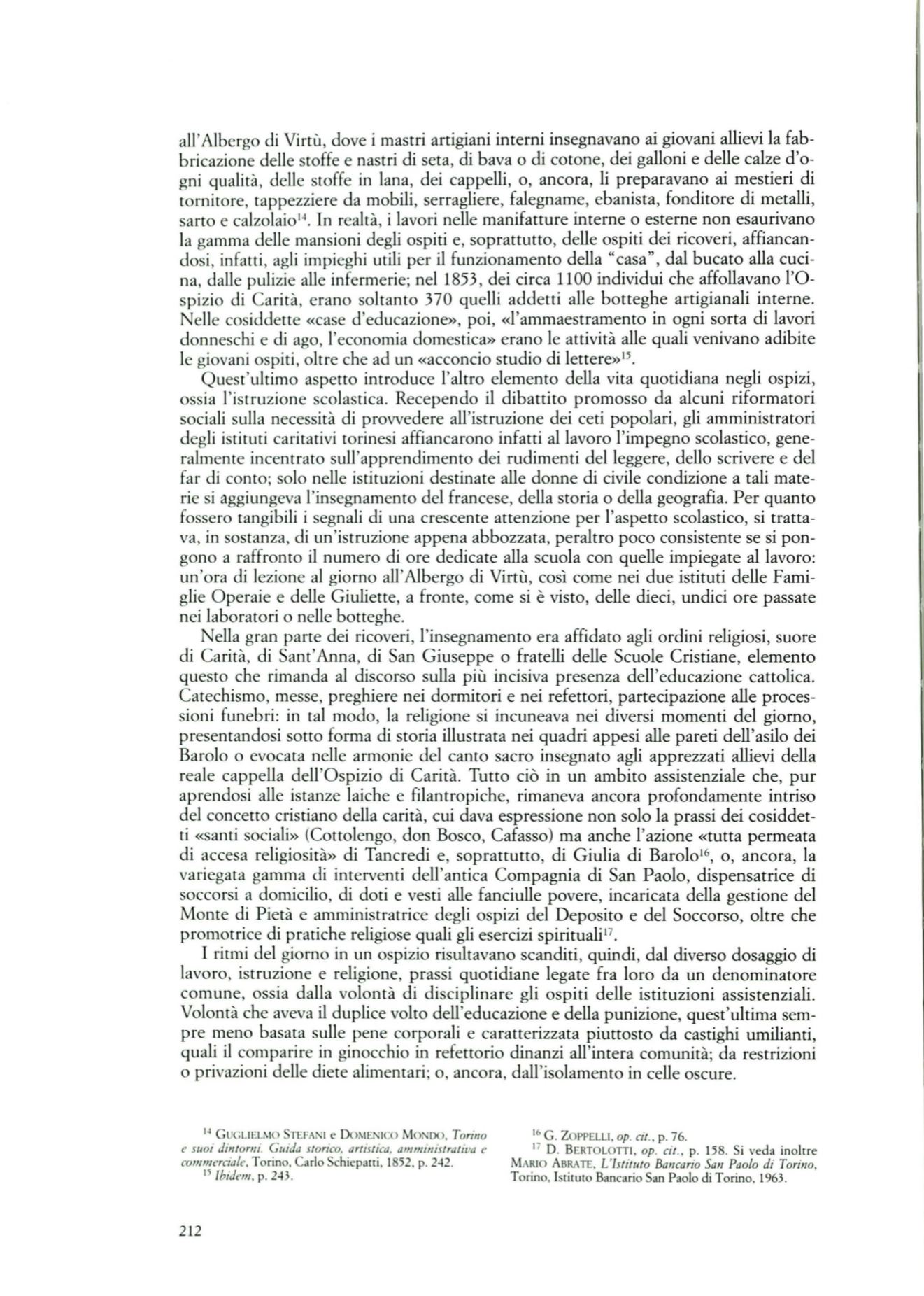
all' Albergo di Virtù, dove i mastri artigiani interni insegnavano ai giovani allievi
la
fab–
bricazione delle stoffe e nastri di seta, di bava o di cotone, dei galloni e delle calze d'o–
gni qualità, delle stoffe in lana, dei cappelli, o, ancora, li preparavano ai mestieri di
tornitore, tappezziere da mobili, serragliere, falegname, ebanista, fonditore di metalli,
sarto e calzolaio
' 4 .
In realtà, i lavori nelle manifatture interne o esterne non esaurivano
la gamma delle mansioni degli ospiti e, soprattutto, delle ospiti dei ricoveri, affiancan–
dosi, infatti, agli impieghi utili per il funzionamento della" casa", dal bucato alla cuci–
na , dalle pulizie alle infermerie; nel
1853,
dei circa 1100 individui che affollavano l'O–
spizio di Carità, erano soltanto 370 quelli addetti alle botteghe artigianali interne.
Nelle cosiddette «case d 'educazione», poi, «l'ammaestramento in ogni sorta di lavori
donneschi e di ago, l'economia domestica» erano le attività alle quali venivano adibite
le giovani ospiti , oltre che ad un «acconcio studio di lettere»'5.
Quest'ultimo aspetto introduce l'altro elemento della vita quotidiana negli ospizi,
ossia l'istruzione scolastica. Recependo
il
dibattito promosso da alcuni riformatori
sociali sulla necessità di prowedere all'istruzione dei ceti popolari, gli amministratori
degli istituti caritativi torinesi affiancarono infatti al lavoro l'impegno scolastico, gene–
ralmente incentrato sull 'apprendimento dei rudimenti del leggere, dello scrivere e del
far di conto; solo nelle istituzioni destinate alle donne di civile condizione a tali mate–
ri e si aggiungeva l'insegnamento del francese, della storia o della geografia. Per quanto
fossero tangibili i segnali di una crescente attenzione per l'aspetto scolastico, si tratta–
va , in sostanza, di un 'istruzione appena abbozzata, peraltro poco consistente se si pon–
gono a raffronto
il
numero di ore dedicate alla scuola con quelle impiegate al lavoro:
un 'ora di lezione al giorno all'Albergo di Virtù , cosÌ come nei due istituti delle Fami–
glie Operaie e delle Giuliette, a fronte , come si
è
visto, delle dieci, undici ore passate
nei laboratori o nelle botteghe.
Nella gran parte dei ricoveri, l'insegnamento era affidato agli ordini religiosi, suore
di Carità, di Sant'Anna , di San Giuseppe o fratelli delle Scuole Cristiane, elemento
questo che rimanda al discorso sulla più incisiva presenza dell 'educazione cattolica.
Catechismo, messe, preghiere nei dormitori e nei refettori, partecipazione alle proces–
sioni funebri: in tal modo, la religione si incuneava nei diversi momenti del giorno,
presentandosi sotto forma di storia illustrata nei quadri appesi alle pareti dell' asilo dei
Barolo o evocata nelle armonie del canto sacro insegnato agli apprezzati allievi della
reale cappella dell 'Ospizio di Carità. Tutto ciò in un ambito assistenziale che, pur
aprendosi alle istanze laiche e filantropiche, rimaneva ancora profondamente intriso
del concetto cristiano della carità , cui dava espressione non solo la prassi dei cosiddet–
ti «santi sociali» (Cottolengo, don Bosco, Cafasso) ma anche l'azione «tutta permeata
di accesa religiosità» di Tancredi e, soprattutto, di Giulia di Barolo
' 6 ,
o, ancora, la
variegata gamma di interventi dell'antica Compagnia di San Paolo, dispensatrice di
soccorsi a domicilio , di doti e vesti alle fanciulle povere, incaricata della gestione del
Monte di Pietà e amministratrice degli ospizi del Deposito e del Soccorso, oltre che
promotrice di pratiche religiose quali gli esercizi spirituali
'7 .
I ritmi del giorno in un ospizio risultavano scanditi, quindi, dal diverso dosaggio di
lavoro, istruzione e religione, prassi quotidiane legate fra loro da un denominatore
comune , ossia dalla volontà di disciplinare gli ospiti delle istituzioni assistenziali.
Volontà che aveva il duplice volto dell 'educazione e della punizione, quest 'ultima sem–
pre meno basata sulle pene corporali e caratterizzata piuttosto da castighi umilianti,
quali il comparire in ginocchio in refettorio dinanzi all 'intera comunità; da restrizioni
o privazioni delle diete alimentari ; o, ancora, dall'isolamento in celle oscure.
14
GUG Ll EL,\iIO STEFAN I e DOME ICO MONDO.
Torino
e SI/ai dinlorni. Cuida siorico, arlisliClI, amminislraliva e
commerciale.
Torino. Carlo Schiepatti . 1852, p. 242.
15
Ibidem,
p.
243.
212
16
G . ZOPPELLI ,
op. cii.•
p. 76.
l ì
D. BERTOLOTTI,
op. cit.,
p. 158. Si veda inoltre
MARIO ABRATE,
L'Istiluto Bancario San Paolo di Torino,
Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963.


















