
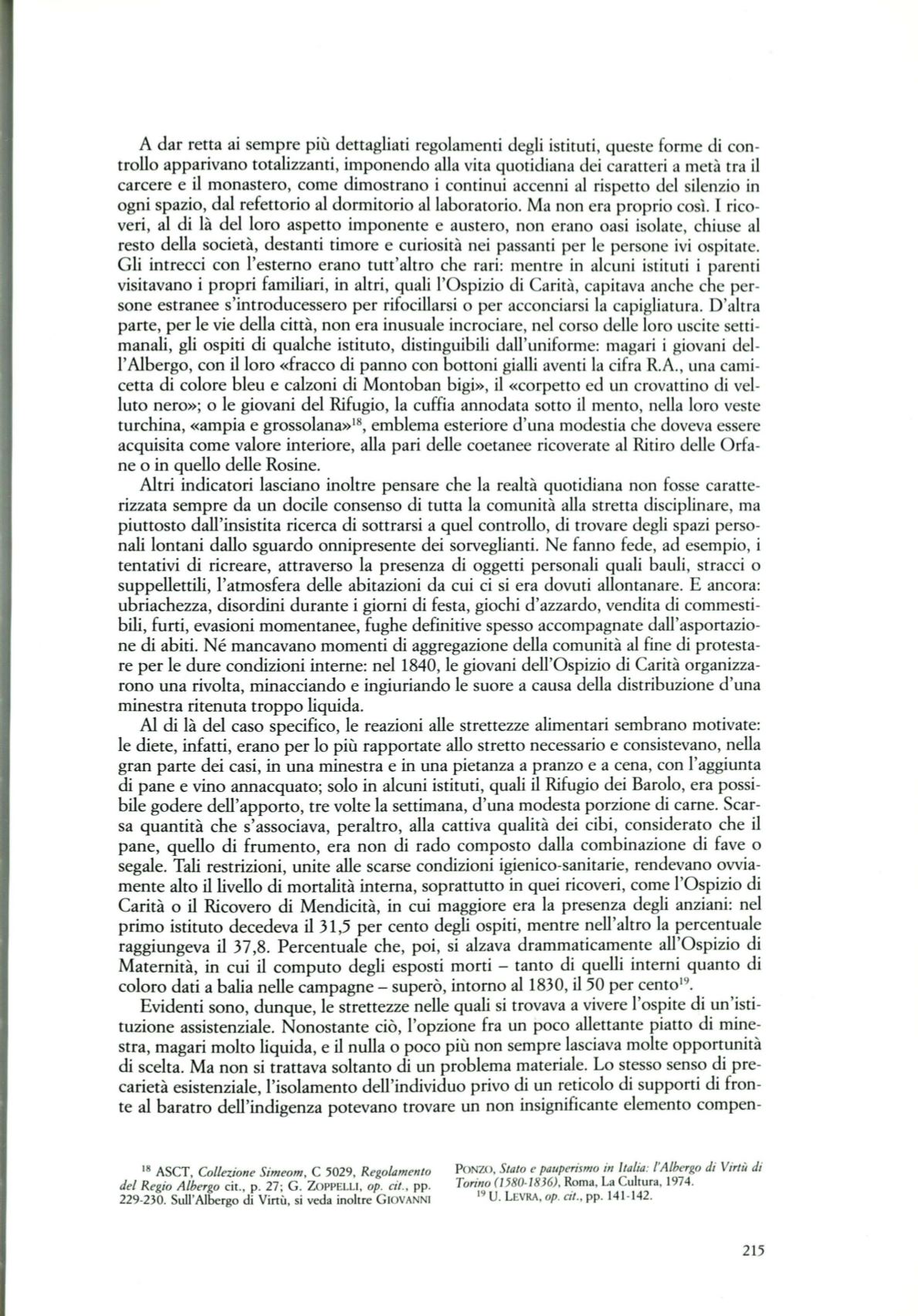
A dar retta ai sempre più dettagliati regolamenti degli istituti, queste forme di con–
trollo apparivano totalizzanti, imponendo alla vita quotidiana dei caratteri a metà tra
il
carcere e il monastero, come dimostrano i continui accenni al rispetto del silenzio in
ogni spazio, dal refettorio al dormitorio al laboratorio. Ma non era proprio così. I rico–
veri, al di là del loro aspetto imponente e austero, non erano oasi isolate, chiuse al
resto della società, destanti timore e curiosità nei passanti per le persone ivi ospitate.
Gli intrecci con l'esterno erano tutt' altro che rari: mentre in alcuni istituti i parenti
visitavano i propri familiari , in altri, quali l'Ospizio di Carità, capitava anche che per–
sone estranee s'introducessero per rifocillarsi o per acconciarsi la capigliatura. D'altra
parte, per le vie della città, non era inusuale incrociare, nel corso delle loro uscite setti –
manali, gli ospiti di qualche istituto, distinguibili dall 'uniforme: maga ri i giovani del –
l'Albergo, con il loro «fracco di panno con bottoni gialli aventi la cifra
RA. ,
una cami–
cetta di colore bleu e calzoni di Montoban bigi», il «corpetto ed un crovattino di vel–
luto nero»; o le giovani del Rifugio, la cuffia annodata sotto
il
mento, nella loro veste
turchina, «ampia e grossolana»18, emblema esteriore d 'una modestia che doveva essere
acquisita come valore interiore, alla pari delle coetanee ricoverate al Ritiro delle Orfa–
ne o in quello delle Rosine.
Altri indicatori lasciano inoltre pensare che la realtà quotidiana non fosse caratte–
rizzata sempre da un docile consenso di tutta la comunità alla stretta disciplinare, ma
piuttosto dall'insistita ricerca di sottrarsi a quel controllo, di trovare degli spazi perso–
nali lontani dallo sguardo onnipresente dei sorveglianti. Ne fanno fede, ad esempio, i
tentativi di ricreare, attraverso la presenza di oggetti personali quali bauli, stracci o
suppellettili, l'atmosfera delle abitazioni da cui ci si era dovuti allontanare. E ancora:
ubriachezza, disordini durante i giorni di festa, giochi d'azzardo, vendita di commesti–
bili, furti, evasioni momentanee, fughe definitive spesso accompagnate dall 'asportazio–
ne di abiti. Né mancavano momenti di aggregazione della comunità al fine di protesta–
re per le dure condizioni interne: nel 1840, le giovani dell'Ospizio di Carità organizza–
rono una rivolta, minacciando e ingiuriando le suore a causa della distribuzione d 'una
minestra ritenuta troppo liquida.
Al di là del caso specifico, le reazioni alle strettezze alimentari sembrano motivate:
le diete, infatti, erano per lo più rapportate allo stretto necessario e consistevano, nella
gran parte dei casi, in una minestra e in una pietanza a pranzo e a cena, con l'aggiunta
di pane e vino annacquato; solo in alcuni istituti, quali
il
Rifugio dei Barolo, era possi–
bile godere dell'apporto, tre volte la settimana, d 'una modesta porzione di carne. Scar–
sa quantità che s'associava, peraltro, alla cattiva qualità dei cibi, considerato che il
pane, quello di frumento , era non di rado composto dalla combinazione di fave o
segale. Tali restrizioni, unite alle scarse condizioni igienico-sanitarie, rendevano ovvia–
mente alto il livello di mortalità interna, soprattutto in quei ricoveri, come l'Ospizio di
Carità o il Ricovero di Mendicità, in cui maggiore era la presenza degli anziani: nel
primo istituto decedeva il 31,5 per cento degli ospiti, mentre nell 'altro la percentuale
raggiungeva il 37,8. Percentuale che, poi, si alzava drammaticamente all'Ospizio di
Maternità, in cui il computo degli esposti morti - tanto di quelli interni quanto di
coloro dati a balia nelle campagne - superò, intorno al 1830,
il
50 per cento
l9
•
Evidenti sono, dunque, le strettezze nelle quali si trovava a vivere l'ospite di un'isti–
tuzione assistenziale. Nonostante ciò, l'opzione fra un poco allettante piatto di mine–
stra, magari molto liquida, e il nulla o poco più non sempre lasciava molte opportunità
di scelta. Ma non si trattava soltanto di un problema materiale. Lo stesso senso di pre–
carietà esistenziale, l'isolamento dell'individuo privo di un reticolo di supporti di fron–
te al baratro dell'indigenza potevano trovare un non insignificante elemento compen-
18
ASCT,
Collezione Simeom,
C
5029,
Regolamento
del Regio Albergo
cit.,
p.
27; G.
ZOPPELLl,
op.
ciI.,
pp.
229-230.
Sull'Albergo di Virtù, si veda inoltre
GIOVANNI
PONZO,
Stato e pauperismo in Italia: l'Albergo di Virtù di
Torino (1 580- 1836),
Roma, La Cultura, 1974.
19
U.
L EVRA,
op.
cit. ,
pp. 141 -142.
215


















