
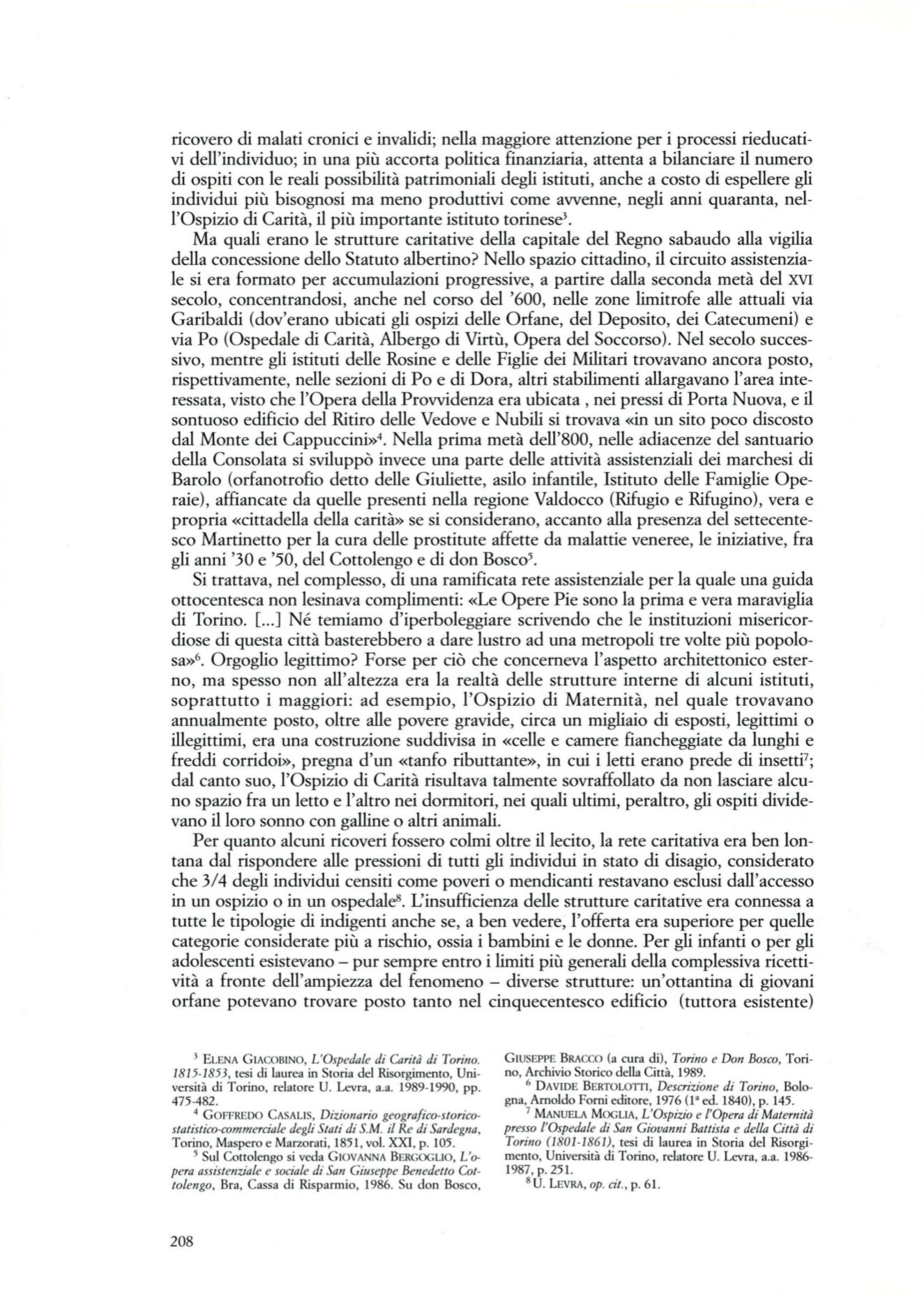
ricovero di malati cronici e invalidi; nella maggiore attenzione per i processi rieducati–
vi dell'individuo; in una più accorta politica finanziaria, attenta a bilanciare il numero
di ospiti con le reali possibilità patrimoniali degli istituti, anche a costo di espellere gli
individui più bisognosi ma meno produttivi come avvenne, negli anni quaranta, nel–
l'Ospizio di Carità, il più importante istituto torinese
3 •
Ma quali erano le strutture caritative della capitale del Regno sabaudo alla vigilia
della concessione dello Statuto albertino? Nello spazio cittadino, il circuito assistenzia–
le si era formato per accumulazioni progressive, a partire dalla seconda metà del
XVI
secolo, concentrandosi, anche nel corso del '600, nelle zone limitrofe alle attuali via
Garibaldi (dov'erano ubicati gli ospizi delle Orfane, del Deposito, dei Catecumeni) e
via Po (Ospedale di Carità, Albergo di Virtù, Opera del Soccorso). Nel secolo succes–
sivo, mentre gli istituti delle Rosine e delle Figlie dei Militari trovavano ancora posto,
rispettivamente, nelle sezioni di Po e di Dora, altri stabilimenti allargavano l'area inte–
ressata, visto che l'Opera della Provvidenza era ubicata , nei pressi di Porta Nuova, e il
sontuoso edificio del Ritiro delle Vedove e Nubili si trovava «in un sito poco discosto
dal Monte dei Cappuccini»4. Nella prima metà dell'800, nelle adiacenze del santuario
della Consolata si sviluppò invece una parte delle attività assistenziali dei marchesi di
Barolo (orfanotrofio detto delle Giuliette, asilo infantile, Istituto delle Famiglie Ope–
raie), affiancate da quelle presenti nella regione Valdocco (Rifugio e Rifugino) , vera e
propria «cittadella della carità» se si considerano, accanto alla presenza del settecente–
sco Martinetto per la cura delle prostitute affette da malattie veneree, le iniziative, fra
gli anni '30 e '50, del Cottolengo e di don Bosc0
5 .
Si trattava, nel complesso, di una ramificata rete assistenziale per la quale una guida
ottocentesca non lesinava complimenti: «Le Opere Pie sono la prima e vera maraviglia
di Torino. [.. .] Né temiamo d'iperboleggiare scrivendo che le instituzioni misericor–
diose di questa città basterebbero a dare lustro ad una metropoli tre volte più popolo–
sa»6. Orgoglio legittimo? Forse per ciò che concerneva l'aspetto architettonico ester–
no , ma spesso non all' altezza era la realtà delle strutture interne di alcuni istituti,
soprattutto i maggiori: ad esempio, l'Ospizio di Maternità, nel quale trovavano
annualmente posto, oltre alle povere gravide, circa un migliaio di esposti, legittimi o
illegittimi, era una costruzione suddivisa in «celle e camere fiancheggiate da lunghi e
freddi corridoi», pregna d'un «tanfo ributtante», in cui i letti erano prede di insetti
7 ;
dal canto suo, l'Ospizio di Carità risultava talmente sovraffollato da non lasciare alcu–
no spazio fra un letto e l'altro nei dormitori, nei quali ultimi, peraltro, gli ospiti divide–
vano il loro sonno con galline o altri animali.
Per quanto alcuni ricoveri fossero colmi oltre illecito, la rete caritativa era ben lon–
tana dal rispondere alle pressioni di tutti gli individui in stato di disagio, considerato
che 3/4 degli individui censiti come poveri o mendicanti restavano esclusi dall'accesso
in un ospizio o in un ospedale8. L'insufficienza delle strutture caritative era connessa a
tutte le tipologie di indigenti anche se, a ben vedere, l'offerta era superiore per quelle
categorie considerate più a rischio, ossia i bambini e le donne. Per gli infanti o per gli
adolescenti esistevano - pur sempre entro i limiti più generali della complessiva ricetti–
vità a fronte dell'ampiezza del fenomeno - diverse strutture: un'ottantina di giovani
orfane potevano trovare posto tanto nel cinquecentesco edificio (tuttora esistente)
3
ELENA GIACOBINO,
L 'Ospedale di Carità di Torino.
1815-1853, tesi di laurea in Storia del Risorgimento, Uni–
versità di Torino, relatore U. Levra, a.a. 1989-1990, pp.
475-482.
4
GOFFREDO CASALIS,
Dizionario geografico-storico–
statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna,
Torino, Maspero e Marzorati, 185 1, voI. XXI, p. 105.
5
Sul Cottolengo si veda G IOVANNA BERGOGLIO,
L'o–
pera assistenziale e sociale di San Giuseppe Benedetto Cot–
tolengo,
Bra, Cassa di Risparmio, 1986. Su don Bosco,
208
G IUSEPPE BRACCO (a cura di),
Torino e Don Bosco,
Tori–
no, Archivio Storico della Città, 1989.
6
DAVIDE BERTOLOlTl,
Descrizione di Torino,
Bolo–
gna, Arnoldo Forni editore, 1976
(l
a
ed. 1840), p . 145.
7
MANUELA MOGLIA,
L'Ospizio e l'Opera di Maternità
presso l'Ospedale di San Giovanni Battista e della Città di
Torino (1 801-186 1),
tesi di laurea in Storia del Risorgi–
mento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 1986-
1987, p. 251.
8
U. LEVRA,
op. cit.,
p. 61.


















